
La croce sulla tomba di Bob Kennedy nel cimitero di Arlington
Il liberalismo ha una teologia segreta per spiegare il male
Il sistema che ha marginalizzato Dio è il proseguimento laico della disputa fra Pelagio e Agostino su libertà e peccato. Un’interpretazione alternativa di Rawls
Il libro di Eric Nelson The Theology of Liberalism (Harvard University Press/Belknap) contiene una notizia sconvolgente già dal titolo, perché a rigore il liberalismo non dovrebbe avere alcuna teologia. Esistono certamente scuole teologiche, nell’ambito di diverse confessioni, che sono più o meno compatibili con la sensibilità veicolata dal liberalismo, ma dire che il discorso liberale è costruito su un’ossatura teologica è tutta un’altra cosa, una specie di bestemmia secolarizzata in una chiesa riconsacrata al laicismo.
La faccenda si complica, come spesso accade, passando dalla copertina alle pagine del libro, dove si scopre che è innanzitutto un testo su John Rawls, che del liberalismo contemporaneo è stato il rifondatore, ma è anche stato un intellettuale di inclinazione particolarmente irreligiosa, e il fatto è probabilmente dovuto alla fede che ha praticato con zelo negli anni giovanili e dalla quale si è poi allontanato dopo una profonda crisi. Studiava per diventare prete episcopaliano, Rawls, poi ha abbandonato il proposito e con questo ogni simpatia per il fenomeno religioso, trattato con sufficienza o ostilità, e ancora più spesso ignorato, nella parte fondamentale della sua possente opera, che ha come pilastri Una teoria della giustizia (Feltrinelli, 1971) e Liberalismo politico (Einaudi, 1993).
Nelson dice al Foglio che Rawls si è premurato di “coprire le tracce degli entusiasmi religiosi della gioventù”, ma qualcosa dell’homo religiosus che era in lui è rimasto impigliato nelle sue laiche riflessioni, e questo qualcosa è l’oggetto dell’indagine del giovane storico di Harvard. La pubblicazione della tesi di baccalaureato di Rawls a Princeton, modestamente intitolata Una breve indagine sul significato del peccato e della fede, e l’apertura degli archivi rawlsiani dove sono conservate milioni di pagine inedite (scriveva in modo compulsivo: annotava a margine molti dei libri che leggeva, le note erano talmente tante che poi doveva compilare un indice delle note) hanno rilanciato la riflessione sulla sua versione del liberalismo e sul liberalismo in generale, idea che in questo periodo storico è sotto processo con un numero notevole di capi di imputazione.
Un libro sulla teodicea per illuminare la crisi di oggi
Chi è Eric Nelson, lo storico di Harvard che ribalta un presupposto della modernità liberale
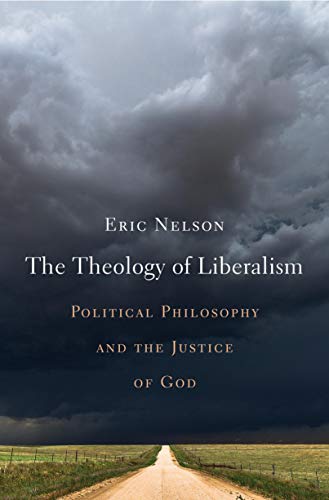 Eric Nelson è uno dei più brillanti storici del pensiero politico in circolazione, specializzato nei dibattiti che hanno dato origine alla modernità e nei riflessi che questi hanno gettato sulla teoria politica contemporanea. 42 anni, professore ad Harvard, dove si è laureato, ha conseguito il dottorato all’università di Cambridge sotto la supervisione di un gigante della storia delle idee come Quentin Skinner, e fra le altre cose si è occupato dell’influsso del pensiero greco sulla scuola repubblicana, del rapporto fra le idee monarchiche e la fondazione degli Stati Uniti e ha editato e commentato le traduzioni dell’Iliade di Thomas Hobbes. Una delle peculiarità della riflessione di Nelson è il tentativo di rinvenire la dimensione religiosa che ha animato la riflessione politica della modernità, scavando negli strati della secolarizzazione per restaurarne la centralità misconosciuta. Si potrebbe dire che è un’opera di “allargamento della ragione”, per usare una vecchia espressione ratzingeriana che non è mai andata di moda, e che perciò è sempre attuale. Finora Nelson si è concentrato soprattutto sul pensiero ebraico, ma nel suo ultimo libro The Theology of Liberalism: Political Philosophy and the Justice of God (da poco pubblicato in America per Harvard University Press/Belknap) esplora una disputa che si è svolta soprattutto nel perimetro della cristianità, quella sulla teodicea, ovvero la coesistenza del male e della perfetta e infinita bontà di Dio. La questione, iniziata con la disfida fra Agostino e Pelagio, complica il nodo fra libertà, grazia e peccato che sarà al centro della riforma protestante, poi trasferita sul piano del disincanto e della secolarizzazione. Secondo Nelson, però, la faccenda è semplicemente inabissata, non risolta, e riaffiora in superficie con John Rawls, il rifondatore del liberalismo contemporaneo. Anni fa il professore è stato invitato a un simposio informale nel quale uno dei suoi colleghi ha proposto ai presenti di leggere insieme la tesi di laurea da poco pubblicata del grande intellettuale americano. L’idea di affrontare anche le esternazioni giovanili di un autore di cui aveva masticato migliaia e migliaia di pagine non era elettrizzante, per usare un eufemismo. E invece in quel testo era nascosto un tesoro prezioso: la testimonianza che Rawls abbracciava un’impostazione agostiniana del problema umano, dunque in contrasto con la base neo-pelagiana che accomunava i padri fondatori del pensiero liberale, all’alba della modernità. Ne consegue che il filosofo più influente nel ridefinire il perimetro del liberalismo di oggi aveva un debito ancora non saldato con una concezione che a parole sconfessava e malediva, assecondato dai suoi critici, ansiosi di cancellare le tracce dell’agostinismo latente. Questa contraddizione è il “Pensiero dominante” di questa settimana, e nell’intervista pubblicata in questa pagina Nelson spiega i termini fondamentali di un’interpretazione che rovescia diversi luoghi comuni su liberalismo e secolarizzazione.
Eric Nelson è uno dei più brillanti storici del pensiero politico in circolazione, specializzato nei dibattiti che hanno dato origine alla modernità e nei riflessi che questi hanno gettato sulla teoria politica contemporanea. 42 anni, professore ad Harvard, dove si è laureato, ha conseguito il dottorato all’università di Cambridge sotto la supervisione di un gigante della storia delle idee come Quentin Skinner, e fra le altre cose si è occupato dell’influsso del pensiero greco sulla scuola repubblicana, del rapporto fra le idee monarchiche e la fondazione degli Stati Uniti e ha editato e commentato le traduzioni dell’Iliade di Thomas Hobbes. Una delle peculiarità della riflessione di Nelson è il tentativo di rinvenire la dimensione religiosa che ha animato la riflessione politica della modernità, scavando negli strati della secolarizzazione per restaurarne la centralità misconosciuta. Si potrebbe dire che è un’opera di “allargamento della ragione”, per usare una vecchia espressione ratzingeriana che non è mai andata di moda, e che perciò è sempre attuale. Finora Nelson si è concentrato soprattutto sul pensiero ebraico, ma nel suo ultimo libro The Theology of Liberalism: Political Philosophy and the Justice of God (da poco pubblicato in America per Harvard University Press/Belknap) esplora una disputa che si è svolta soprattutto nel perimetro della cristianità, quella sulla teodicea, ovvero la coesistenza del male e della perfetta e infinita bontà di Dio. La questione, iniziata con la disfida fra Agostino e Pelagio, complica il nodo fra libertà, grazia e peccato che sarà al centro della riforma protestante, poi trasferita sul piano del disincanto e della secolarizzazione. Secondo Nelson, però, la faccenda è semplicemente inabissata, non risolta, e riaffiora in superficie con John Rawls, il rifondatore del liberalismo contemporaneo. Anni fa il professore è stato invitato a un simposio informale nel quale uno dei suoi colleghi ha proposto ai presenti di leggere insieme la tesi di laurea da poco pubblicata del grande intellettuale americano. L’idea di affrontare anche le esternazioni giovanili di un autore di cui aveva masticato migliaia e migliaia di pagine non era elettrizzante, per usare un eufemismo. E invece in quel testo era nascosto un tesoro prezioso: la testimonianza che Rawls abbracciava un’impostazione agostiniana del problema umano, dunque in contrasto con la base neo-pelagiana che accomunava i padri fondatori del pensiero liberale, all’alba della modernità. Ne consegue che il filosofo più influente nel ridefinire il perimetro del liberalismo di oggi aveva un debito ancora non saldato con una concezione che a parole sconfessava e malediva, assecondato dai suoi critici, ansiosi di cancellare le tracce dell’agostinismo latente. Questa contraddizione è il “Pensiero dominante” di questa settimana, e nell’intervista pubblicata in questa pagina Nelson spiega i termini fondamentali di un’interpretazione che rovescia diversi luoghi comuni su liberalismo e secolarizzazione.
La tesi di Nelson è che il liberalismo è nato come tentativo secolarizzato di risolvere il problema della teodicea – la coesistenza fra un Dio onnipotente, perfettamente buono, e il male – questione che per secoli ha infiammato il dibattito nel mondo cristiano, determinando eresie, scomuniche e scismi attorno al nodo della grazia e della libertà. In altre parole, il liberalismo ripropone i termini di una disputa essenzialmente teologica per capire la quale occorre tornare alla disfida fra Agostino e Pelagio attorno al IV secolo.
Il monaco britannico (o meglio, i suoi seguaci: di Pelagio sappiamo pochissimo) tenta di risolvere il problema del male nel mondo – e dell’inferno – e dell’esistenza di un Dio infinitamente buono essenzialmente appellandosi alla libertà umana. L’uomo può scegliere di essere buono. Per Agostino si trattava di un errore gravissimo, perché una libertà umana perfetta, che realizza il bene semplicemente aderendovi con un atto della volontà, rende inutile l’incarnazione e il sacrificio di Cristo per la salvezza dell’uomo, che potrebbe a quel punto salvarsi da sé. Per rispondere all’eresia pelagiana, Agostino ha rielaborato la dottrina del peccato originale già affrontata dai primi padri della chiesa, insistendo sull’imperfezione della libertà umana e l’impossibilità di ottenere la salvezza tramite i propri meriti, idee che poi verranno riprese e radicalizzate dall’agostiniano Martin Lutero con la formulazione del “servo arbitrio”.
Nelson sostiene che in fondo il liberalismo non si è mai allontanato da questa disputa, e l’ha riproposta tentando una cesura degli elementi teologici. “I pensatori proto-liberali come Locke e Kant – spiega Nelson al Foglio – sono tutti pelagiani, nel senso che il loro programma intellettuale si poggia sulla perfezione della libertà umana. Rawls, che ha fissato i termini del liberalismo contemporaneo, ha invece una posizione agostiniana, anche se poi lui stesso e i suoi esegeti hanno cercato di nasconderla. Per anni ho detto ai miei studenti, scherzando, che Rawls propone un ‘agostinismo secolarizzato’, perché la sua idea dell’uomo è imperniata su una libertà imperfetta e pervasa dal senso del peccato originale come tratto indelebile della condizione umana; dopo aver letto la sua tesi di laurea, che è ancora imbevuta dei precetti neo-ortodossi che aveva studiato a lungo, ho capito che non era uno scherzo. Leggerla è stata, scusate il gioco di parole, una rivelazione: si tratta del primo liberale anti-pelagiano della modernità”.
Ma come si può conciliare la fiducia nelle perfettibili virtù della libertà umana, cuore del progetto liberale moderno, con la visione di un uomo macchiato da un’incapacità di determinarsi e bisognoso della grazia per compiersi? “La risposta è semplice: non si conciliano”, dice Nelson, che vede nella contraddizione di Rawls una chiave per rileggere non solo la sua opera ma l’intero dibattito liberale contemporaneo. “La sua teoria della persona, l’idea della giustizia distributiva e il suo attacco alla possibilità del merito hanno un chiaro debito agostiniano. Non solo: la sua idea fondamentale, quella del ‘difference principle’, secondo cui le disuguaglianze nella distribuzione dei beni sono accettabili soltanto nella misura in cui migliorano le condizioni di vita degli ultimi nella società, è il retaggio di una mentalità anti-pelagiana, e perciò il processo di riconciliazione con un apparato di idee essenzialmente pelagiano non gli riesce. Il liberalismo di Rawls è pieno di asimmetrie che lui stesso ha cercato di correggere e aggirare. Il fatto è che pensava e scriveva come se credesse ancora in valori che formalmente rifiutava”.
Per Nelson negli anni Settanta del secolo scorso il dibattito sul liberalismo ha preso una “via sbagliata”, negando le sue radici teologiche, e il suo libro è un primo tentativo di correggere questo errore di prospettiva. Di certo, nota l’autore, “è innegabile che il dibattito intellettuale degli anni Settanta sia stato caratterizzato da una profonda ostilità verso la religione, era l’ethos del tempo, e si è fatto di tutto per cancellare le tracce teologiche da un progetto che doveva essere puramente secolarizzato”.
E’ interessante tuttavia notare anche che alcuni dei protagonisti di quel dibattito, lontanissimi da posizioni religiose, più tardi si sono avvicinati a temi teologici, ad esempio Ronald Dworkin o Hilary Putnam. Alla luce dell’interpretazione di Nelson, non si tratta di un percorso bizzarro. Anzi, è piuttosto la conseguenza del ritorno a una chiave ermeneutica, proposta fra gli altri da Carl Schmitt, secondo cui le grandi questioni della modernità altro non sono che problemi religiosi secolarizzati. “In questa visione – conclude Nelson – la secolarizzazione non è un processo di erosione della religione, ma è la religione che semplicemente si inabissa sotto la superficie dei dibattiti”. E a volte riemerge in superficie.





