
Aleksandr Solženicyn nel 1974
La distruzione del mito di Stalin
Nel “Primo cerchio” Solženicyn fa un brutale affresco dell’Unione Sovietica e dell’enigma di un’enorme nazione che resta sveglia perché il suo sovrano non riesce a dormire. Cinquant’anni dopo, questo libro colpisce un bersaglio molto più ampio, che ci riguarda
Pubblichiamo la postfazione di Anna Zafesova a “Nel primo cerchio”, la prima versione non purgata – non “spennata”, come dice l’autore – del romanzo di Aleksandr Solženicyn, che esce per la prima volta in Italia edito da Voland.
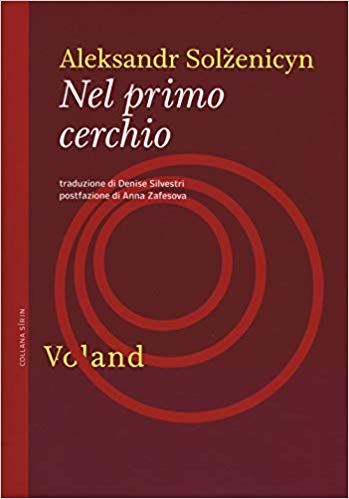 Anni fa, durante una lunga discussione notturna, di quelle che l’intelligencija, non solo russa, conduce ancora per cercare di capire la tragedia del comunismo sovietico, dissi a mio marito che per comprendere i meccanismi della dittatura doveva leggere i capitoli dedicati a Stalin di “Nel primo cerchio” di Aleksandr Solženicyn. Il mattino dopo – Amazon non era ancora sbarcato in Italia – eravamo in una grande libreria del centro di Milano, convinti di trovare uno dei più grandi romanzi del Novecento in cinque minuti, un po’ come si entra al supermercato sicuri di trovare il latte o il pane. Ma il romanzo non c’era negli scaffali della narrativa straniera e nemmeno in altri reparti. Il gentile giovane commesso, dopo aver consultato i cataloghi, ci disse che era ormai fuori stampa, guardandoci con educato stupore: a me era sembrato di chiedere il pane, qualcosa di ovvio, un classico che non poteva non esserci, a lui eravamo apparsi come due personaggi bizzarri, in cerca di una rarità stravagante.
Anni fa, durante una lunga discussione notturna, di quelle che l’intelligencija, non solo russa, conduce ancora per cercare di capire la tragedia del comunismo sovietico, dissi a mio marito che per comprendere i meccanismi della dittatura doveva leggere i capitoli dedicati a Stalin di “Nel primo cerchio” di Aleksandr Solženicyn. Il mattino dopo – Amazon non era ancora sbarcato in Italia – eravamo in una grande libreria del centro di Milano, convinti di trovare uno dei più grandi romanzi del Novecento in cinque minuti, un po’ come si entra al supermercato sicuri di trovare il latte o il pane. Ma il romanzo non c’era negli scaffali della narrativa straniera e nemmeno in altri reparti. Il gentile giovane commesso, dopo aver consultato i cataloghi, ci disse che era ormai fuori stampa, guardandoci con educato stupore: a me era sembrato di chiedere il pane, qualcosa di ovvio, un classico che non poteva non esserci, a lui eravamo apparsi come due personaggi bizzarri, in cerca di una rarità stravagante.
Non sapevo in quella mattina che, se avessimo scovato il libro, la delusione sarebbe stata ancora maggiore: dalla prima traduzione, uscita con la Mondadori nel 1968, in poi in Italia veniva pubblicata la versione “light” del romanzo, quella “spennata”, come la definisce lo stesso Solženicyn nella prefazione, che lo scrittore cercò di rendere adatta a superare la censura sovietica, “perché godesse almeno di una flebile vita”. Non ci riuscì, ma fu proprio questa stesura a finire nel tamizdat e nel samizdat, a venire pubblicata in occidente, a circolare clandestinamente in Unione Sovietica, e a meritare allo scrittore il Nobel. A venire sacrificati per primi furono, ovviamente, proprio i capitoli su Stalin, e altri passaggi cruciali ma troppo taglienti, per un totale di nove capitoli. Inoltre, la molla stessa del plot, la motivazione della telefonata di Volodin all’ambasciata americana, venne resa più innocente: invece di cercare di impedire ai sovietici di ottenere la bomba atomica, voleva soltanto mettere in guardia un medico che ebbe in cura sua madre dai contatti con i colleghi stranieri, quindi invece di salvare il mondo – e tradire il suo paese – desiderava solo proteggere un innocente verso il quale aveva un debito di gratitudine. Una trama più “privata”, che rendeva Volodin più vittima – è evidente che la sua azione sarebbe stata considerata un tradimento sotto qualunque regime – ma toglieva drammaticità al dilemma morale dei principali protagonisti del romanzo, rendendone sfasati e sfocati i tormenti. E’ stata però questa versione a entrare nella memoria di una generazione di lettori russi e occidentali: la stesura integrale, “ricostruita” dall’autore nel 1968 e tornata ad avere 96 capitoli invece di 87, venne pubblicata in russo solo nel 1990, nella prima edizione legale in patria, e in inglese nel 2009. Quando nel 2006 la televisione russa trasmise una fiction tratta dalla versione integrale del romanzo, milioni di russi provarono delusione e rabbia: “Da un brav’uomo il protagonista diventa traditore!”, era il leit-motiv di numerose proteste di critici e spettatori, che pure avevano rischiato se non la vita, la libertà e la carriera, per leggere illegalmente il romanzo mutilato trent’anni prima.
Ma questo è il destino dell’opera di Solženicyn, di emergere “da sotto i macigni”, per citare il titolo di una sua raccolta di saggi. Un romanzo concepito nel 1945-1953, durante la sua prigionia nel gulag, scritto nel 1955-58, modificato nel 1964, ricostruito nel 1968, e che arriva al lettore italiano mezzo secolo dopo la prima traduzione. E si presenta in tutta la sua grandezza da cattedrale, alla quale lo paragonò Heinrich Böll, una cattedrale di romanzo, con arcate, volte, travi a sorreggersi in un insieme imponente e leggiadro allo stesso tempo, tenuto insieme in una tensione perfetta da migliaia di mattonelle, ciascuna incisa con un dettaglio diverso, microscopico e preciso. Come una cattedrale gotica, la sua pianta è subordinata a un rigido precetto teologico, e ogni piccola parte è funzionale a comporne il maestoso insieme, e nello stesso tempo è un prezioso piccolo capolavoro. Della cattedrale possiede il respiro della navata – il panorama multidimensionale della Russia staliniana, dalle campagne desolate ai salotti della borghesia rossa, e dalle segrete del gulag ai teatri moscoviti – e la vertiginosa guglia dei capitoli su Stalin, ma anche la moltitudine di angoli reconditi, cappelle, affreschi, statue che emergono dall’oscurità, composti da singole storie, scene, personaggi, in un quadro corale che, proseguendo la metafora architettonica, ricorda nella ricchezza e terribile nitidezza un gigantesco Giudizio universale a tutta parete.
Le vittime producono nuove vittime, i prigionieri e i carcerieri possono scambiarsi di posto in qualunque momento, e sono accomunati dalla stessa mancanza di libertà, in un paese dove tutti vivono in prigione, dal capo supremo ai carnefici: nessuno può uscirne, nessuno può permettersi il lusso di non avere paura
Tutti i raffigurati in questo affresco finiscono dannati, in una Russia ovviamente paragonata all’inferno fin dalla copertina: il titolo del romanzo “Nel primo cerchio” contiene un’allusione a Dante e alla Commedia più che trasparente anche nel testo, quando uno dei protagonisti spiega il cerchio “di lusso” dove il poeta aveva collocato i filosofi dell’antichità classica, e di nuovo nel finale, e paralleli e citazioni dal Faust e dalla Divina Commedia non sono mai casuali. Buona parte dell’azione si svolge nella šaraška, il primo cerchio del gulag (ma nella narrazione balenano anche quelli inferiori, che verranno poi studiati nel dettaglio in “Arcipelago Gulag”), la prigione privilegiata alle porte di Mosca dove detenuti ingegneri e matematici lavorano alla costruzione di apparecchiature che aiuteranno i loro carcerieri a fare altri prigionieri. Le vittime producono nuove vittime, i prigionieri e i carcerieri possono scambiarsi di posto in qualunque momento, e sono accomunati dalla stessa paura e mancanza di libertà, in un paese dove tutti vivono in prigione, dal capo supremo ai carnefici: nessuno può uscirne, nessuno può parlare liberamente, nessuno può permettersi il lusso di non avere paura, e Gleb Neržin, quello fra i protagonisti di un romanzo senza eroi che più rappresenta l’alter ego dell’autore, finisce per esclamare: “Sia benedetta la prigione!!! Mi ha dato il tempo di riflettere.”
Ed è proprio nella prigione che coloro che non hanno più nulla da perdere svolgono appassionati e dotti dibattiti sulla politica, l’arte, la storia, il senso della vita, ormai impossibili dall’altra parte del filo spinato, come quei dialoghi tra Neržin, Rubin e Sologdin dove più traspare la presa di posizione dell’autore, e dove troviamo le tracce di tutti quei temi che negli anni successivi saranno i più cari a Solženicyn, e i più discutibili per i suoi critici: la rivoluzione, la religione, la donna, il popolo contadino, la monarchia, la lingua russa, l’Europa, il marxismo, il valore purificatore della prigionia, ma soprattutto la cultura (più è pericoloso un personaggio, più di solito è rozzo, squallido e insignificante). Ma non è un romanzo didattico e ideologico, è una narrazione corale, mirabilmente resa nella traduzione di Denise Silvestri nella moltitudine di voci, parlate, tonalità, con decine di storie che si diramano dalla trama principale e la narrazione dell’autore che si adatta di volta in volta alle vicende di illustri astri della matematica come alla straziata biografia dello spazzino Spiridon, una sorta di Ivan Denisovič ante litteram. I personaggi – tutti ispirati da persone realmente esistite, e di molti i biografi dello scrittore han- no ricostruito identità e sorti – sono decine e decine, alcuni appaiono in scena solo per un capitolo, altri si muovono e si intrecciano, ma di tutti viene fornito un vivido ritratto di avvincente precisione e introspezione.
Romanzo corale nei personaggi e nei luoghi, la cui azione è invece pressata in meno di tre giorni, con però decine di flashback che vanno indietro di decenni, e lontano migliaia di chilometri dalla Mosca del Natale 1949, descritta in maniera quasi palpabile, negli odori, colori e rumori di una grande metropoli indifferente, spaziando dai corridoi delle prigioni alle stanzette dei convitti studenteschi, dalla metropolitana alla dacia di Stalin, con continui e improvvisi cambiamenti di ritmo, in un mosaico dove voragini filosofiche si alternano a intermezzi quasi comici, serrati dialoghi carichi di messaggi a tenui descrizioni introspettive, momenti di alta tensione a improvvise deviazioni dal plot, in un incastro che sa di perfezione matematica, ma anche di musica, con le voci dei vari protagonisti perfettamente udibili e distinguibili, in un coro polifonico. Tutti i dettagli sono al loro posto, il fucile appeso nel primo atto spara nel terzo, come raccomandava ČCechov, l’infinito puzzle di dettagli, sfumature, oggetti, suoni, odori e frasi si compone senza lasciare fessure, è tutto visibile, quasi come fosse una sceneggiatura pronta, uno dei panorami più ampi e realistici della Russia del Novecento.
Un giorno, forse, questo capolavoro si leggerà “soltanto” come un grande romanzo. Ma oggi, un secolo dopo la nascita dello scrittore e cinquant’anni dopo la prima pubblicazione “spennata”, è ancora impossibile distinguere questo imponente affresco dal suo soggetto: lo stalinismo. L’enigma di un paese enorme totalmente soggiogato dal suo sovrano, un’intera nazione che resta sveglia perché “un uomo soltanto di notte non dormiva […] Per non cedere al sonno, convocavano i loro vice, e i vice importunavano i capiufficio, gli archivisti sulle scalette spulciavano negli schedari, i segretari volavano per i corridoi, le stenografe spezzavano la punta delle matite”. Un paese stretto dalla paura, “la paura sorta in lunghi anni di subordinazione era così enorme che nessuno di loro, né prima né dopo, aveva avuto abbastanza coraggio da farsi valere davanti ai superiori”, i delatori sono ovunque e il minimo gesto o frase possono costare la vita e la libertà. Un paese preso da una “folle, insopportabile corsa che stava stritolando tutta la nazione”, la corsa impossibile verso l’utopia, mentre “le case non stavano in piedi, i ponti non si reggevano, le costruzioni si riempivano di crepe, il raccolto marciva o non germogliava proprio”, in un’autodistruzione che nessuno aveva il coraggio di fermare, e che veniva spacciata per l’approssimarsi della nuova era. Un paese avvolto nella bugia, che della menzogna aveva fatto strumento di lavoro e sopravvivenza, dove la verità e lo sguardo disincantato sulla realtà erano punibili con la prigione, e solo nella prigione diventavano possibili. Tutti mentono a tutti – i mariti alle mogli, i genitori ai figli, i superiori ai sottoposti, i giornali ai lettori, i ministri a Stalin e Stalin a sé stesso – in un meccanismo psicologico quanto politico, dove le fake news diventano strumento di governo e necessità quotidiana, di cui Solženicyn descrive il funzionamento in intuizioni che sembrano tratte da studi di comportamentalistica moderna.
In questo romanzo ispirato a persone realmente esistite, tutti mentono a tutti – i mariti alle mogli, i genitori ai figli, i superiori ai sottoposti, i giornali ai lettori, i ministri a Stalin e Stalin a sé stesso – in un meccanismo psicologico quanto politico, dove le fake news diventano strumento di governo e necessità quotidiana
Un sistema dove tutti sono vittime e carnefici, e tutti prigionieri, a cominciare dal Capo Supremo, che ha appena festeggiato i settant’anni e si appresta quasi con disperazione a governare per altri venti, paragonandosi anch’egli a un detenuto che deve scontare la condanna. Alla distruzione del mito di Stalin Solženicyn si dedica con parole di violenza quasi fisiologica – “era soltanto un piccolo vecchio dagli occhi gialli, con i capelli biondicci (nei ritratti li raffiguravano corvini) che si stavano già diradando (li raffiguravano folti), il viso grigio butterato qua e là dai segni del vaiolo, una sacca di pelle flaccida sotto il mento (quella non la disegnavano affatto), i denti scuri e irregolari, una parte dei quali ripiegata all’interno della bocca che puzzava di tabacco in foglie, le umide dita unte che lasciavano tracce sulle carte e sui libri” che vive una vita da recluso nella sua dacia, abitando (proseguendo la metafora infernale) nel buio, nella notte, in solitudine, a percorrere corridoi sotterranei, stanze piccole e senza finestre, sbirciando da spioncini e porte nascoste, dove perfino l’aria arriva filtrata e artificiale. E’ un uomo di soluzioni semplici, considera la morte (degli avversari come degli alleati) come lo strumento più semplice per eliminare un problema. Non conosce il paese che governa – nelle sue poche uscite all’esterno strade e stazioni vengono sgomberate, fino quasi a convincerlo di esserne l’unico abitante – e governa un paese che non esiste, in un mondo che respira morte, già sepolto da vivo (anche se sogna l’immortalità regalata dalla scienza), in un labirinto blindato, senza luci, senza finestre, senza incontrare nessuno, avvolto dalla paura e dalla paranoia, in una Russia svuotata per non arrecargli disturbo.
E’ l’autunno di un patriarca che non ha conosciuto una primavera gloriosa, un vecchio rancoroso, paranoico, vanitoso e permaloso, afflitto dalla paura della morte e dalla solitudine nella quale non gli resta che confrontarsi con quel dio che ha rinnegato (per poi cercare di sostituirlo) lasciando la carriera del seminario per quella del rivoluzionario. Ma è l’antirivoluzionario per definizione, è il potere pragmatico incarnato, desideroso solo di stabilità e ordine: odia le rivoluzioni, disprezza gli uccisori dei tiranni, il potere viene dall’alto e non dal basso, è un conservatore anche nell’amorosa meticolosità con la quale ripristina i dettagli della monarchia, dalle mantelle delle ginnasiali alle uniformi dei ferrovieri.
Più che ispirato dall’utopia marxista è il suo becchino, un Grande Inquisitore dostoevskiano che ambisce a una gerarchia patriarcale, convinto che “il popolo non poteva restare senza risposte giuste e continue. Il popolo non poteva reggere senza certezze. La rivoluzione aveva trasformato il popolo in un orfano, in un senzadio, cosa davvero pericolosa”.
Quando scrisse – e poi tolse – quei capitoli nella prima stesura di “Nel primo cerchio”, Solženicyn si sentì obiettare da Aleksandr Tvardovskij – il poeta direttore della rivista Novij Mir, che ebbe il coraggio di pubblicare “Una giornata” di Ivan Denisovic – di non poter inventarsi “dettagli così precisi e certi della vita del monarca” senza conoscerli. Lo scrittore rispose che “Stalin doveva mietere la semina della sua segretezza. Visse in segreto, e dunque oggi chiunque ha diritto a scriverne qualunque cosa secondo la propria immaginazione. Questo è il diritto e il compito dell’artista, dipingere un quadro e contagiarne il lettore”. Il prodigio, come si è scoperto decenni dopo da numerose e svariate testimonianze, è che l’artista colse quello che ignorava, ricostruendo lo scheletro del dinosauro dalla mandibola. Anche perché il meccanismo inesorabile della mente del dittatore, che plasma la realtà fino a crederci lui stesso, non poteva essere dissimile da quello dei suoi “le- muri”. Ma può essere letta anche come la psicoanalisi perfetta del narcisista, che distrugge tutto quello che lo può oscurare, per poi annoiarsi con i mediocri che egli stesso ha selezionato: “Come re Mida, che trasformava in oro tutto ciò che toccava, Stalin rendeva mediocre tutto ciò che sfiorava.”
Solženicyn aveva dedicato la sua opera, il suo scontro del vitello che voleva incornare la quercia, come recita il titolo della sua prima autobiografia, ad abbattere quello che gli sembrava un mito che avvelenava la Russia e il mondo: la bontà del comunismo, nonostante i suoi crimini. Voleva dimostrare che Stalin non fosse una tragica “deviazione”, ma il prodotto inevitabile e logico dell’ideologia comunista (i pochi marxisti convinti nel suo romanzo, anche loro ovviamente detenuti, vengono trattati con benevola compassione), non un’eccezione, ma la sua massima espressione. Molti russi della sua generazione sono convinti di essere stati colpiti da un male eccezionale, senza confronti, che in un certo senso rende grandi anche le vittime (a differenza degli ebrei però, oltre che vittime ne furono pure perpetratori). Ma lo Stalin di Solženicyn appare all’improvviso banale, già visto, replicato altre volte in tutte le sue manifestazioni – dai monumenti del “culto della personalità” all’eliminazione metodica di tutti i nemici più brillanti, i Trockij di turno.
I paragoni con molti tratti della Russia contemporanea – emblematico il passaggio della limousine di Vladimir Putin diretto alla cerimonia della sua terza investitura al Cremlino, attraverso una Mosca svuotata di abitanti – sono involontari quanto sintomatici di un sistema ancora radicato. Riletto cinquant’anni dopo, il romanzo colpisce però un bersaglio molto più ampio, non circoscritto né nello spazio, né nel tempo. Come l’unicità del male degli anni Trenta viene ora messa in discussione dalla risorgenza di discorsi e odi che sembravano banditi per sempre, così quella che doveva essere una denuncia di fuoco contro il mostro della dittatura comunista oggi si può rileggere come un manuale di psicologia del dittatore, e del funzionamento della macchina totalitaria – paura, paranoia, bugia, manipolazione, violenza, corruzione, risentimento, autarchia e mediocrità – in nome di un potere da concentrare in poche, pochissime mani. Da Mao alla dinastia dei Kim, dai peronisti latinoamericani a quelli birmani, dai satrapi africani ai rais mediorientali, fino ai sovranisti e populisti europei e americani, in quella triste farsa che, se- condo Marx, è sempre la ripetizione della storia, inneggiano al popolo per trasformarlo in plebe.
Il dittatore ideale, come lo Stalin di Solženicyn, proclama la mediocrità come modello, disprezza la scienza e deride gli intellettuali, con la loro attitudine a dubitare, esitare e sottilizzare. Per lui l’unico metodo per superare un ostacolo è eliminarlo: il confronto, il dialogo, la persuasione, la competizione gli sono sconosciuti, anche perché sa che in questi campi non può che essere un perdente. Lo stesso Stalin di Solženicyn sa, intuisce, di non essere l’unico: il solo essere umano verso il quale avesse mai nutrito una fiducia e una complicità tra pari è Adolf Hitler, e risponde a chi voleva eliminarlo esclamando: “Un socialismo senza di lui era fascismo bell’e buono!”
“Nel primo cerchio” racconta anche come va a finire l’inevitabile stratificazione che nasce da ogni sogno rivoluzionario, descrivendo senza elusioni una società sovietica violenta, cinica, corrotta e classista, cogliendo, dalle segrete gelate del gulag più remoto alla camera da letto di Stalin, quella sensazione di squallore che disgusta in misura eguale comunisti e anticomunisti, con la nuova borghesia rossa che ha dimenticato qualunque ideale, perfino sanguinario, per darsi alla sfrenata caccia a tappeti, cristalli e mobili, iniziata con il saccheggio della Germania sconfitta: “Il paese si era inferocito, si era fatto totalmente disonesto, e voragini separavano una gracile miseria da una ricchezza che ingrassava spudorata.”
Qualunque giustificazione, ideale, economica, sociale, estetica, della rivoluzione, sparisce in una certificazione senza appello del fallimento, che oggi non riguarda più solo l’illusione del comunismo, ma tante altre che sono venute, e che verranno, secondo la regola, dimostrata da Solženicyn con la precisione del matematico, che un potere sorto con la violenza e l’inganno non può non essere cinico e inefficiente. La distinzione elitista, e l’assenza di dialogo, tra chi è istruito e il “popolo”, così tradizionale dei dilemmi della letteratura russa, oggi si rilegge in un’ottica tornata di attualità, e Stalin – il leader che disprezza l’élite e capisce il popolo, manipolando entrambi – potrebbe sembrare l’unica, per quanto ripugnante, soluzione per tenerli insieme. Con l’inevitabile conclusione che gli unici a volere e potere comportarsi come cittadini e farsi guidare dalla ragione e dalla morale, in una sorta di società ideale di filosofi che contrasta la dittatura dell’imbecillità, siano i detenuti.

l'editoriale dell'elefantino
Troppi baci al caro Trump. Bisognerebbe fargli un po' di male

Dal gulag all'occidente
Intervista a Sharansky: “Fra tirannie e utili idioti siamo in pericolo”



