
Una manifestazione degli anti vaccinisti nei pressi del Senato nel luglio 2017 (foto LaPresse)
La fine degli hater
Il coronavirus ci ha messo le mascherine ma pure le museruole, e i leoni da tastiera si sono ammansiti: se la sono fatta sotto
C’eravamo tanto odiati, tanto che odiare era diventata attività connotante e chi odiava faceva categoria sociale a parte, una smartworking class attiva su scala mondiale, molto operosa e vasta e odiosa, a volte persino perniciosa, pagata non in denaro ma in visibilità, che avevamo nominato hater. Gli hater ci erano parsi incontrastabili, ma nonostante questo avevamo dedicato molti sforzi al loro depotenziamento, contenimento, assorbimento. E forse incontrastabili sarebbero rimasti, se non fosse accaduta una immane tragedia, che come tutte le tragedie fu ingiusta, arbitraria, spietata, ma fece anche giustizia. Era poi infatti accaduto che era venuto un virus dalle origini umili e bestiali, dal nome maestoso e allarmante, dalla potenza sottile e infestante, e lo avevamo contratto ammalandoci in molti, quasi tutti, amatori, odiatori e neutri, e allora di odiare non avevamo più avuto la voglia, non avevamo più trovato il gusto. Ecco come forse ci racconteremo, noi millennial tardivi, ai figli che un nostro cantautore di riferimento, Vasco Brondi, anni fa cantava che non avremmo avuto e che invece, forse, complice anche la clausura di queste settimane, avremo eccome – ragazzi, se alla fine di tutto questo non si risana almeno la demografia, almeno un pochino, se non fate l’amore e qualche bimbo neanche quando vi murano vivi in casa con coniugi e/o conviventi allora bisognerà forse ammettere che di pandemia ce n’è un’altra, e da molto tempo, ed è asintomatica, e si chiama autoestinzione.
A darci la misura dell’uomo, che avevamo perso da un po’, è arrivato un virus vigliacco. I social come diario di una mutazione. Apri Instagram e vieni invaso da dirette di comici, musicisti, scrittori, che si offrono per tenerti compagnia e far passare questa lunga notte
E se non ci racconteremo ai figli nostri, ci racconteremo a quelli degli altri, o agli alieni, che in fondo questo sono, figli di altri – non vorrete escludere lo sbarco degli alieni, ora che abbiamo visto avverarsi tutto “Black Mirror” e il settanta per cento delle distopie da bancarella e pure da Pulitzer, ora che da giorni viviamo in un taccuino di Philip K. Dick. Le fonti privilegiate del nostro studio socioantropologico atto a raccogliere materiale per questo racconto che sarà la nostra storia da tramandare, naturalmente, sono i social network, e nessuno può più dire di no, opporre che il paese reale è un altro, è altrove, che le persone sono tra i vicoli di Roma a far pezzi una canzone e non su Facebook a fare a pezzi Roberto Burioni, che tutto il mondo è paese e non Instagram. Siamo tutti (quasi tutti) in casa a telelavorare, telecomprare, televendere, teleamare e non andiamo più a cena fuori, a bere fuori, a passeggiare, non ci incontriamo che su WhatsApp, non comunichiamo che su Facebook, non dibattiamo che su Twitter e allora misurare la temperatura di questi spazi, se prima era miope, adesso è la sola cosa da fare. L’uomo è misura di tutte le cose, tranne che di sé stesso. A darci la misura dell’uomo, che avevamo perso da un po’, accapigliandoci su quale fosse lo strumento migliore per prenderla, è arrivato un virus vigliacco, che uccide i deboli attraverso i forti, senza spargimenti di sangue ma di detersivo sì, specie se disinfettante. I forti mettono in pericolo i deboli con la sola presenza, e chi mai l’avrebbe immaginato, nel ventennio dei supereroi, che per far bene agli indifesi li si sarebbe dovuti separare dai difensori. Chi mai avrebbe immaginato che i social network, che per anni abbiamo indicato prima come una bomba da maneggiare con cura, poi come una deflagrazione di cui contenere i danni, e periodicamente persino come uno strumento da proibire, sarebbero invece diventati il diario di una possibile, epocale mutazione antropologica. Leggiamo gli status, le interazioni, le condivisioni su Facebook e la prima cosa che balza agli occhi, con una prepotenza che è prima di tutto una speranza, e subito dopo pure un’evidenza, non importa se momentanea, è che gli hater sono quasi tutti dispersi, scissi, rescissi, dileguati, azzittiti. Il coronavirus ha messo mascherine ma pure museruole, e non per autocensura bensì per autocontrollo. Lo avete notato? Sembravamo destinati alla rabbia perpetua, all’incremento costante del disprezzo, del vilipendio, della violenza, dell’insulto, del bullismo, e invece poi siamo cascati in una pandemia, siamo diventati tutti uguali pur essendo così diversi, impilati in classi rigide ma invisibili, invalicabili, e ci siamo fermati, ci siamo dovuti fermare, dividere, accomiatare, isolare. E dalla prossimità asfissiante con l’altro siamo passati alla sua assoluta mancanza, alcuni di noi vivono addirittura una quarantena nella quarantena, un isolamento nell’isolamento, perché hanno magari stretto la mano a un collega che s’è scoperto positivo e quindi potrebbe averli infettati e allora loro per non infettare anche il resto della famiglia con cui si sono chiusi in casa come chiesto da decreto di Conte, devono chiudersi in una stanza tutta per loro, e comunicare coi propri cari attraverso il muro, come Piramo e Tisbe, o su Skype, come genitori e cervelli in fuga. Ci stiamo vicini tenendoci lontani e le piazze sono vuote, i negozi chiusi, gli aperitivi banditi, le presentazioni di libri annullate, le file distanziate, tutte cose che fino a ieri ci sembravano utopie auspicabili, perché fino a ieri gli altri ci arrivavano fin sopra i capelli, con tutto il loro inferno incandescente. Poi all’improvviso gli altri ci sono stati levati di torno e noi non abbiamo pensato neanche per un attimo che era ora, finalmente, e i salotti virtuali in cui andavamo a sfogarci di quell’inferno, di quella frustrazione che per molti è diventata la democrazia, spesso indossando una maschera che ci garantisse l’anonimato, quei salotti dove davamo il peggio di noi stessi, ci stiamo adesso ingegnando a renderli ospitali, calorosi, rassicuranti, amorevoli. Apri Instagram e vieni invaso da dirette Facebook di comici, musicisti, presentatori, scrittori, poeti che si offrono per intrattenerti, tenerti compagnia, far passare questa lunga notte che durerà molti giorni ancora, e che è tanto nera da sporcare le lenzuola, l’umore, l’amore, le prospettive. E tu partecipi a tutte, e ti senti abbracciato, incluso, uguale a tutti, come tutti, e ne sei felice, e vedi che Ghemon legge un tuo messaggio ad alta voce, che Emma Marrone ha il frigorifero come il tuo, che Fiorello sta bene in pigiama, che a Victoria Cabello fa schifo cucinare quasi quanto fa schifo a te e che lo dice con la stessa soave faccia tosta con la quale dice che non andrebbe a letto con una donna mai e poi mai, senza che nessuno la insulti per questo, o l’accusi di incitamento all’omofobia, perpetuazione di cliché segregazionisti, eccetera eccetera. Il bello delle dirette sui social network non è soltanto che sono spontanee, e le stanno facendo artisti e non, politici e non, intrattenitori e non, per tenere le persone in casa, aiutarle a non sentirsi sole, impotenti, inutili, spacciate, abbandonate. Il bello delle dirette è soprattutto il modo in cui gli utenti le accolgono, partecipando non per dire la loro a tutti i costi, come era nel mondo prima che arrivasse il coronavirus, quando dire il proprio era quasi sempre dire un vaffanculo, bensì per aderire, far numero, far calore, fare rete, dire ci siamo ed è bello esserci, e ce la faremo, e non siamo più arrabbiati, anche se siamo spaventati, in fondo eravamo spaventati anche prima, solo che prima la paura era senza scopo, adesso lo scopo lo ha ed è non compromettere gli altri per non compromettere sé stessi.
Gli italiani si riuniscono attorno ai propri smartphone e si collegano coi loro cantanti preferiti e la stanza non ha più pareti ma falò di San Lorenzo, quelli che si fanno in estate, in spiaggia, da molto giovani, con molte chitarre. Diodato era in diretta Instagram quando, mercoledì sera, Giuseppe Conte ha detto al paese che ci sarebbe voluto un altro sforzo ancora, che dal giorno dopo sarebbero rimasti chiusi pub, negozi, parrucchieri, e che la vita mondana si sarebbe ridotta all’essenziale, alla prima necessità, e nessuno dei collegati ha sbraitato, bestemmiato, polemizzato, sacramentato. Hanno tutti pigiato sui cuori delle tastiere, e chiesto cantaci questa, e cantaci quest’altra, e quando tornerai su un palco, e va bene non preoccuparti anche se non lo sai noi ti aspetteremo. E lui ha cantato, poi ha detto che quello che sta accadendo ci sta aiutando a dare alle cose il peso che hanno, e che lui è molto commosso.
Siamo tutti molto commossi, molto tremanti, molto accesi, abbiamo sentimenti potenziati, chi lo sa se falsati o svelati dalla cattività, stiamo sperimentando quello che “Il Grande Fratello”, quando nacque, aveva l’intento di sperimentare e cioè quanto e come si apre o si chiude il cuore di un uomo quando gli viene impedito di uscire. Siamo tutti più sentimentali, e simpatici, e disponibili, ed educati, e sinceri, e pacati, e misericordiosi. Twittiamo consigli per un nuovo bon ton della vita reclusa, ci immaginiamo come sarà rincontrarci tra un mese, occhi neri tra milioni di occhi neri che saran belli più di ieri, ci fotografiamo sul divano per dare il buon esempio agli irriducibili negazionisti che s’ostinano a minimizzare e che forse fino a ieri erano hater e adesso sono solo negazionisti tuttavia prossimi a mollare, a cedere, lo si vede lontano un dodici pollici che molto presto non saranno in grado di mantenere lo stoicismo da passeggeri di prima classe del Titanic, quelli che rinunciarono alle scialuppe pur di affondare con stile, in smoking, imperturbabili, pur di non cambiare abitudini neanche nell’ultimo quarto d’ora delle loro vite.
I leoni da tastiera si sono ammansiti perché se la sono fatta sotto, e gli sparuti immarcescibili che ancora infestano Facebook sono comunque passati dal ruggire al miagolare, dal “muori troia” al “scusi se mi permetto ma lei ha detto una cazzata”, dal “che cazzo dici” al “non sono d’accordo”, è bastata una polmonite con una capacità virale in confronto alla quale un post di Chiara Ferragni è un editoriale di Lotta Comunista per farli arrendere, azzerare quell’acredine con cui credevano di poter addurre infiniti lutti alla casta. E noi fessi che per anni abbiamo fatto convegni, scritto libri, analizzato il paradosso per cui Internet, nel dare la parola a tutti, abbia finito con l’instaurare una dittatura, noi che ci siamo messi a scrivere giornali e sceneggiature e canzoni e leggi che turbassero, agitassero, scontentassero il meno possibile, che tenessero sempre presente che l’animale che prima ci portavamo dentro ora ce lo portiamo tutti fuori ed è pronto a sbranare. Noi che avevamo quasi perso la speranza che il mondo potesse redimersi, contenersi, ritrovare la misura, osserviamo adesso come una malattia sconosciuta stia forse riuscendo laddove New York Times, Enrico Mentana, divulgatori, Nasa, polizia postale, Dio, #metoo, non sono riusciti e chissà se sarebbero riusciti mai. Gli sproloqui di Matteo Salvini non circolano più, perché Matteo Salvini stesso sproloquia assai meno, sfotte assai meno, ha capito che il gioco s’è fatto tetro e peso e che però non è il caso di vender il suo didietro, anche perché non lo comprerebbe nessuno. Le testatine online non diffondo video di litigi trash, e se lo fanno in pochi le ricondividono. Sgarbi fa Sgarbi ma non proseliti. Gli influencer fatturano, fatturano sempre, ma per beneficienza (i coniugi Ferragnez hanno raccolto tre milioni e passa di euro in 24 ore e li hanno destinati alle terapie intensive). Fabrizio Corona dagli arresti domiciliari si connette in diretta Instagram ed entra nelle case degli italiani per dir loro che vuole trasmettere serenità e rimprovera chi ha scritto “Italia merda” sul wall della diretta e lo corregge – “Italia merda no, non si dice, ma Italia paese sbagliato sì, si può dire” – e ricorda a tutti che in casa si possono fare molte cose, e ci si può arrangiare e da un arrangiamento possono nascere grandi imprese. I Savonarola che prima diffondevano scontrini di pranzi di parlamentari per incitare le masse al colpo di Stato, adesso fotografano quelli che circolano abbracciati per dire che non si fa, che bisogna stare a casa, e distanti – e va bene che li danno in pasto alla pubblica gogna, ma almeno per un fine più nobile del contare le monetine nelle tasche di chi li governa.
Degli altri ci manca tutto tranne l’occasione di sfotterli, irriderli, odiarli, insultarli, perché abbiamo capito che siamo uguali a loro. Dal “muori troia” al “scusi se mi permetto ma lei ha detto una cazzata”, dal “che cazzo dici” al “non sono d’accordo”
Stavamo preparandoci alla fine del mondo, stavamo rassegnandoci al fatto che sarebbe stata un lamento e non uno schianto, come in quella poesia di Thomas Stern Eliot, Uomini vuoti, e invece poi è successo qualcosa di imprevisto. Una malattia che nell’ammalarci ci purifica, ci lenisce, ci rinsavisce, e lo fa certamente punendoci, ma con una punizione che infligge un dolore lucido, di quelli che non annebbiano ma disvelano. Un dolore che ci dice chiaramente che “Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo” e ci rimette al nostro posto. La scorsa settimana di virale non c’è stata nessuna bufala, nessuna fake news, nessuna porcata di Trump, ma una poesia di Mariangela Gualtieri, che l’ha scritta per questi giorni, per questa epidemia, per questa nuova èra, e che a un certo punto fa così: “Ci dovevamo fermare. Lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Non c’era sforzo umano che ci potesse bloccare”. E poi dice che qualcosa al di sopra di noi ha fatto in modo che ci bloccassimo, qualcosa di non umano, un salto di specie, e ora eccoci qua, fermi ma non immobili, chiusi ma non reclusi, a cercarci, a desiderare di baciarci, a non vedere l’ora di fare le cose che prima ci facevano venire la varicella al solo pensiero, ché ci manca persino presentare libri brutti, cenare con uomini che quando facciamo una battuta ci chiedono “in che senso”, far la fila alle poste, far la fila per il bagno dell’ufficio che sappiamo che i nostri colleghi hanno ridotto a una fogna; tutto, degli altri ci manca tutto tranne l’occasione di sfotterli, irriderli, odiarli, insultarli, perché abbiamo capito che siamo uguali a loro, anche se niente e nessuno riusciva più a convincercene, a dimostrarcelo. C’è voluto un piccolo stronzo, un minuscolo bastardo, invisibile a occhio nudo proprio come un hater di internet nel mondo ante coronavirus, un mondo che è servito a fare di noi gli uomini di domani, che torneranno “a quella stretta di un palmo col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci è interdetto ora”. Ricordiamocelo, per il futuro, quel futuro che è ciò che viene dopo un bicchiere di vino, e cioè un altro bicchiere di vino, che per spazzare via gli odiatori, e stupirci della loro fragilità, è bastato scoprire quanto è triste stare lontani un metro.

evitamento organizzato
Viviamo l'èra dell'essenzialità muta. Ma parlate, fatevi questo piacere!
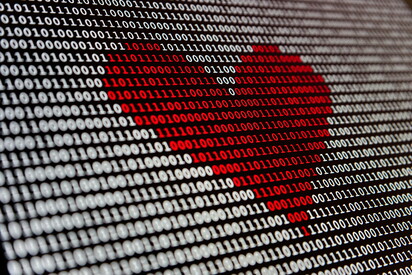

L'editoriale dell'elefantino


