
Roma, murales raffigurante un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (foto LaPresse)
Un nuovo inizio per l'Italia
Indagine sulla natura dell’improvvisa accelerazione di forze contrarie agli indirizzi che sembravano prevalere nel mondo. Il nuovo libro del prof.Cassese
Pubblichiamo ampi stralci tratti dal primo capitolo di “La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia”, il nuovo libro del professor Sabino Cassese edito da il Mulino (344 pp., 18 euro), da giovedì scorso in libreria. Questi dialoghi contengono una riflessione sulle vicende politiche e istituzionali italiane, considerando il sistema politico, i suoi dati strutturali, i modi in cui opera la democrazia, i condizionamenti e i contesti europeo e globale.
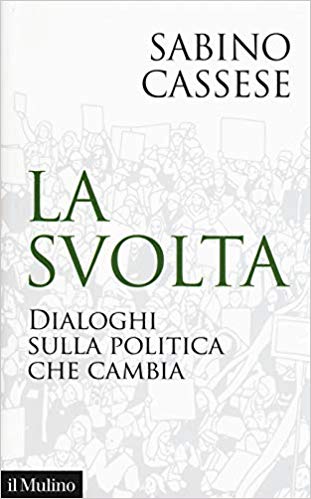 Molti eventi si sono succeduti nel biennio 2017-2018, un biennio cruciale. Si riscoprono le frontiere, si ergono nuovi muri. I “sovranisti” mettono sotto accusa la globalizzazione. Si affacciano diversi tipi di europeisti. La costruzione europea è criticata dagli europeisti e contestata dagli antieuropeisti. L’Unione europea perde il Regno Unito, e quest’ultimo, una volta esempio di temperanza e senso pratico per le altre democrazie, sembra dominato da ideologismi. Gli Stati Uniti sollevano dubbi sull’Alleanza atlantica che ha governato questa parte del mondo fin dalla fine della Seconda guerra mondiale. Qui e lì nel mondo si affermano democrazie illiberali.
Molti eventi si sono succeduti nel biennio 2017-2018, un biennio cruciale. Si riscoprono le frontiere, si ergono nuovi muri. I “sovranisti” mettono sotto accusa la globalizzazione. Si affacciano diversi tipi di europeisti. La costruzione europea è criticata dagli europeisti e contestata dagli antieuropeisti. L’Unione europea perde il Regno Unito, e quest’ultimo, una volta esempio di temperanza e senso pratico per le altre democrazie, sembra dominato da ideologismi. Gli Stati Uniti sollevano dubbi sull’Alleanza atlantica che ha governato questa parte del mondo fin dalla fine della Seconda guerra mondiale. Qui e lì nel mondo si affermano democrazie illiberali.


L’interrogativo se il biennio 2017-2018 segnali un passaggio a una fase diversa della storia dei sistemi politici contemporanei
Per la prima volta, in Italia, hanno conquistato il governo due forze politiche che si sono sviluppate fuori e contro l’establishment. Ritorna d’attualità la diagnosi di un acuto osservatore di quasi un secolo fa, che notava: “L’epoca nostra ha la febbre” e segnalava “un’ansia indefinita dell’immediato domani”. “L’orizzonte della nostra aspettativa” (Karl Mannheim) sembra diventare meno roseo. Dieci anni dopo l’inizio di una delle peggiori crisi economiche mondiali, trenta dopo la caduta del Muro di Berlino, settanta dopo l’inizio del periodo repubblicano in Italia, il progresso della globalizzazione si è fermato o è stato rallentato, vi è meno libertà e democrazia nel mondo, riprendono forza gli Stati, perdono definitivamente quota in Italia le forze politiche che si iscrivevano nella tradizione dei “padri fondatori” della Repubblica. E’ vero cambiamento? Siamo in presenza di un nuovo tornante nella storia mondiale e nazionale? Perché questa improvvisa accelerazione di forze contrarie agli indirizzi che sembravano prevalere nel mondo? Il biennio 2017-2018 è un tornante, segnala un passaggio nuovo, indica l’inizio di una fase diversa, non per tutti migliore, della storia dei sistemi politici contemporanei?
Un governo di newcomers e di outsiders
Cominciamo da casa nostra. Il 1° giugno 2018 ha giurato il 65° governo della Repubblica italiana, che si è autodefinito “governo del cambiamento”. Il 4 marzo precedente quasi 47 milioni di italiani erano stati chiamati alle urne. 34 milioni sono andati a votare (quindi, l’affluenza è stata del 73 per cento). Al Movimento 5 stelle (nato nell’ottobre 2009 per iniziativa di Giuseppe Grillo e di Gianroberto Casaleggio) sono andati più di 10 milioni di voti, al Partito democratico 6, alla Lega-Salvini premier (nata nel dicembre 2017 dalla Lega Nord del 1989 e da “Noi con Salvini” del 2014) quasi 6, a Forza Italia circa 5. Rispetto alle elezioni politiche del 2013, il M5s ha avuto 2 milioni di voti in più, mentre la Lega ne ha avuti 4. Invece, Forza Italia ha perduto 2 milioni 700 mila elettori, mentre il Pd ne ha perdutI 2 milioni e mezzo. E’ così iniziata la diciottesima legislatura repubblicana. Il 73 per cento dei parlamentari del M5s e l’86 per cento di quelli della Lega erano alle prime armi. Tre forze politiche hanno raggiunto un rapido accordo sui vertici parlamentari: la presidenza del Senato è andata a una senatrice di Forza Italia, ma non al candidato indicato dal leader di quel partito; la presidenza della Camera è andata a un candidato del M5s, ma scelto tra i maggiori competitori interni del “capo politico” di quel partito. Più difficile e lunga la procedura di formazione del governo, che ha impegnato il presidente della Repubblica in più giri di consultazioni e i due presidenti delle assemblee parlamentari in “esplorazioni”. Solo alla fine è risultato chiaro che l’unica soluzione stava in un accordo tra i due migliori perdenti, M5s e Lega, i quali hanno stipulato un “contratto per il governo del cambiamento”, sottoposto a due diverse consultazioni popolari, quella del M5s tra i suoi iscritti e quella della Lega aperta a tutti. Ottantanove giorni dopo le elezioni, i ministri hanno giurato.
La compagine, squilibrata per il genere (solo un quarto composta di donne), per la rappresentanza regionale (regioni importanti, come Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, non hanno propri rappresentanti nel governo) e per esperienza (solo due ministri sono stati in precedenza al governo), ha quattro figure fondamentali (presidente, ministri dell’Economia e delle finanze, degli Affari esteri e degli Affari europei) prescelte tra non parlamentari e non appartenenti alle due forze parlamentari che hanno costituito il governo.
Le due forze politiche, se, per il peso della quota maggioritaria della formula elettorale della legge Rosato e per il numero relativamente alto dei voti nulli, dispongono di una maggioranza in Parlamento, tuttavia, rappresentano solo circa il 48 per cento dei votanti e il 35 per cento degli aventi diritto al voto. Così, l’Italia è “la prima democrazia occidentale che ricostruisce la propria sfera pubblica intorno a due forze che si sono sviluppate al di fuori e contro l’establishment”. L’Italia ha per la prima volta un governo composto non solo da newcomers, ma anche da outsiders. Un governo unito da stili populistici, ma diviso dalla diversa natura delle due forze che lo compongono, una, la Lega, costituita come un partito del leader, l’altra, il M5s, organizzata come una rete aperta (ma anch’essa rigidamente governata o corretta dal centro). Le difficoltà dell’azione di governo si sono subito manifestate. Infatti, le due forze politiche sono tenute insieme da una comune tradizione leaderistica condita di retorica populista, ma sono asimmetriche: M5s e Lega sono alleati al centro, oppositori in periferia (regioni e comuni), mentre Forza Italia è all’opposizione al centro e alleata in periferia con la Lega. Come primo atto, il governo ha, con toni nazionalistici e guerreschi, deciso la chiusura dei porti agli immigrati, un provvedimento roboante quanto inutile, se si considera che la popolazione subsahariana è più di due volte quella europea e si prevede che sia quasi cinque volte quella europea in cinquant’anni, e che lo scarto di reddito medio tra questa e quella europea è di 1 a 11.
Chiudere i porti, quindi, è come provare a svuotare gli oceani con un cucchiaio (basti pensare ai molti modi di entrare illegalmente o legalmente, come quello di chi non approda nei porti o degli overstayers, che varcano le frontiere con permessi regolari, salvo poi non rientrare nel proprio Paese, o alle difficoltà di espellere gli immigrati irregolari). La seconda iniziativa del governo è stata l’approvazione di un decreto legge intitolato “dignità dei lavoratori e delle imprese” (per la prima volta nel mondo la dignità viene assicurata anche alle imprese). Nato all’insegna di un metodo antico, quello del government by negotiation, specialmente con i sindacati dei lavoratori, ne ha fatto una applicazione sbagliata, attirandosi critiche da molte parti, specialmente per le sanzioni disposte a carico delle imprese che delocalizzano attività economiche fuori dell’Unione europea.


Le due forze politiche al governo alternano e mescolano movimentismo e istituzionalizzazione e quindi sono fortemente oscillanti
Più avanti è stato approvato un disegno di legge denominato “concretezza” (così chiamato perché si può pensare ispirato a una pubblicazione della corrente andreottiana della Democrazia cristiana), che promette centinaia di migliaia di concorsi in un anno e nello stesso tempo criminalizza i dipendenti pubblici chiedendo loro di registrare i dati biometrici per dimostrare la propria presenza in ufficio. Quanto ai primi passi più all’interno, nella scelta dei collaboratori, il nuovo governo ha seguito un moto contraddittorio. Nella nomina dei capi di gabinetto e dei capi di uffici legislativi, ha dato la preferenza, secondo un vecchio sistema, a consiglieri di Stato e avvocati dello Stato. Invece, ha manifestato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei vertici burocratici e delle autorità indipendenti, con numerosi cambi della guardia e una inusitata fame di posti. Inoltre, il governo si è subito impegnato a disfare il passato, opponendosi con molta acrimonia a quanto era stato fatto negli anni precedenti, invece di concentrarsi sulla costruzione di un diverso futuro.
Insomma, le due forze politiche al governo alternano e mescolano “movimentismo” e istituzionalizzazione e quindi sono fortemente oscillanti, ciò che è reso più agevole dall’assenza di opposizione, dovuta da un lato all’ambigua posizione di Forza Italia e dall’altro alle divisioni interne del Pd. L’assenza o afonia delle opposizioni produce una riduzione dell’offerta politica, e quindi delle possibilità di ricambio. Se e quanto questa diversa compagine politica sia destinata a durare non è possibile dire, anche per la sua duplice novità: l’aver unito forze politiche così politicamente opposte e tanto interamente nuove. Ma, anche se la durata sarà breve, il cambiamento non è meno importante.
“Nel passato matura il futuro”. La sovranità appartiene al popolo
Perché è avvenuto questo cambiamento? Esso è stato improvviso, o è stato preparato lentamente dalle circostanze? Dove vanno cercati i germi del mutamento? Claude Lévi-Strauss ha distinto civiltà “fredde”, che rifiutano il cambiamento, da civiltà “calde”, che scelgono il cambiamento. L’Italia appartiene alla prima categoria: chi ha tentato di accendervi rivoluzioni, come Carlo Pisacane, ha fallito. Bisogna, dunque, andare a ritroso per cercare i germi del cambiamento in corso, quelli che l’hanno preparato e quelli che l’hanno agevolato, così come, nel 1935, il grande storico olandese Johan Huizinga si chiedeva come fossero avvenuti i grandi cambiamenti del passato. La ricerca deve cominciare dalla caduta del fascismo. Allora altissime furono le aspettative. “Credevamo che le stelle fossero a portata di mano”, ha scritto un testimone di quei giorni, quando, disfatto lo Stato monarchico e fascista, il 2 giugno 1946, il popolo fece sentire la propria voce. Furono tre i cambiamenti importanti: scelta della Repubblica; elezione dell’Assemblea costituente, che un anno e mezzo dopo avrebbe dato all’Italia una Costituzione; estensione del voto alle donne. Solo con le elezioni del 1946, il corpo elettorale fu esteso a tutti, perché in quell’anno, per la prima volta, venne data la possibilità di votare alle donne, che erano state considerate, fino allora, parzialmente incapaci. Oltre a non poter votare, non potevano fare i giudici, né potevano accedere alle cariche più importanti (prefetto, ambasciatore, ecc.).
Nel 1925 una legge permise loro di votare, ma solo per eleggere i rappresentanti comunali, a livello locale. Questa legge, del resto, non fu mai applicata perché, subito dopo, il fascismo tolse carattere elettivo alle cariche locali. A un paese autarchico, chiuso all’esterno, si sostituì una nazione che si uniformava alle norme del diritto internazionale e limitava la propria sovranità per assicurare pace e giustizia nel mondo: nel 1949 l’Italia aderì al Trattato del Nord Atlantico, nel 1951 alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nel 1957 alla Comunità economica europea e a quella dell’energia atomica. Per vent’anni non erano state consentite libertà di parola e di associazione. Queste furono ripristinate e ai maggiori partiti si iscrissero 4 milioni di persone (la popolazione italiana era allora di 46 milioni), mentre alle elezioni partecipò poco più del 90 per cento degli aventi diritto. L’Italia unificata aveva accettato forti divari al suo interno. Nel 1950 la riforma agraria iniziò a eliminare i latifondi meridionali e la Cassa per il Mezzogiorno portò al Sud risorse per l’agricoltura e le opere pubbliche. Lo Stato assunse un ruolo dominante nel settore economico: si estesero le imprese pubbliche, con l’istituzione, nel 1953, dell’Ente nazionale idrocarburi (Eni) e con la nazionalizzazione dell’elettricità (espropriazione delle industrie private produttrici e distributrici di energia elettrica e passaggio della gestione a un ente pubblico, l’Ente nazionale per l’energia elettrica, Enel, istituito nel 1962). Ai comuni, vissuti per cento anni sotto il controllo statale, e nel periodo fascista privati persino della elettività degli organi di vertice, venne riconosciuta autonomia. Vi era stata “separazione tra Stato e popolo”; si volle “massima permeazione tra strutture statali e le forze popolari”.


Il ventennio che va dagli anni 60 agli anni 80 è stato aggravato dall’incompleta rifondazione dello stato. Molte le promesse tradite
Questo è il punto sul quale soffermarsi. Nel discorso radiofonico del 14 giugno 1946, Alcide De Gasperi promise che l’Italia sarebbe stata “una Repubblica di tutti”. L’Assemblea costituente, dopo aver discusso a lungo sulla formula della sovranità (“emana”, “risiede”, “spetta”, “è del”), scelse quella che è entrata nell’articolo 1 della Costituzione: “la sovranità appartiene al popolo”. Trent’anni dopo, uno dei principali autori della Costituzione, Costantino Mortati, dirà che la formula aveva un “significato polemico”. La sovranità non veniva attribuita a un soggetto astratto, quale lo Stato o la nazione, ma a uno concreto, il popolo. I costituenti dovettero aggiungere subito dopo, per contenere la promessa di people’s empowerment, che il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. Dunque, l’attribuzione è piena, l’esercizio limitato a elezioni e referendum (artt. 48, 75 e 138). Lo stesso Mortati, nel commentare, nel 1975, quell’articolo della Costituzione, ha osservato che la sovranità popolare comporterebbe l’attribuzione al popolo della scelta dell’indirizzo politico, senza la quale c’è “una forma di sovranità del Parlamento”. Mortati auspicava quindi un “processo espansivo della società civile” e lamentava l’“insufficienza dei congegni […] per l’inserimento” delle istanze di partecipazione nell’organizzazione dello Stato, segnalava l’“esigenza di nuove forme rappresentative”, la “molteplicità di gradi intermedi”, auspicava la rappresentanza di interessi territoriali, ma specialmente sindacali, riteneva necessario un “sistema piramidale di delegazioni” e comunque l’“ampliamento dei canali di comunicazione fra la società e lo Stato”. Come si vede, siamo lontani dalla “sovranità parlamentare” britannica, così bene illustrata da Albert Venn Dicey nel 1885. Essa costringerà il Parlamento inglese, spintovi dalla Corte suprema, ad adottare una legge dopo il referendum popolare sulla cosiddetta “Brexit” (caso Miller del 2016). Così siamo lontani dall’interpretazione della nozione di “sovranità” data dal Tribunale costituzionale tedesco, secondo il quale “le decisioni degli organi statali debbono […] risalire alla volontà del popolo e trovare in questa una fonte. Questa attribuibilità è possibile principalmente a mezzo della elezione del Parlamento, delle leggi del Parlamento che dettano standard per l’esecutivo, dell’influenza del Parlamento sulle politiche governative, del diritto del governo di dirigere e guidare la pubblica amministrazione”. Lo stesso può dirsi della dichiarazione iniziale della Costituzione, secondo la quale l’Italia è una Repubblica democratica. La Costituzione stessa, disponendo più avanti che alla magistratura e agli uffici pubblici si accede mediante concorso, dimostra che l’Italia non è una Repubblica interamente democratica, come promesso dall’articolo 1. Insomma, già la Costituzione, nel 1948, con le disposizioni con cui si apre, aveva posto le premesse perché venissero nutrite aspettative di maggiore partecipazione, nonché di una democrazia più vasta.
Diritti senza doveri, spese senza nuove imposte
Negli anni 60, e specialmente negli anni 70, si è aperta una nuova stagione. Si è allargata la base sociale dei governi (1963-1972 centrosinistra; 1976-1979 solidarietà nazionale; 1980-1992 pentapartito). Si è affermata la “centralità” del Parlamento. Il 1968 ha portato nuovo smalto alla pretesa di tutti ad avere il massimo, tutti gli strumenti della felicità, una piena autodeterminazione soggettiva. Principalmente, si è aperta la stagione dei diritti, la rights revolution: parità tra uomo e donna, statuto dei lavoratori, divorzio, aborto, più tardi unione tra persone dello stesso sesso. In questi anni, hanno trovato applicazione alcune delle “promesse” della Costituzione, specialmente quella, fortemente influenzata dal Piano Beveridge (1942), della “libertà dal bisogno”, relativa principalmente alla salute, all’istruzione, al lavoro e alla protezione sociale (Cassa integrazione guadagni straordinaria: 1951, 1975, 1991; scuola media unica: 1962; pensione, poi assegno sociale: 1969; Servizio sanitario nazionale: 1978). Tuttavia, mentre nella Costituzione i diritti erano garantiti insieme con i doveri, e il binomio diritti-doveri rispecchiava fedelmente l’archetipo della Costituzione francese del Termidoro (1795), nella living Constitution l’enfasi è stata posta sui diritti, dimenticando doveri e responsabilità; mentre la Costituzione disponeva che le spese fossero coperte da nuove o maggiori entrate, ai costi del welfare si faceva fronte aumentando il debito pubblico e con l’inflazione a due cifre. Si ponevano, quindi, altre due premesse dell’odierna situazione: concezione illimitata dei diritti e debito pubblico altissimo. Gli andamenti contraddittori di questo ventennio, dagli anni 60 agli anni 80, sono stati aggravati dall’incompleta rifondazione dello Stato. Sono state molte le promesse tradite e le attese non soddisfatte. Si era combattuto per chiudere completamente con il fascismo. Molte sue istituzioni, invece, rimasero in vita. Gli italiani speravano in un nuovo Stato, ricostruito dalle fondamenta: si dovettero invece accontentare di una modifica del vertice (la Costituzione), mentre il resto rimase immutato, nel segno della continuità (Nenni osservava nel 1963: “Tutto funziona, nulla vive”). (…)
La Prima Repubblica è finita, la Seconda non è nata
Si comprende che una costruzione così fragile e piena di tante contraddizioni dovesse soccombere con il terremoto giudiziario del 1992 (“Mani pulite”), che i principali partiti del Dopoguerra (Dc, Psi, Pci) siano stati messi sotto accusa e siano presto entrati in crisi e scomparsi, che sia stata approvata una formula elettorale maggioritaria e siano apparse nuove formazioni politiche, pur senza cambiare il regime politico, che sulla scena politica abbiano assunto un ruolo da protagonisti dei magistrati-procuratori. Si può ben dire, con Spengler, che le elezioni politiche nazionali del 1994, come quelle del 2018, siano state “rivoluzioni in forme legali”. La riforma costituzionale, avviata nel 1983, non è decollata, il sistema politico è restato parlamentare, mentre, invece, è cominciata una vita nuova dei poteri locali (nel 1993 è stata disposta l’elezione diretta di sindaci e presidenti delle province; nel 1999 l’elezione diretta delle giunte regionali, rafforzando così l’esecutivo dei tre enti substatali, comuni, province e regioni; nel 2001 è stato modificato l’intero titolo V della parte seconda della Costituzione, quello intitolato “le regioni, le province, i comuni”). Se la democrazia è innanzitutto eliminazione del potere perenne del monarca, si capisce perché del sommovimento del 1992 abbiano fatto le spese in particolare i due partiti che avevano più a lungo governato, quello democristiano e quello socialista. Ma questo è avvenuto senza che si consolidassero nuove forze politiche, anzi con una sorta di regressione delle nuove forze politiche da partiti-organizzazione a partiti-movimento o meri séguiti elettorali (in qualche caso, è persino rifiutata la denominazione “partito”), con un ulteriore aumento della distanza tra iscritti e votanti e con una forte componente leaderistica o cesaristica (partiti piedistalli). Anche per l’incapacità di creare una classe dirigente, il nuovo assetto politico, pur avendo assicurato per un quarto di secolo un’alternanza al potere (che nel cinquantennio precedente non c’era stata), non è riuscito a frenare il declino industriale e il rientro dal debito, reso più difficile a partire dal 2008 dalla crisi economica mondiale. Quindi, non è riuscito ad adeguare l’Italia al “vincolo esterno” che aveva cercato, anche se questo è poi servito da deterrente contro i peggiori animal spirits che avrebbero potuto portare l’Italia verso un modello argentino. Diversi governi, specialmente quelli Amato, Ciampi e Monti, hanno tentato di ridurre il carico più pesante che grava sul paese, il debito pubblico, ma la loro breve durata ha reso la loro azione insufficiente. In questo quarto di secolo è continuato il tentativo – avviato, come notato prima, nel 1983 – di modificare il sistema di governo previsto dalla Costituzione, con due scacchi, quello subìto da Berlusconi nel 2006 e quello subìto da Renzi nel 2016. E si sono inseguite le formule elettorali: legge Mattarella del 1994, per tre quarti maggioritaria e un quarto proporzionale; legge Calderoli del 2005, proporzionale con premio di maggioranza e liste bloccate; legge Renzi del 2015, proporzionale con correzione maggioritaria; legge Rosato del 2017, per due terzi proporzionale e un terzo maggioritaria. Nella sfera pubblica, infine, si è registrato un aumento di almeno 20 punti dell’astensionismo, una crisi della forma partito (alcuni partiti hanno esaurito i loro obiettivi, tutti i partiti hanno perso le caratteristiche di istituzioni di formazione e selezione della classe politica), un’alta volatilità dei votanti, la formazione di vere e proprie divaricazioni di saperi e competenze, e di dislivelli linguistici e culturali, un abbassamento del livello di competenza dei parlamentari, un continuo peggioramento della qualità del governo e della pubblica amministrazione, un’accentuazione del ruolo del leader piuttosto che di quello delle élite, un aumento degli istinti suicidi della classe dirigente, che si è messa da sola sul banco degli imputati, con ripetuti attacchi alla “casta”, continua enfatizzazione della sua corruzione, coltivazione dell’antipolitica. Un segno dell’atteggiamento sempre più aggressivo dell’antipolitica sta nella vicenda dei vitalizi degli eletti e in quella del finanziamento dei partiti. I primi sono stati soppressi nel 2012, ma da quel momento è continuata, con toni crescenti, una polemica diretta a sopprimere o almeno a ridurre gli assegni vitalizi già in godimento, cioè quelli precedenti. Dal 2013, poi, il finanziamento pubblico dei partiti mediante i rimborsi elettorali è stato ridotto e poi soppresso, sostituito da contribuzioni volontarie (cosiddetto 2x1000 e incentivi fiscali a donazioni private di ammontare non superiore a 100 mila euro). Le entrate dei partiti, prima dell’ammontare di 180 milioni annui, si sono ridotte a poco più di 33 milioni annui, costituiti in prevalenza da contributi degli eletti. I gruppi parlamentari godono di contributi a carico delle Camere, di ammontare superiore (complessivi 53 milioni). In conclusione, il quarto di secolo che va dal 1993 al 2018 ha posto altre premesse per i cambiamenti successivi, contribuito a “liquefare” i partiti-incubatori su cui la democrazia si era retta nel primo cinquantennio, messo sotto accusa quel po’ di élite che c’era, sviluppato la democrazia come leaderismo.
La rabbia e l’algoritmo
Ci sono momenti nella storia nei quali il precipitato di debolezze antecedenti fa massa, e – per così dire – eventi preparati nel passato ricompaiono insieme e presentano il conto ai tempi nuovi. Questo è accaduto nel 2017-2018. Le istanze populistiche erano presenti fin nella Costituzione (secondo la quale – come già notato – “la sovranità appartiene al popolo”). E’ bastato che una forza politica evocasse il mito roussoviano del potere rimesso direttamente nelle mani del popolo, aggiungendo che la diffusione di internet consentirebbe a tutti di esprimersi su tutto, perché la credenza nella democrazia diretta e nella sovranità popolare rivivesse e si dimenticasse la seconda parte della frase della Costituzione, secondo la quale il popolo “esercita [la sovranità] nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il “desiderio insaziabile di eguaglianza”, la richiesta crescente di diritti, svincolata dalle circostanze storiche, il senso della democrazia illimitata, alimentata dalla stagione dei diritti e dalle richieste giovanili e operaie del ’68 (fino agli estremi di Nanni Balestrini, “Vogliamo tutto” (1971): “Compagni, rifiutiamo il lavoro. Vogliamo tutto il potere. Vogliamo tutta la ricchezza”) hanno condotto alla richiesta per tutti di un “reddito di cittadinanza”, cioè di poter vivere senza lavorare. I trasformismi dei partiti “liquidi”, i cambiamenti di “casacca” (passaggi di parlamentari da un gruppo all’altro), la relativa chiusura dei vertici partitici, non facilmente “scalabili”, invece di suggerire l’alternanza al potere, hanno suggerito di proporre deleghe temporanee e “cambi veloci”. I modi della comunicazione sono cambiati: alla discussione nelle sedi dei partiti si sono sostituiti i talk-show e lo scambio solitario nella rete, one to one, la diffusione dei quotidiani si è in breve tempo dimezzata, gli intellettuali pubblici o sono silenti, o enfatizzano sentimenti diffusi, invece di filtrare, analizzare, valutare, ragionare.


La “lunga scivolata dell’economia italiana” ha condotto al declino relativo dell’Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei
A questi elementi risalenti ai diversi passati si sono aggiunti cambiamenti strutturali e congiunturali dell’economia. Quest’ultima non è più organizzata in stabilimenti industriali, ma articolata in global value chains. Se Ford nel 1908 poteva vantarsi di produrre tutta l’auto in una fabbrica, oggi le diverse componenti di uno smartphone sono prodotte in centinaia di paesi diversi e assemblate in un altro paese, secondo i disegni preparati in un paese ancora diverso. I clerical works, di cui vivevano una volta i ceti medi, scompaiono. Attività che una volta erano professioni diventano industria (ad esempio, quelle culturali). Molte persone sono spostate fuori del mercato del lavoro e tutti debbono prepararsi per una nuova generazione di lavori. Un sondaggio del gennaio 2018 mostra che il 54 per cento degli italiani pensa di essere in credito verso l’Italia (era il 49 per cento due anni prima), solo il 7 per cento in debito, il 35 per cento di aver avuto quanto ha dato (era il 43 per cento due anni prima). Questo è l’effetto della “lunga scivolata dell’economia italiana”, iniziata nel 1980, che ha ridotto il “senso delle possibilità” e condotto al declino relativo dell’Italia rispetto a tutti gli altri paesi europei.
Tutto questo ha accentuato l’inquietudine sociale, che ha alimentato la rabbia, il rancore, comunque il malessere, e che è stata intercettata da forze a vocazione cesaristica, interessate meno a quel che bisogna fare e più a chi accontentare (“a me non interessa la politica, interessa l’opinione pubblica”: Gianroberto Casaleggio). Le basi della società non sono scosse, ne è turbato l’animo. Sarebbe sbagliato attribuire meriti e demeriti della svolta alle due forze politiche che, sia pur minoritarie, sono riuscite a mettersi d’accordo. Le ragioni della loro vittoria risalgono a tutto il settantennio, che l’ha in qualche modo preparata. In particolare, i governi guidati dal Pd che hanno preceduto il governo affermatosi dopo le elezioni del 2018, nel tentativo di rivitalizzare la sinistra e di portare le istanze populistiche in una diversa direzione, hanno usato argomenti populistici, adoperato il potere della Borsa per finalità distributive, piuttosto che per investimenti, utilizzato lo strumento leaderistico, dimenticato il partito-organizzazione e i suoi legami con la società, insistito sul cambiamento (la “rottamazione”), enfatizzato la corruzione, addirittura creando un’apposita autorità. In questo senso, i vinti hanno aperto la strada ai futuri vincitori. Riflettendo sul crollo del mondo antico, lo storico francese René Grousset ha osservato che “nessuna civiltà viene distrutta senza essersi prima rovinata da sola, nessun impero viene conquistato dall’esterno, senza che precedentemente fosse già suicida”.









