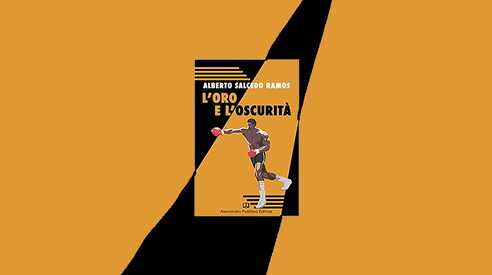
Quando la Colombia era boxe e la boxe era Pambelé
Antonio Cervantes è stato campione del mondo dei pesi welter junior dal 1972 al 1976 e dal 1977 al 1980. “L’oro e l’oscurità” di Alberto Salcedo Ramos è un viaggio alla ricerca del vecchio campione
Madrid, Spagna. Riunione di colombiani. Arriva Gabriel Garcia Marquez. C’è chi esclama: “Ecco l’uomo più importante della Colombia”. Gabo si guarda intorno: “Dov’è Pambelé?”.
Pambelé, o Pambelé Kid, è Antonio Cervantes, professione pugile, campione del mondo dei pesi welter junior dal 1972 al 1976 e dal 1977 al 1980. Centosei incontri da professionista, novantuno vittorie (quarantaquattro per k.o.), dodici sconfitte (tre per k.o.) e tre pareggi. Eppure, nato povero, cresciuto povero, Pambelé aveva cominciato come tappabuchi di cartelloni, anche se aveva fisico e classe innati. Il fisico: “Magro come un’anguilla ma solido come una roccia”, “sembrava essere in grado, nella stessa notte, di ballare il mapalé e combattere contro cinque uomini”. E la classe: “Liberava le mani con la rapidità di un fulmine e la potenza di un mortaio”, “ogni volta che assestava un colpo al sacco di sabbia da centoventi chili, lo spostava di novanta centimetri”. Ma sul ring sembrava un altro, peggiore: “Portava la guardia così aperta che incassava tutti i colpi che gli tiravano”, “quando per puro caso tirava un pugno, lo mancava nei modi più ridicoli”. Finché imparò l’arte. E cominciò a dettare legge.
Alberto Salcedo Ramos ha scritto “L’oro e l’oscurità” (Alessandro Polidori Editore, 204 pagine, 15 euro), la storia di Pambelé Kid non come biografia (anche), ma come viaggio alla ricerca del vecchio campione. Lo insegue nella tenuta di campagna della famiglia (“c’è una gallina dispettosa che disturba la siesta di un cane pigrone, una bicicletta appoggiata a un albero e un pallone da calcio”), fra le testimonianze di moglie e figli, nuore e nipoti (“Ricordo che papà rompeva un televisore al mese, quando dava di matto, e poiché a quel tempo aveva ancora soldi, andava il giorno dopo in qualche magazzino e ne comprava uno nuovo”), fra le ricostruzioni di giornalisti e allenatori (“lo speaker Napoleon Perea sale sul ring e urla che non ce n’è, signori, questo campione ormai si avvicina ai trentatré anni, l’età in cui è morto Cristo, ma ci ha appena regalato un concerto di boxe”), fra i ricordi di compagni e avversari (“anche come persona – aggiunge dopo una pausa – è il massimo, sempre che sia sobrio. A volte, quando gli pagano la pensione, viene in palestra verso mezzogiorno e fa portare il pranzo per i pugili che si stanno allenando”).
Pambelé Kid conosceva la polvere: “Era completamente al verde. I suoi pantaloni e le sue camicie si potevano contare sulle dita di una mano. Si allenava senza fare colazione. Camminava sempre a piedi, perché non aveva soldi per l’autobus. Se pranzava non cenava, e viceversa”. Poi salì sull’altare: “Qualcuno, convinto che la sua vittoria per k.o. su Alfonso Peppermint Frazer fosse frutto di un colpo di fortuna, vaticinò che sarebbe stato un campione effimero, seduto su un trono di carta che sarebbe volato via con la brezza più lieve. Ciononostante, Pambelé vinse la sua prima difesa del titolo, poi la seconda. Continuò ad annichilire gli sfidanti, fino a imporre la più ferrea dittatura mai vista nella categoria delle centoquaranta libbre. Da pugile maldestro si era ormai trasformato in un giustiziere implacabile, una macchina da demolizione senza crepa alcuna”. Era il risultato di una straordinaria disciplina: “Se il piano di allenamento prevedeva otto riprese al giorno, lui le combatteva tutte, anche con pioggia, tuoni e fulmini. Se si era detto sei chilometri, correva sei chilometri, né quattro né cinque. Se l’allenatore gli diceva che per perfezionare il gancio sinistro doveva tirarlo ripetutamente per mezz’ora, lui lo tirava per quarantacinque minuti. Non lasciava mai i compiti a metà, non rimandava mai a domani ciò che andava fatto oggi”.
Ma la boxe non fa sconti. Pugni, donne, alcol, droghe, altro. Oggi Pambelé Kid, settantatré anni, vive ossessionato, obnubilato, mai però dimenticato: “Fu la vetta a fargli girare la testa. Ad alcune persone il passaggio da struzzo ad aquila può creare danni. Lassù si può perdere la prospettiva, la nozione di realtà diventa distorta. Un giorno tendi le braccia, inspiri aria fresca e sei certo che, in effetti, non c’è una sola nuvola fra te e il Cielo. Inizi a credere di essere il Signore del Giorno e della Notte, anzi, il Cielo stesso. Perdi piano piano la messa a fuoco. Vedi troppo piccolo il mondo che hai sotto di te, ma sei in un punto dove non hai più margine per continuare a salire. Rimani in cima, è vero, ma a chi dai del tu, se nessuno è al tuo livello?”.
La boxe – ring, ma anche film e libri - libera un fascino irresistibile. Come se custodisse il meglio e il peggio della vita. Salcedo Ramos racconta la sua indagine, adeguandosi: neanche lui, stavolta, fa sconti.





