
Illustrazione di Francesco Guarnaccia (tutti i diritti riservati)
Non è cricket! (È molto di più)
Con questo sport i gentlemen inglesi si sono avvicinati ai workers e poi hanno modellato il comportamento dei nativi nelle colonie. Fino a quella partita del 30 gennaio 1960 che cambiò tutto
A me interessa guardare al fascino del cricket in quanto intreccio indissolubile fra sport e politica, idea di un confine e, insieme, del suo superamento. Il campo da gioco, infatti, è un ovale delimitato non da una striscia di gesso tracciata sul terreno – come per il tennis, il calcio, il rugby – ma da una barriera più concreta, una corda posata sull’erba. Il colpo più efficace per la squadra alla battuta consiste proprio nel mandare la palla oltre il confine del campo (segnando così automaticamente quattro o sei runs) e viene denominato, nel meraviglioso gergo del cricket, a boundary.
Le premesse sono quasi finite: mettete insieme i tre presupposi (sport, politica, confini) e capirete come questa disciplina ci offra una chiave d’accesso privilegiata per parlare di un modo di stare al mondo che il cricket ha insegnato a partire dall’Inghilterra pre-vittoriana, rotolando in tutti quegli angoli del pianeta dove l’Impero britannico è riuscito ad arrivare. Capito perché tre miliardi di tifosi?
Serve ancora una cosa, l’ultima, portate pazienza: una guida, qualcuno che abbia competenza, quella che noi, con le nostre lenti mediterranee, non possediamo. Un faro, un riferimento, un Virgilio che ci orienti in questo viaggio. Zero dubbi: questo ruolo spetta di diritto a un libro che è un vero capolavoro e che nel 2005 un sondaggio del giornale inglese The Guardian ha giudicato “il terzo miglior scritto di argomento sportivo mai scritto”. Ecco, state già pensando a quali sono i primi due? No, restiamo concentrati sul cricket, ne varrà la pena. Questo libro monumentale lo ha scritto un intellettuale filo-marxista di Trinidad, Cyril Lionel Robert James, e il suo lavoro in lingua originale si intitola Beyond a Boundary, titolo tradotto in italiano con Giochi senza frontiere. Del cricket o dell’arte della politica (CasaDeiLibri Editore, 2006). James scrive un saggio, che in realtà ha molto a che fare con il racconto autobiografico, raccontando del valore culturale, estetico, sociale e politico del cricket nel contesto della cultura britannica e nel processo di emancipazione e autodeterminazione di Trinidad e delle West Indies.


È lo sport più seguito al mondo dopo il calcio. Oltre 3 miliardi di tifosi stanno seguendo il Mondiale in questi giorni
Il cricket, codificato nelle sue regole fondamentali tra il 1778 e il 1830 allo Hambledon Club, nella campagna dell’Hampshire, non aveva nulla di vittoriano, nel senso tradizionale del termine. Contegno, rigore morale? Proprio no, le partite erano un fatto popolare, i cricketers non disdegnavano il buon vino, cantavano canzonacce sguaiate e scommettevano pesanti somme di denaro, con l’inevitabile conseguenza che molti match fossero truccati. Insomma, tutt’altro che senso della misura e fair play. La middle class vittoriana, che quel gioco non aveva per nulla partecipato a costruirlo, pensò che appropriarsene sarebbe stata un’operazione strategicamente perfetta. Una sorta di avvicinamento ai propri workers, per potersi prudentemente contaminare o, meglio, offrire loro un’occasione di migliorarsi un po’. Così negli anni in cui Thomas Arnold, preside della Rugby School, insegnava valori morali, buone maniere e timore di Dio attraverso l’istruzione e il gioco della palla ovale, anche il cricket scalò le classifiche di importanza nei curricula scolastici.
Si diffuse la Muscular Christianity e lo sport diventò strumento per inculcare nei giovani inglesi valori quali disciplina, altruismo, senso dell’onore, spirito di sacrificio, capacità di accettare vittorie, sconfitte e decisioni arbitrali. L’operazione di ripulire il cricket dalle sue grezze origini raggiunse il culmine con il conio di un meraviglioso virtuosismo linguistico: “It isn’t cricket” diventò il modo per dire: “Non è leale”. La lingua stava strutturando la realtà. Terminato il suo processo di nobilitazione sul mercato interno, il cricket era pronto per partire alla conquista del mondo. Nel 1862 la prima rappresentativa di cricketers si imbarcò verso l’Australia, ma serviva sistemare un altro dettaglio: trovare un campione che diventasse icona mondiale di quello sport e dei suoi valori. Non fu difficile. Un ragazzo nato nella campagna del Gloucestershire, origini umili a sufficienza, diventò il più grande eroe popolare della sua epoca: si chiamava William Gilbert Grace (e forse perfino quel cognome fu funzionale). Grace era perfetto per lo scopo, il suo cricket prevedeva il rispetto di una rigidissima gerarchia, metafora ideale della necessità di mantenere una altrettanto rigida struttura della società. In campo ci si andava divisi in due distinti gruppi: i gentleman, sportivi per puro piacere e diletto, e i professional players, provenienti dalle classi lavoratrici che per giocare dovevano essere pagati. I gentlemen ricoprivano il ruolo più nobile, quello di battitore (batsman), mentre ai professional players erano assegnati ruoli secondari, ossia quelli di bowler (lanciatore) e fielder (chi afferra la palla e la rilancia verso il wicket, i paletti difesi dal battitore avversario). Naturalmente, il ruolo di capitano – indiscusso leader della squadra, colui che decide la formazione, l’ordine dei giocatori al lancio e alla battuta e tutte le strategie tattiche – era esclusiva dei gentlemen. I giocatori erano fisicamente divisi, si cambiavano in spogliatoi distinti, alloggiavano in hotel differenti ed entravano in campo attraverso porte separate.
Non c’erano più dubbi, il cricket stava diventando per la Gran Bretagna merce ideale da esportare: permetteva agli inglesi di sentirsi a casa anche nelle terre più lontane dell’Impero e inculcava nei nativi, grazie all’azione lubrificante dell’essere uno sport, valori e comportamenti necessari per mantenere una società, diciamo così, ordinata. James dimostra tutto ciò nella sezione più autobiografica del libro, attraverso il racconto di sé bambino e delle sue tre grandi passioni: la Bibbia, la letteratura inglese e gli articoli sul cricket, attività che per le quali un nativo di Trinidad non avrebbe certo dovuto avere una naturale propensione.
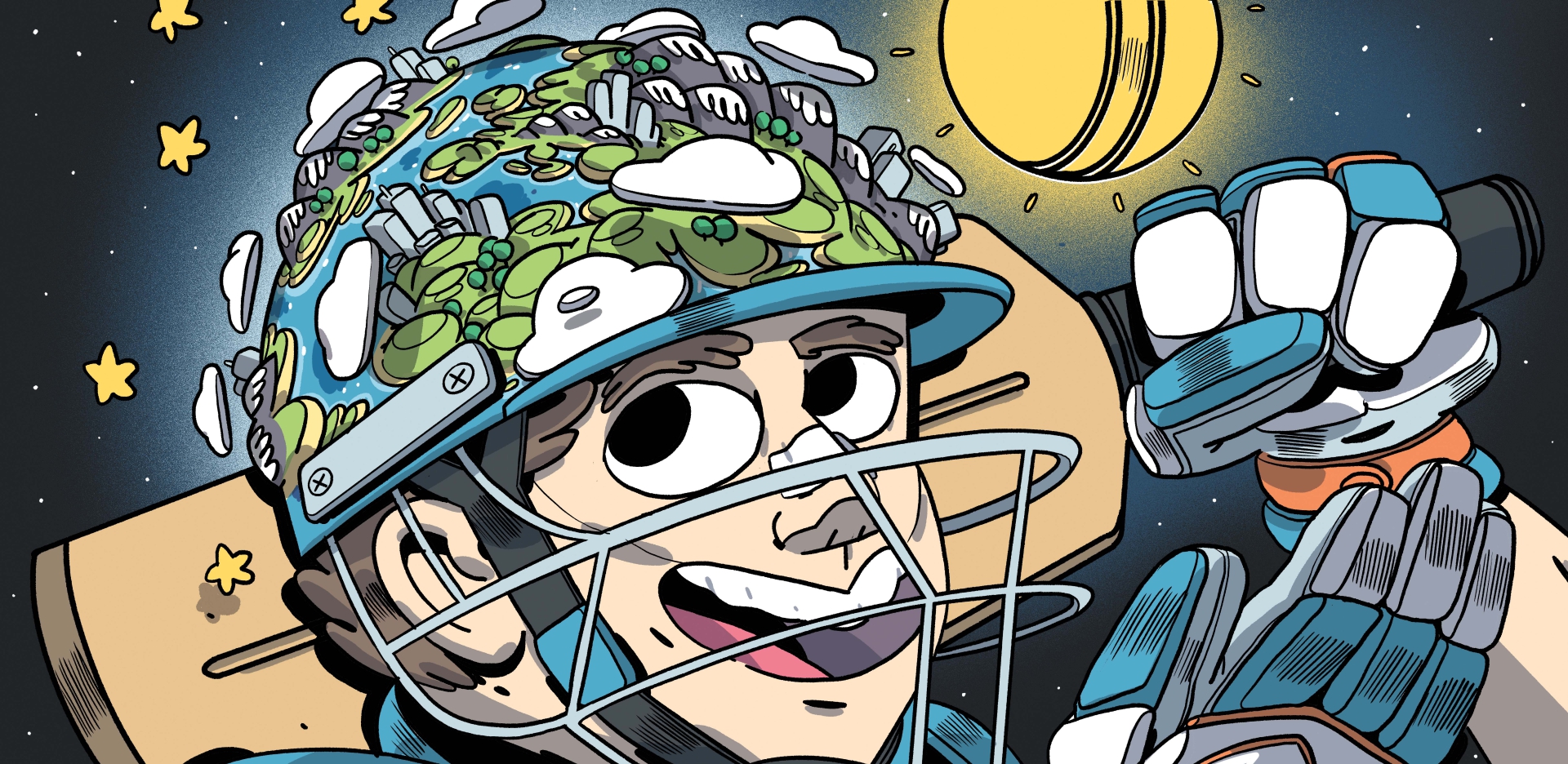
Illustrazione di Francesco Guarnaccia. Guarda qui tutte le altre illustrazioni del Foglio Sportivo
Attraverso il cricket gli inglesi modellavano il comportamento dei nativi nelle colonie nei quattro angoli del mondo, lasciando loro, conquistati sul territorio e nel cervello, un’ultima geniale possibilità: battere gli inglesi nel loro gioco! Dalle isole caraibiche alle colonie orientali il cricket stava diventando, consciamente o meno, uno strumento di resistenza. Se, come James sostiene, il cricket e il calcio, molto più di musica o arte, sono state le due più grandi influenze culturali esportate dai britannici, gli sportivi diventavano apprendisti politici che potevano sfidare i colonizzatori quando i leader indipendentisti non riuscivano ancora farlo.
Nel 1935 le West Indies vinsero la loro prima partita a Trinidad contro l’Inghilterra e nel 1950 riuscirono a farlo anche sul suolo inglese. In una crescente necessità di confronto e, soprattutto, con una questione di colore della pelle da risolvere (nessuno si era ancora posto la domanda del perché ottimi giocatori colored dovessero necessariamente avere un capitano bianco) si arrivò a una partita storica, giocata il 30 gennaio 1960 a Port of Spain, Trinidad. Un test match fra West Indies e inglesi venne interrotto per le violente proteste del pubblico, con lancio di bottiglie in campo, a causa della decisione dell’arbitro locale di considerare eliminato il battitore caraibico Singh.


Una forma d’arte a tutti comprensibile e accessibile, uno spettacolo drammatico come il teatro, la danza
Il sentimento che gli antinazionalisti locali (il direttore di gara era un nativo) tramassero al fine di favorire gli inglesi e umiliare i giocatori indigeni, deflagrò improvvisamente sulla base di una decisione arbitrale. Ormai la misura era colma, ciò che succedeva in campo collideva con quel “It isn’t cricket”, non c’era più nulla di percepito come leale. La miccia la accese James (che giocava e scriveva di cricket) incominciando una campagna stampa a favore dell’elezione a capitano del colored Frank Worrel, a discapito del bianco Alexander e non perché fosse nero, ma semplicemente perché migliore nel gioco e nelle qualità richiesta a un capitano.
Il dado era tratto, la rivoluzione culturale era partita e la svolta marxista di James anche, ma tutto ciò non gli impedì di dedicare un capitolo intero, meraviglioso, al rapporto fra sport e arte, che culmina in una visione: il cricket, secondo James, è una forma d’arte accessibile e comprensibile a tutti, uno spettacolo drammatico esattamente come il teatro, la danza, l’opera. All’inizio del suo libro James ne offre la prova, parlando di un suo vicino di casa, Matthew Bondman, ragazzo sbandato, volgare e aggressivo in ogni aspetto della sua vita, ma che, sul campo, acquisiva magicamente grazia e stile. Matthew, secondo la nonna dell’autore, “un buono a nulla, tranne che per il cricket”, acquistava credibilità e rispettabilità solo sul campo di gioco. Il cricket è dunque per James uno spazio sul quale costruire una metodologia di approccio sociopoetica, qualcosa in grado di offrire un’esperienza estetica, ma che ha anche una profonda responsabilità sociale e rilevanza politica. Altro che, come sosteneva Trotzky, strumento di distrazione dei lavoratori! Insomma: andiamo a vedere come è finita Bangladesh-Afghanistan?

L'exception française




