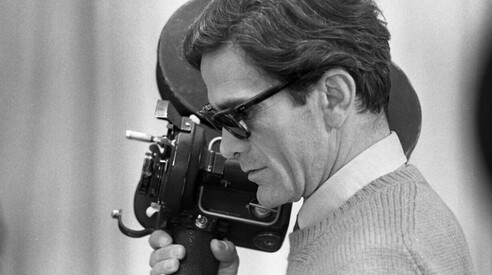LaPresse
Piccola Posta
La meritocrazia come concetto assoluto nuoce alla democrazia. Un libro
Il professore Paquale Terracciano ripercorre dall’origine il corpo a corpo fra il proposito di riconoscere a ciascuno il suo merito e le forme ideologiche o ingannevoli con cui il criterio si presenta. Naturalmente il luogo principe del cimento del merito è la scuola
Nel 1959 Santo Mazzarino pubblicò un libro prezioso sulla “Fine del mondo antico”. Della rassegna di interpretazioni mi colpì soprattutto la formula di uno storico tedesco sulla “selezione alla rovescia”. Si capisce che influisse un darwinismo, ma la rivelazione stava nell’idea che il mondo, un mondo, potesse andare a rotoli perché la sua classe dirigente non veniva più scelta fra i più meritevoli ma fra i più inadatti – i peggiori. Così, Darwin e Spencer a parte, quella formula non fa che tornarmi in mente, allo spettacolo dei titolari delle sorti del mondo contemporaneo. Al quale per giunta si era attribuita la qualifica di meritocrazia. Non una generica discussione sul merito, ma la sostituzione – il progresso – della democrazia con la meritocrazia. Suona sarcastico, no? Donald Trump e il potere del merito. Dunque mi sono tuffato nell’esauriente studio di Pasquale Terracciano, “I capaci e i meritevoli. Storia filosofica del merito” (Marsilio, 2025, pp. 303). Terracciano (1981), normalista, docente a Roma Tor Vergata, ripercorre dall’origine il corpo a corpo fra il proposito di riconoscere a ciascuno il suo merito e le forme ideologiche o ingannevoli con cui il criterio si presenta. Una partita che non si chiude con una vittoria e una sconfitta e però nemmeno con una tregua sine die, bensì con lo sforzo di regolarne via via il rapporto reciproco. Naturalmente il luogo principe del cimento del merito è la scuola. Fra le prime mosse di Trump c’è la correzione di tutte le politiche DEI (Diversity, Equity and Inclusion), come a Harvard, a favore di quelle MEI (Merit, Excellence and Intelligence): e abbattere così qualsiasi quota in favore di chi parte svantaggiato. E’ comunque un connotato comune delle destre mondiali, e non solo: la meritocrazia era la parola d’ordine della campagna di Blair nei 90.
Terracciano affronta il merito come si affronta una parola che ha fatto carriera, e perciò porta con sé un carico di equivoci. Non la assume come un valore autoevidente, né come una colpa originaria, ma come un concetto mobile, che cambia significato insieme alle società che lo invocano. Il suo libro procede al passo della ricostruzione genealogica, poi della presa diretta sulle fratture politiche del presente, e di una proposta normativa. Il punto di partenza è quasi filologico. “Merito” non designa una qualità naturale, ma una relazione: Aristotele lo legava alla virtù, e dunque a una disposizione morale riconosciuta dalla polis; l’umanesimo lo intendeva come eccellenza al servizio della comunità. In entrambi i casi il merito non era separabile dall’idea di bene comune. La modernità rompe questo nesso. Il merito si emancipa dalla virtù e si lega al talento, e soprattutto al talento misurabile. E’ qui che nasce la meritocrazia come progetto politico: carriere aperte ai talenti, selezione dei migliori, promessa di mobilità sociale. Ma è anche qui che il merito cambia di segno. Da criterio tra altri diventa principio ordinatore, e pretende di giustificare gerarchie, disuguaglianze, successi e fallimenti.
La parola venne consacrata, nel 1958, da un gran romanzo distopico, “L’avvento della meritocrazia” di Michael Young. Young immaginava un’evoluzione che culminava nel 2033 – ci siamo quasi – in cui la selezione per merito, nata per correggere l’arbitrio delle élite ereditarie inglesi, finiva per svuotare la democrazia. In una società però ormai ossessionata dall’intelligenza e dalla prestazione, gli svantaggiati si ribellano, sostenuti dalle donne più intelligenti, transfughe dal loro stesso privilegio. (Il primo testo che ha il merito nel titolo è di una veneziana, Moderata Fonte, “Il merito delle donne”. Finisce di scriverlo nel 1592, a 37 anni, appena prima della sua morte per parto). Il romanzo era una satira, ma conteneva già una diagnosi: una società che si pensa giusta perché seleziona i migliori rischia di perdere ogni linguaggio della dignità.
Il Novecento prende sul serio la promessa. La società post-industriale, la centralità dell’istruzione, il capitale umano: tutto concorre a fare del merito intellettuale il criterio dominante. Specie dopo il 2008 c’è stata un’enfasi crescente sulla parola meritocrazia, e peraltro mentre quelle promesse sembravano incagliarsi moltissimi testi hanno avvertito che le promesse dell’istruzione servono semplicemente a nascondere un privilegio di origine. I normalisti a Parigi sono essenzialmente figli di normalisti. A Pisa magari è diverso – o era. Fino a un po’ di anni fa la maggioranza dei normalisti erano figli di insegnanti, di famiglie in cui lo studio era riconosciuto come un modello di ascesa sociale, e con il vantaggio di avere libri a casa. Oggi forse prevale una provenienza famigliare e regionale benestante. A Firenze, pare, le 15 famiglie più in vista sono le stesse dal 1400. E’ nel contesto politico che Daniel Bell, nel “Modello Cina” (2015), arriva a interrogarsi provocatoriamente sulla capacità delle democrazie liberali di selezionare classi dirigenti competenti. Una democrazia che produce fenomeni alla Trump – suggeriva – è davvero più funzionale di sistemi che, come quelli asiatici, selezionano i governanti attraverso percorsi lunghi, competitivi, tecnocratici? Bell non nascondeva la natura autocratica di quei modelli, una sorta di mandarinato moderno, ma metteva il dito su una ferita: lo sfaldamento delle capacità di filtro della democrazia occidentale. Perché in quel contesto il merito finisce per coincidere con la disponibilità di vantaggi economici e culturali che ti includono a priori e ne escludono altri. Non è il talento a essere selezionato, ma la sua certificazione sociale.
Un neonato abbandonato merita di essere aiutato? Naturalmente non lo merita, ne ha bisogno: e se una società si reputa decente aiuta un neonato abbandonato, non perché abbia dei meriti ma perché non ha altra difesa. Non lo aiuta per un investimento differito, l’eventualità che ne venga fuori un genio. Può succedere, ma non è la probabilità. Ma anche la più volgarmente meritocratica delle posizioni non dev’essere interessata ad allargare il serbatoio dentro il quale pesca? Il merito richiama biografie di questo tipo: o figli di ex campioni Nba, perché tuo padre è alto 2 metri e 25, o LeBron James, figlio di una ragazza madre, che non ha mai conosciuto il padre… (LeBron James ha pagato gli studi a ragazzi neri disagiati davvero nell’ordine di decine di migliaia). Nelle pagine finali Terracciano propone di ricucire il legame fra merito e responsabilità, sottraendo il primo alla logica dell’autolegittimazione. Il merito va riconosciuto ma sottratto alla pretesa di giustificare tutto; non un titolo di proprietà sul successo, ma un criterio situato, limitato, reversibile. Il merito è una legittima arma per chi non ne ha altre, e però i suoi nemici sono proprio quelli che lo esaltano come modello su cui fondare tutta la società. Il cui contraccolpo è la percezione del merito tradito da trame opache… Si è gravato il merito di un peso che non poteva reggere, e per ripristinarne una legittimità bisogna delimitarlo. Rafforzare il legame con la responsabilità.
Un filosofo politico, Michael Sandel (1953) che ha scritto “La tirannia del merito”, 2021, interpreta la vittoria del primo Trump con il rancore: non sono i ricchi, sono quelli senza il diploma di laurea che lo votano. (Lui è professore a Harvard). Poi c’è la questione dell’intelligenza artificiale, che incombe come una smentita radicale. Se una parte crescente delle prestazioni intellettuali viene automatizzata, che ne è del merito fondato sull’intelligenza misurabile? Se ciò che ci ha garantito riconoscimento e posizione viene replicato da una macchina, la gerarchia vacilla. Forse si aprirà un nuovo spazio per redistribuire secondo altri criteri, forse no. Ma è difficile immaginare che la meritocrazia, così come l’abbiamo conosciuta, ne esca intatta.
Il primo libro di Kurt Vonnegut, “Player Piano” (Piano meccanico), del 1952, immaginava anche lui una città meritocratica divisa, sulle due rive del fiume, coi tecnici che hanno sostituito tutti gli operai perché sono riusciti a ricrearne i movimenti con le macchine: bastano tre tecnici per tirare avanti la fabbrica. Il padre spiega al figlio una rudimentale intelligenza artificiale che batte a scacchi il tecnico più bravo. Il figlio si arrabbia e la fa distruggere. Gli insorti perdono, ma ci hanno provato.