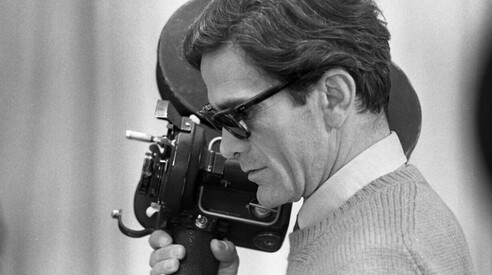LaPresse
Piccola Posta
I mille volti di Vladimir Putin
Da personaggio in cerca d'autore a padrone della Russia. Michael Thumann, corrispondente della Zeit e spesso inviato a Mosca, ricostruisce la genesi e lo sviluppo delle mire dell'autocrate che ha dato vita al "regime più minaccioso del mondo"
Michael Thumann (1962) è corrispondente per gli esteri della Zeit, ha studiato a Mosca ed è stato ripetutamente inviato in Russia. Il suo libro ora tradotto da Castelvecchi, Vendetta. Come Putin ha creato il regime più minaccioso al mondo (trad. di Massimo Ferraris, 270 pp., 22 euro), ricostruisce efficacemente l’ascesa politica e le mutazioni personali del padrone della Federazione russa. Il testo si ferma al 2023, ed è più ricco per l’anno precedente, in cui fu scritto per la gran parte, dal febbraio dell’invasione dell’Ucraina al settembre della mobilitazione e dell’annessione delle regioni parzialmente occupate alla madrepatria, con la quale Putin si lega ostentatamente le mani rispetto a un compromesso negoziale, prima che lo faccia, in risposta, Zelensky.
Singolarmente, il volume non ha alcun aggiornamento dell’autore né un avvertimento dell’editore, sicché se ne deduce la data procedendo nella lettura, nel punto in cui si rinvia al risultato eventuale delle elezioni americane del 2024 – “potrebbe tornare…” – dove il lettore tira un dolente sospiro, salvi improperi più rumorosi. Mancano dunque, oltre alla rielezione di Trump, la morte di Naval’ny – alla cui figura è dedicata una adeguata attenzione – la portata della mancata controffensiva dell’estate del ’23, dopo il successo spettacolare di quella dell’anno prima, a Kharkiv e a Kherson, l’impresa effimera del Kursk, e soprattutto il cambiamento del contesto internazionale, che ha tratto Putin e la Russia dall’isolamento fino a celebrarne un’accoglienza sontuosa sul divano oriental-occidentale. Tuttavia questa sfasatura cronologica contribuisce a suo modo alla riflessione e al bilancio della guerra all’Ucraina, mettendo di fronte, con le due prospettive mutate, gli errori e le colpe che le hanno segnate. Una sopra tutte: la scommessa di Putin sul ritorno del suo uomo alla Casa Bianca, escluso ottusamente dagli attori decisivi, i fautori ostinati della ricandidatura di Biden. Donde lo Zelensky dello Studio Ovale, il Putin d’Alaska e i trionfi di Pechino.
Thumann racconta un Putin in cerca d’autore, di fronte a una crisi di consensi, alla fine del 2011 e al momento del ritorno alla presidenza del 2012, che gli fa temere di perdere la sola cosa cui incrollabilmente tenga, il proprio potere, e lo trova nella risorsa di tutti i dispotismi, il nazionalismo. L’autore è particolarmente attento alle vicende della fornitura di gas ai paesi europei, che gli riservano una fiducia e una simpatia crescenti – “il nostro uomo al Cremlino” – negli anni stessi in cui fa terra bruciata della Cecenia e poi di Aleppo, fino alla Crimea, e intanto regola, ben prima dell’aggressione all’Ucraina, i rubinetti dei gasdotti sulla dipendenza dei clienti. Fra i quali comprensibilmente Thumann ha soprattutto di mira i suoi connazionali, e il campione della passione sviscerata per Putin, Gerhard Schröder, da cancelliere prima e poi da oligarca adottivo – del resto adottò anche due bambini russi; passione di cui avemmo il nostro campione, ma almeno Berlusconi era ricco di suo. La dipendenza tedesca dal gas russo passò dal 38 per cento del 2012 al 55 per cento del 2021. (C’è una reticenza in Thumann sull’attentato al gasdotto Nord Stream 2, probabilmente dovuta all’incertezza, oggi superata dagli inquirenti tedeschi, mentre resta sospeso il giudizio sul rapporto fra un delitto e un’azione di guerra).
Thumann ricostruisce dal Trattato di Rapallo, 1922, che sancì con la firma riluttante di Rathenau, assassinato di lì a poco, la relazione privilegiata fra Germania e Russia sovietica, la peripezia di attrazione e repulsione fra i due paesi, non tanto diversa, fatte le proporzioni, da quella fra Russia e Italia, un cui deposito penoso sta nella comune propensione alla simpatia per il dispotismo russo gabellato per nostalgia dell’anima russa. “A cosa serve un mondo in cui la Russia non esiste?”. Non è una domanda di Paolo Nori, è di Putin, ed è stata pronunciata per motivare il ricorso a una catastrofe nucleare.
Non si è notata abbastanza l’affinità fra il rimpianto “comunista” per il muro di Berlino e l’umorismo di Andreotti sul suo amore per la Germania, “tant’è vero che ne vorrei due”. Putin, insiste Thumann, passa sopra l’economia quando sia in gioco l’espansione del suo potere. “Dal 2012, o al più tardi dal 2014, ha assunto quasi esclusivamente decisioni contrarie agli interessi economici del suo Paese”. Ciò che lo metterebbe agli antipodi del suo pupillo americano. E spiega come il suo ritorno all’Urss e allo stesso stalinismo prescinda interamente dal “socialismo” e si riduca al potere imperiale – e al suo nocciolo: il territorio.
Combinando la storia all’esperienza sociale dei lunghi soggiorni in Russia, Thumann offre un quadro interessante dei controversi anni 90, ripudiati dalla maggioranza dei russi come un’età di impoverimento, caos e umiliazione, e rimpianti da una minoranza come l’irruzione delle libertà, di movimento, di parola, di pensieri. Il Putin che ci aveva fatto dentro il nido se ne farà vendicatore, ed è divertente che qualcuna delle comparse che vi agirono da sperimentatori in corpore vivi e vili, come Jeffrey Sachs, gli si siano accodati con l’entusiasmo dei pentiti. Del resto, prima di chiedersi con stupefazione come possano simpatizzare way of life opposti come il russo e l’americano, ci si deve chiedere come si siano chiusi gli occhi davanti alla realtà.
L’incendiaria crociata sull’odio del dopo Kirk ha trascurato l’introduzione nel codice russo del misterioso reato di “odio politico”, da aggiungere all’odio nazionalista, antireligioso, razzista… Semplicemente – no, non “semplicemente” – sembrava esserci nel way of life americano un’onda impetuosa di progresso, inarrestabile, fatta di mille minoranze ma maggioritaria e padrona del futuro, cui corrispondeva una tendenza analoga nelle grandi città russe, autorizzata dalla libertà inaudita dei Novanta, e restata comunque minoritaria e paga di tenersi nelle riserve, sapendosi incapace di misurarsi col potere, se non in veri eroi, Nemcov, Politkovskaja, Naval’ny… L’una e l’altra sono state schiacciate, negli Usa con un rovesciamento che si pretende come la rivelazione del paese profondo fanatico superstizioso dunque vero, a costo dello stato di diritto, in Russia con la repressione e l’esaltazione fomentate dallo stato di guerra, negli uni e nell’altra con lo stesso linguaggio ipocrita, bigotto e sfrontato.
Thumann dedica molte puntigliose pagine al presunto impegno occidentale a non allargare a est la Nato dopo la riunificazione delle Germanie e la fine dell’Urss. E ricorda che una buona parte delle pretese promesse di non allargamento sarebbero state assurdamente formulate prima del febbraio 1991, quando cioè era ancora in vigore il Patto di Varsavia. E nel 2004, tre giorni dopo l’ingresso nella Nato di Estonia, Lettonia e Lituania, i paesi baltici confinanti con la Russia (la Polonia, a sua volta confinante con l’exclave di Kaliningrad, era entrata nel 1999, e la confinante Norvegia c’era da sempre, la Finlandia, la più confinante di tutti, ci è arrivata per la guerra, un vero affare) in una conferenza congiunta col cancelliere Schroeder, Putin disse: “Per quanto riguarda l’allargamento della Nato, non abbiamo preoccupazioni sulla sicurezza della Federazione russa”.