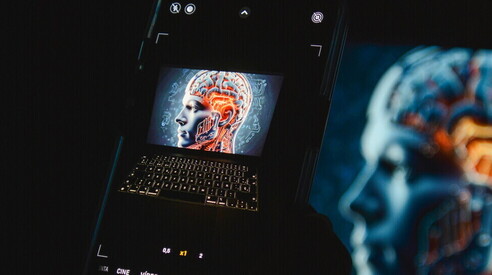
L'editoriale del direttore
Abbiamo ancora buone carte da giocare per governare l'AI
Dalla stagione del “se” (se usarla o no) a quella del “come” (come utilizzarla e trarne vantaggio). L’intelligenza artificiale cambierà il lavoro e forse ci supererà in molte cose. Ma saremo noi, con la creatività e il senso del limite, a decidere dove fermarla
Cerchiamo di distrarci, ma non sempre ci riusciamo, e alla fine dei conti il nostro pensiero, nei ritagli di tempo, finisce lì. Su quelle due lettere che ci hanno fatto impazzire, che continuano a farci divertire e che misteriosamente continuano a essere utilizzate, dalla stampa italiana, come se fossero un accessorio, come se fossero un giochino per passare il tempo, come se fossero un tamagotchi al servizio della modernità. Due lettere: AI. L’intelligenza artificiale, come sapete, è entrata a gamba tesa in questo giornale a marzo (gamba tesa è un’espressione giornalese che il nostro programma di intelligenza artificiale non userebbe mai, troppo banale, ma ogni tanto dobbiamo dare prova della presenza dell’essere umano) quando è finita ogni giorno in pagina con il nostro formidabile Foglio AI, che dopo l’esperienza quotidiana è diventata un’esperienza settimanale, sempre di quattro pagine, con le quali ci divertiamo a informare con l’intelligenza artificiale, a usare l’intelligenza artificiale per parlare di intelligenza artificiale, a utilizzare l’intelligenza artificiale per dare voce all’intelligenza artificiale e a capire verso quale direzione va il dibattito, che in Italia non c’è, sul futuro dell’AI.
In Italia, e in Europa, l’intelligenza artificiale, il nostro tamagotchi, trova spazio sui giornali per ragioni legate allo strano ma vero. In giro per il mondo, negli ultimi tempi, il dibattito sull’AI ha preso una piega diversa, che ha permesso di fare un salto lontano dalla stagione del “se” (se usarla o no) e che ha permesso di fare un passo nella stagione del “come”: come utilizzarla, come vivere con, come governarla. Lo spunto più interessante da cui partire, quello che ha innescato negli ultimi tempi un dibattito gustoso, ampio, profondo sulla stampa internazionale è quello che è scaturito in seguito a uno studio condotto dai ricercatori del Media Lab del MIT. Lo studio si chiama “Your Brain on ChatGPT” e analizza cosa succede al nostro cervello quando scriviamo con o senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Su un campione di 54 studenti, i ricercatori hanno confrontato tre condizioni: scrivere un testo da soli, scriverlo usando un motore di ricerca o con l’aiuto di ChatGPT. I risultati sono stati netti: chi usa l’AI mostra una drastica riduzione dell’attività cerebrale rispetto a chi scrive autonomamente, chi scrive i testi prodotti con ChatGPT spesso non ricorda nemmeno che cosa ha scritto, la qualità degli scritti prodotti con AI cala in originalità e varietà semantica e chi scrive prima con ChatGPT e poi prova a farlo da solo vede i risultati della sua scrittura peggiorati, mentre chi prima scrive da sé e poi usa l’AI per rivedere migliora i propri risultati.
Dunque, avete capito il punto: oltre che portarci via posti di lavoro, l’intelligenza artificiale porterà via ciò che resta della nostra intelligenza? Per provare a rispondere a questa domanda abbiamo trovato spunti di riflessione utili in due ragionamenti formidabili. Il primo lo ha messo nero su bianco sul New York Times Robert Capps, giornalista esperto di tecnologia, che ha offerto qualche spunto utile su come mettere la nostra intelligenza al servizio delle trasformazioni future. Il secondo lo ha messo insieme, in un discorso all’Union College, Joanna Stern, una giornalista del Wall Street Journal esperta anche lei di tecnologia. La tesi di Capps è questa: in un futuro dominato dall’intelligenza artificiale, i lavori umani non scompariranno, ma cambieranno radicalmente, e l’intelligenza naturale dovrà essere preservata, e autopreservata, su tre aree cruciali, non replicabili: fiducia, integrazione e gusto. Serviranno figure, dice Capps, capaci di garantire la responsabilità (come AI auditors, verificatori e “traduttori” del linguaggio tecnico), perché l’output dell’AI, per quanto efficace, richiede validazione umana. Saranno poi fondamentali professionisti capaci di integrare l’AI nei processi aziendali, con ruoli nuovi come plumber, trainer o assessor, che sappiano risolvere guasti e adattare i modelli alle esigenze. Infine, conterà sempre di più il gusto umano: scegliere, selezionare, progettare. Sarà il tempo dei designer dell’identità, delle storie, dei servizi.
La Stern, invece, ha ragionato sul futuro con una chiave diversa, tornando al punto di partenza. Spiegando una questione centrale: come vivere al fianco di queste macchine. E lo ha fatto suggerendo cinque regole per vivere e prosperare in un mondo di intelligenza artificiale. Regola numero uno: essere un essere umano creativo. Per dimostrare cosa significa, la giornalista ha offerto agli studenti due esempi. Una canzone realizzata interamente con l’intelligenza artificiale e una canzone intonata da una cantante. Se si ascoltano i testi, dice, ci si rende subito conto che questo robot non ha mai passato la notte in bianco, non ha mai ballato con i suoi migliori amici, non si è mai sporcato le mani: non suda. L’intelligenza artificiale è uno strumento utile, ma manca di anima ed esperienza umana. A quella canzone dell’intelligenza artificiale mancavano il cuore, le sfumature, la verità della vera narrazione. Ciò che ci distingue dall’intelligenza artificiale sono le emozioni, la creatività e la vulnerabilità. Regola numero due: imparare per tutta la vita. “Quando ho chiesto a Sam Altman, ceo di OpenAI e creatore di ChatGPT, quale consiglio avesse per tutti voi, ecco cosa mi ha risposto: ‘Diventate bravi a usare gli strumenti di intelligenza artificiale e concentratevi sull’apprendimento di abilità come l’adattabilità, la resilienza e la capacità di capire cosa vogliono le altre persone in un mondo in rapida evoluzione’. Non dovete sapere esattamente cosa vi aspetta, ma dovete continuare a imparare ed essere pronti a costruirlo”. Terza regola. Essere un cercatore di verità. Viviamo in un’epoca di falsi profondi, fatti allucinati, bot fuorvianti ma sicuri di sé e, siamo onesti, di leader che gridano alle fake news ogni volta che c’è qualcosa che non gli piace. “Che si tratti di un articolo, di una risposta di un chatbot o di un TikTok che afferma che la vostra celebrità preferita è morta, chiedetevi: chi ci crede? A chi giova se ci credo? Non prendete per buono ciò che vedete, e non escludetelo nemmeno. Gli algoritmi hanno già creato delle camere d’eco in cui sentiamo solo ciò che vogliamo sentire. Pensate in modo critico, fate domande, siate le persone che interrogano le informazioni, non che si limitano a consumarle”. Quarta regola: “Siate grandi lavoratori. Non perdete tempo. E’ facile pensare che non lavoreremo più così duramente quando l’AI potrà fare tutto il lavoro al posto nostro. Alcuni leader dell’AI dicono che lavoreremo solo per divertimento. Lasciate che l’intelligenza artificiale vi aiuti con il lavoro, ma non permettetele di ridurre gli sforzi importanti. Come per questo discorso: ChatGPT avrebbe potuto scriverlo, ma ho pensato che fosse importante scrivere le mie battute cattive”. Infine, la quinta regola: “Siate collaborativi. Non dimenticate mai il potere di unirsi, di risolvere cose, di creare cose o semplicemente di essere umani con altri umani. Potete anche considerare AI uno dei vostri compagni di squadra. Ma non dimenticate che i vostri più grandi collaboratori saranno sempre gli altri esseri umani. In fin dei conti, non sono le macchine a definire il vostro futuro. Sono le relazioni che costruite, i valori che portate con voi e la curiosità e la creatività che mettete in tutto ciò che fate”. In queste relazioni è necessario sapere quello che la macchina sa fare, quello che la macchina non sa fare, e quando si è capito ciò che la macchina sa fare, non usare tutta la sua potenzialità non deve essere un peccato: deve essere una scelta, deve essere uno sforzo quotidiano, deve essere un gioco continuo e personale e individuale in cui ciascuno di noi sa cosa la macchina sa fare ma sa cosa rischierebbe a far fare alla macchina il lavoro che dovrebbe fare il nostro cervello. L’AI creerà nuovi lavori, cambierà quelli esistenti, e forse ci supererà in molte delle cose che oggi facciamo meglio. Ma non sarà lei a scegliere cosa lasciarci. Saremo noi, con il gusto, la creatività e il senso del limite, a decidere dove mettere la frontiera. Rinunciare all’intelligenza, in nome della comodità, non è progresso. E’ stupidità: tutta naturale e per niente artificiale.

la relazione con il tech





