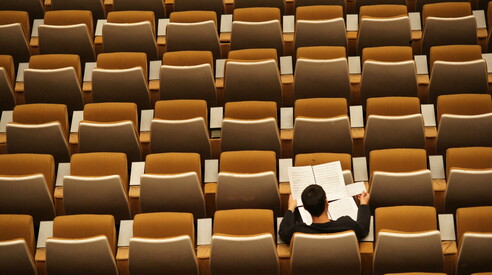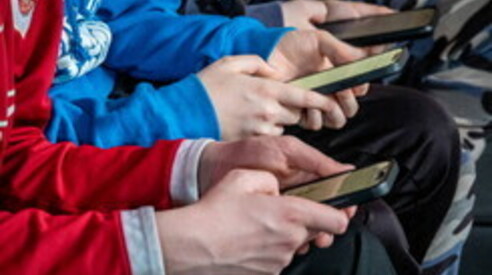
FOTO Getty Images
cattivi scienziati
Le piattaforme digitali amplificano i nostri istinti tribali
Se in un villaggio reale sarebbe stato impensabile insultare pesantemente un vicino senza subirne le conseguenze, su Twitter o in un commento anonimo molti si lasciano andare ai peggiori impulsi senza filtri
Nella quotidianità iperconnessa di oggi capita di scorrere le notifiche sullo smartphone e, nel volgere di pochi istanti, sentir ribollire dentro di noi impulsi antichi. Ci indigniamo furiosamente per l’ennesimo commento provocatorio di uno sconosciuto online, ci sentiamo confortati dall’abbraccio virtuale di una comunità di perfetti estranei che condividono le nostre idee, oppure proviamo il brivido amaro di vedere un gruppo “avversario” esultare per qualcosa che percepiamo come una minaccia ai nostri valori. In quei momenti emergono in superficie dinamiche profonde della nostra psicologia, forgiatesi in contesti ben diversi dall’attuale.
Come recita una provocatoria massima contemporanea, abbiamo menti ed emozioni dell’Età della Pietra e strumenti da dèi. Questo paradosso riassume la condizione dell’essere umano nel mondo moderno: creature con cervelli plasmati dalla vita tribale preistorica e da secoli di passioni viscerali, che si trovano ora a maneggiare tecnologie e poteri un tempo attribuiti solo alle divinità. Siamo, per citare il biologo E. O. Wilson, una sorta di “chimera evolutiva” che porta in sé un mix complicato di emozioni paleolitiche, retaggi pre-moderni e capacità tecnologiche quasi divine. Il risultato è uno sfasamento profondo – un disallineamento evolutivo – tra ciò per cui la nostra mente ed emotività si sono adattate e l’ecosistema culturale e digitale in cui oggi ci muoviamo.
Gran parte della storia evolutiva umana si è svolta in un ambiente radicalmente diverso dall’attuale. Per centinaia di migliaia di anni, i nostri antenati hanno vissuto in piccoli gruppi nomadi compatti, tipicamente di poche decine di individui – forse fino a un centinaio al massimo. In queste tribù primordiali l’appartenenza era tutto: far parte del clan significava avere protezione e accesso alle risorse, mentre esserne esclusi poteva equivalere a una condanna a morte. La selezione naturale ha affinato in quel contesto i nostri istinti sociali: abbiamo sviluppato un bisogno potente di appartenenza e lealtà identitaria, nonché sofisticati meccanismi per monitorare il nostro status nel gruppo e fiutare possibili minacce provenienti da esterni. I circuiti emotivi che regolano la paura, la collera, l’affetto o la vergogna si sono tarati su interazioni a misura d’uomo, faccia a faccia, in cui ciascuno conosceva personalmente gli altri membri della comunità e ne condivideva miti, simboli e obiettivi. Il cervello umano, in termini strutturali, non è cambiato granché dai tempi del Paleolitico: neuroanatomia e predisposizioni istintive restano quelle adatte a garantire la sopravvivenza di piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori. Non sorprende dunque che i nostri crani moderni alloggino una mente dell’età della pietra, progettata per un mondo semplice e stabile che non esiste più.
Quella mente ancestrale si ritrova oggi immersa in un ambiente planetario complesso, frammentato e tecnologicamente sovraccarico – un ambiente per molti versi incompatibile con le sue attese. Siamo passati dai villaggi reali alle tribù digitali globali. Grazie agli strumenti da dèi di cui disponiamo – Internet, social media, comunicazioni istantanee – ciascuno di noi è connesso a migliaia di altre persone, entra quotidianamente in contatto con notizie, opinioni e conflitti provenienti da ogni angolo del globo. Le nostre comunità non sono più geografiche e coese, ma sfuggenti e sovrapposte: possiamo far parte contemporaneamente di decine di gruppi online, forum, reti social, ciascuno con valori e linguaggi propri, che spesso nemmeno si conoscono tra loro. Questa proliferazione di identità e appartenenze simultanee non ha precedenti nella storia evolutiva e crea un onere psicologico notevole.
Molti di noi sperimentano una sorta di dissonanza cognitiva nel dover costantemente passare da un contesto identitario all’altro – ad esempio dall’essere, in rapida successione, un professionista serio sul social lavorativo, a un appassionato tifoso in una community sportiva, a un polemista infuocato su Twitter riguardo a questioni politiche. Gli equilibri interiori ne risentono: districarsi fra le proprie molteplici “versioni di sé” può far perdere la sensazione di avere un’identità coerente. I nostri antenati non dovevano certo affrontare nulla di simile. Essi vivevano immersi in un mondo sociale stabile, con ruoli chiari e un numero limitato di relazioni, mentre noi navighiamo in un flusso costante di informazioni e interazioni effimere, bombardati da stimoli sociali che i nostri sensi e le nostre emozioni faticano a decifrare appieno.
Questa discordanza tra predisposizioni psicologiche antiche e realtà contemporanea è al cuore di molti fenomeni peculiari del nostro tempo. L’istinto tribale che un tempo garantiva cooperazione all’interno del gruppo e diffidenza prudente verso gli estranei oggi risorge nelle forme delle affiliazioni ideologiche online e dei conflitti polarizzati su scala globale. La pulsione a tracciare confini fra un “noi” e un “loro” – descritta in chiave politica dal giurista Carl Schmitt come distinzione amico/nemico – è iscritta nel nostro retaggio evolutivo e si manifesta ovunque, dai campanilismi calcistici alle “guerre culturali” sui social. Nel desiderio viscerale con cui difendiamo il nostro gruppo digitale preferito o la nostra posizione ideologica, riconosciamo la stessa logica delle antiche alleanze tribali: fedeltà identitaria in cambio di protezione e senso di appartenenza.
D’altro canto, l’ostilità verso il fuori-gruppo che un tempo aveva la funzione di proteggerci da possibili nemici ora si accende contro categorie astratte di persone mai incontrate di persona – gli elettori dell’altro partito, i sostenitori di una certa causa, i membri di una differente sottocultura online. Ciascuno di questi può diventare, ai nostri occhi, il bersaglio su cui proiettare paure e rancori atavici. Ed ecco che le tribù digitali si coagulano e si contrappongono, litigando ferocemente su questioni spesso simboliche. I social network sono gremiti di fazioni che si sentono sotto attacco reciproco, pronte a rinsaldare al proprio interno un forte cameratismo e a dipingere l’avversario come totalmente malvagio o folle. È un meccanismo profondamente umano: in fondo gli esseri umani esprimono indignazione morale online per la stessa ragione per cui la esprimevano nelle tribù dell’Età della Pietra – per difendere la comunità da comportamenti nocivi e rafforzare le norme condivise. L’errore non sta nell’istinto in sé – che anzi fu vantaggioso nelle giuste condizioni – ma nel nuovo contesto in cui esso viene attivato, un contesto per cui non è stato progettato.
In effetti, molte delle nostre reazioni emotive odierne risultano “sprogrammate” rispetto alla realtà contemporanea. Gli psicologi evoluzionisti parlano di disallineamento proprio per descrivere questo scollamento: ad esempio, tendiamo a sovrastimare pericoli immediati e tangibili, reagendo in modo eccessivo a stimoli di lieve entità, e al contempo a sottovalutare minacce più astratte, diffuse o lontane nel tempo. Il nostro cervello è tarato per attivare la risposta “lotta o fuggi” di fronte a un aggressore visibile nell’immediato – come poteva essere un predatore o un nemico tribale – ma è molto meno preparato ad affrontare minacce complesse come un cambiamento climatico graduale o le crisi finanziarie globali.
Così, paradossalmente, possiamo arrabbiarci e impaurirci enormemente per un tweet provocatorio o per una notizia allarmante letta sul web (uno stimolo simbolico che però scatena in noi paure concrete), mentre restiamo apatici di fronte a problemi reali ma percepiti come astratti o lontani. Allo stesso modo, ciò che era cooperazione di gruppo può trasformarsi in conformismo settario: cerchiamo approvazione e validazione all’interno del nostro “branco” online, e questo può portarci ad aderire a credenze o comportamenti sempre più estremi pur di non essere esclusi. Nell’ancestrale cerchia ristretta, manifestare indignazione morale verso chi violava le regole serviva da segnale virtuoso di lealtà (dimostrava che tenevamo al bene comune) e aiutava a correggere i devianti; oggi, la medesima spinta si traduce talvolta in outrage virali e campagne di linciaggio morale verso perfetti sconosciuti, colpevoli magari di aver espresso un’opinione impopolare. La passione emotiva con cui reagiamo a certi dissensi ricorda più l’ardore dei crociati o l’ira funesta di una faida religiosa che il dibattito ragionato che le nostre istituzioni democratiche moderne si attenderebbero. È come se parti di noi fossero rimaste a un livello premoderno di risposta emotiva: sotto la patina di civiltà illuminista, restiamo pronti a fare la guerra per un’idea eretica o per un simbolo profanato, proprio come in un’epoca di inquisizioni e streghe al rogo – solo che oggi il “rogo” avviene sotto forma di gogna mediatica in diretta mondiale.
A esacerbare ulteriormente questo quadro interviene la potenza dei moderni strumenti tecnologici, che interagiscono in modo perverso con i nostri bias cognitivi innati. Le piattaforme digitali non si limitano a mettere in scena i nostri istinti tribali: li amplificano attivamente. I social network, progettati per catturare e mantenere la nostra attenzione il più a lungo possibile, hanno scoperto (quasi in modo algoritmico-evolutivo) che nulla attira l’attenzione umana quanto i contenuti capaci di scatenare le nostre emozioni tribali più forti – indignazione, paura, senso di rivalsa o di rettitudine. Un post moderato, sfumato, che richieda riflessione lenta, difficilmente diventerà virale; al contrario, un messaggio carico di rabbia, paura o moralismo identitario ha molte più probabilità di propagarsi, perché preme esattamente quei tasti emotivi a cui siamo maggiormente sensibili. Gli algoritmi delle piattaforme lo hanno imparato con l’esperienza (macinando miliardi di dati sul comportamento degli utenti) e tendono a riproporci soprattutto i contenuti che provocano reazioni istintive intense, che sia uno scandalo politico, un titolo allarmistico o l’ennesima provocazione divisiva. Il risultato è un circolo vizioso: siamo naturalmente portati a cercare notizie e opinioni che confermano la visione del nostro gruppo; gli algoritmi, fiutata questa nostra preferenza, ce ne mostrano sempre di più simili; col tempo le nostre convinzioni si radicalizzano per l’esposizione ripetuta a una sola campana; la realtà digitale si polarizza in bolle separate di tribù ostili, ciascuna nutrita dai propri flussi di informazioni partigiane, e il conflitto identitario si inasprisce ancora, propagandosi sui media tradizionali e in politica. Il tutto avviene spesso a nostra insaputa: restiamo intrappolati in quelle che l’informatico Eli Pariser definì filter bubble, bolle di filtro personalizzate in cui vediamo soprattutto ciò che conferma i nostri pregiudizi, mentre la visione dell’altro ci giunge deformata o caricaturale.
Studi recenti, ad esempio, mostrano che gli elettori di opposti schieramenti sovrastimano enormemente l’odio e la disumanizzazione che la fazione avversa proverebbe nei loro confronti – segno di quanto la percezione dell’altro sia distorta quando la si osserva attraverso la lente dei media polarizzati. In questo senso, gli algoritmi si inseriscono esattamente nelle nostre vulnerabilità cognitive, sfruttando bias radicati: ad esempio il bias di conferma (tendiamo a cercare e credere alle informazioni che confermano ciò in cui già crediamo), il pregiudizio di negatività (gli stimoli negativi ed emotivi catturano più la nostra attenzione) o l’effetto identitario (diamo più credito a chi consideriamo membro del nostro gruppo). Il disallineamento tra gli obiettivi dei social media (massimizzare il coinvolgimento per fini commerciali) e le funzioni della psicologia umana ha prodotto maggiore polarizzazione e disinformazione nel discorso pubblico odierno. Quando evolvevano i nostri meccanismi di apprendimento sociale, informazioni cariche di valenza morale ed emotiva erano cruciali perché servivano a far rispettare le norme del gruppo e assicurare la sopravvivenza collettiva. Oggi però gli algoritmi, guidati da tutt’altri scopi, sovraespongono proprio quel tipo di informazioni “PRIME” (Prestigiose, In-group, Morali, Emotive) a cui siamo più ricettivi, indipendentemente dalla loro accuratezza o rappresentatività della realtà. Così contenuti estremi e divisivi ottengono una cassa di risonanza abnorme, e gli utenti – se non esposti intenzionalmente a opinioni diverse – finiscono per maturare una visione falsata delle posizioni altrui e sentirsi sempre più giustificati nella propria rabbia. In pratica, la macchina tecnologica potenzia e arma le nostre emozioni istintive, creando un ambiente sociale in cui la moderazione e la razionalità fanno fatica a emergere.
Un altro elemento cruciale del mondo digitale è l’assenza di alcuni freni e contrappesi naturali che esistevano nei contesti di interazione faccia a faccia. Nelle tribù tradizionali esistevano limiti e responsabilità precise: conoscevi personalmente ogni membro della comunità, vedevi direttamente le conseguenze dei conflitti e sapevi che avresti dovuto continuare a convivere con quelle persone anche dopo un diverbio. C’era dunque un incentivo a mantenere un certo rispetto reciproco, a non oltrepassare certi limiti, perché dalla rottura dei rapporti avrebbe finito per perdere l’intero gruppo. Online tutto questo in gran parte svanisce: interagiamo spesso con sconosciuti di cui non conosciamo il volto, che probabilmente non rivedremo mai più e verso i quali non ci sentiamo responsabili.
Se in un villaggio reale sarebbe stato impensabile insultare pesantemente un vicino senza subirne le conseguenze, su Twitter o in un commento anonimo molti si lasciano andare ai peggiori impulsi senza filtri. Il medium digitale, proteggendoci dietro uno schermo, disinibisce le nostre reazioni: possiamo scagliarci con veemenza ben maggiore di quanto faremmo guardando qualcuno negli occhi. Inoltre, la distanza fisica e sociale ci rende facile de-umanizzare l’altro – ridurlo a un’icona, a un username, dimenticando che dietro c’è una persona reale. Questo abbassa ulteriormente la soglia dell’empatia e alimenta cicli di provocazione e ritorsione verbale. In poche parole, ci troviamo con armi comunicative potentissime – la possibilità di diffondere istantaneamente i nostri pensieri e umori a platee vastissime – ma senza un corrispondente aumento della nostra saggezza emotiva o capacità di autocontrollo. Gli strumenti “da dèi” sono finiti nelle mani di esseri con reazioni da primati territoriali, mettendo a dura prova le convenzioni civili e istituzionali che reggono la convivenza pacifica.
Basti pensare all’impatto che pochi personaggi carismatici con milioni di seguaci possono avere nel diffondere teorie cospirative o nel fomentare l’odio: i loro messaggi infiammati attivano nei follower i meccanismi di allineamento tribale e sospetto verso il nemico, spesso aggirando del tutto i tradizionali corpi intermedi (partiti, media autorevoli, accademie) che in passato filtravano e moderavano i contenuti del dibattito pubblico. In questo senso le nostre “istituzioni” socio-politiche, ancora in buona parte modellate su logiche novecentesche se non addirittura ottocentesche, faticano a tenere il passo: la democrazia rappresentativa e il discorso razionale illuminista presuppongono cittadini in grado di informarsi criticamente e di negoziare compromessi, ma la combinazione di emozioni arcaiche e canali tecnologici nuovi mina queste premesse, spingendo verso una politica di pancia e di appartenenze viscerali. Il filosofo politico del secolo scorso pensava l’opinione pubblica come un’arena di confronto argomentativo; oggi somiglia più a un campo di battaglia emotivo in cui vince chi grida più forte al tradimento o all’eresia. E così le nostre passioni “paleolitiche” – onore, orgoglio di fazione, fervore morale – riemergono potenti, solo che invece di brandire pietre, spade o torce ardenti impugniamo smartphone e tweet taglienti.
Dipinto questo quadro, si potrebbe essere tentati dal pessimismo: dopotutto, una mente paleolitica con strumenti moderni può fare grossi danni, e in parte è ciò che vediamo nelle patologie sociali attuali. Ma riconoscere il problema è già un passo verso possibili rimedi. Il fatto stesso di comprendere che questa tribalizzazione della vita online non è semplicemente un difetto morale individuale, bensì un disallineamento evolutivo, può aiutarci ad affrontarla con un approccio più costruttivo. Non si tratta di condannare l’umanità per la sua irrazionalità, ma di prendere atto che tutti noi siamo vulnerabili a questi meccanismi – anche le persone colte, anche quelle consapevoli ne restano in qualche misura influenzate. In fondo, essere umani significa proprio portare dentro di sé questa eredità duplice: da un lato gli istinti immediati di un organismo sociale forgiato nella scarsità e nel pericolo imminente, dall’altro la scintilla di ragione e creatività che ci ha permesso di costruire civiltà complesse.

CATTIVI SCIENZIATI