
Giuseppe Busia - foto GettyImages
La non concorrenza strozza l'Italia sugli appalti e sul Pnrr. Le svolte necessarie
I dati che il presidente dell'Anac ha messo al centro della sua relazione in Parlamento mostrano come il mercato italiano stia conoscendo fenomeni di poca trasparenza e concorrenza
Il sistema italiano degli appalti presenta molte criticità che tengono da sempre lontane le imprese straniere dal mercato: la giustizia che incombe sempre e può dirottare il destino di un’opera, l’eccesso di burocrazia, la corruzione diffusa e quella presunta, i progetti fatti male che lasciano ampia libertà di modifica e di inattuazione, procedure di autorizzazione defatiganti, finanziamenti (e cassa degli enti appaltanti) a intermittenza, margini di redditività per le imprese molto ridotti rispetto agli altri paesi europei, mancanza di una revisione dei prezzi automatica e trasparente che garantisca l’equilibrio contrattuale (si sta cercando di rimediare con il nuovo codice), la frequente incapacità tecnica delle stazioni appaltanti a gestire l’appalto.
E poi ancora, un ambiente ostile, una serie di meccanismi che consente di recuperare i costi (e spesso di accrescerli) allungando i tempi e autorizzando varianti. Un disastro, in termini di efficienza. C’è però un difetto che da trent’anni il mercato italiano non aveva mai avuto: la mancanza di concorrenza e di trasparenza. E che invece ora si è a tal punto imposto all’esame dei dati che il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, lo ha messo al centro della sua relazione annuale al Parlamento.
Prima ancora di dare i numeri, bisogna sgomberare il campo da un equivoco che spesso si ripropone: la velocizzazione delle procedure di appalto – più che mai necessaria – richiede necessariamente meno gare, meno informazioni, meno procedure complesse. Falso. La digitalizzazione consente di semplificare, sburocratizzare, velocizzare anche mantenendo i fondamentali paletti di trasparenza e concorrenza garantiti da una competizione pubblica. L’importante è non confondere la semplificazione che elimina ridondanze formalistiche con l’azzeramento delle informazioni necessarie ad alimentare un mercato, con la volontà strisciante di assegnare gli appalti nel silenzio pubblico e negli affari con amici o cugini, con la volontà di nascondere le notizie sulla volontà di dare in appalto una fornitura, un lavoro o un servizio. Prima del 1994, anno in cui nacque la legge voluta da Francesco Merloni, tutto avveniva al buio, non c’erano neanche le direttive Ue a imporre la “pubblicità”. Da allora tutto avvenne alla luce, in un mercato trasparente in cui le imprese sapevano sempre chi appaltava, come e cosa.
Oggi è passata l’idea che la procedura negoziata (un tempo si chiamava trattativa privata) può sostituire la gara formale con un forte risparmio di tempi. Anche molti puristi della concorrenza hanno accettato – con i decreti del Pnrr di Mario Draghi – una maggiore diffusione della procedura negoziata che consente di invitare un numero minimo di imprese e di procedere a una negoziazione senza troppe formalità, con il risultato di avere in un paio di mesi un vincitore dell’appalto e un prezzo. Il nuovo codice degli appalti, scritto dal Consiglio di stato e corretto in corsa da Salvini, privilegia affidamenti diretti e procedure negoziate consentendo sotto la soglia delle regole europee di 5,5 milioni di euro di affidare lavori senza gara.
Sul punto l’Unione europea ha tenuto bloccata la quarta rata del Pnrr per 4-5 mesi perché la norma di Salvini, scritta al presente indicativo, prefigurava addirittura un obbligo per le stazioni appaltanti di procedere senza gara. Dopo il tira e molla, la Commissione Ue si è accontentata di una circolare del ministro, che considera scritta sulla pietra, mentre Busia insiste che sarebbe necessario modificare la norma legislativa per lasciare maggiore libertà di scelta alle stazioni appaltanti e per imporre obblighi minimi di “pubblicità”, cioè almeno un avviso o un bando che faccia sapere al pubblico delle imprese e dei professionisti che si sta procedendo a una procedura negoziata. Anche le imprese più strutturate del settore – dai costruttori dell’Ance alle società di ingegneria dell’Oice – gridano al mercato tradito e reclamano più concorrenza e più trasparenza per non tornare ai tempi bui in cui gli affidamenti avvenivano senza saperne nulla. Proprio una stima dell’Ance parla, in sintonia con i dati Anac, di 50 per cento del mercato sottratto alla concorrenza.
Qui arrivano i numeri. Nel 2023 – dice Anac – dei 267 miliardi che costituiscono il mercato totale soltanto il 17,4 per cento degli appalti è stato assegnato con “procedura aperta” (gara aperta a tutti) e il 3,6 per cento con “procedura ristretta” (gara pubblica ma con selezione), mentre il 29,3 per cento è andato per procedura negoziata (trattativa informale) e il 49,6 per cento per affidamento diretto (assegnazione decisa discrezionalmente dalla stazione appaltante). Negli affidamenti diretti e informali pesano molto i piccoli appalti tanto è che i pesi cambiano se consideriamo gli importi anziché il numero di appalti: 56 per cento procedure aperte, 12 per cento procedure ristrette, 24 per cento procedure negoziate, affidamenti diretti appena il 6,4 per cento.
Tutto bene quel che finisce bene, quindi? Niente affatto. Per almeno quattro ragioni.
La prima è che comunque gli affidamenti diretti sono cresciuti del 31 per cento, più di qualsiasi altra procedura di affidamento, proprio per effetto della pseudo-liberalizzazione imposta dal codice.
La seconda è che guardando solo i lavori pubblici (escludendo quindi forniture di beni e servizi) rispetto a un totale di 70,2 miliardi affidati le gare sono al 10 per cento e gli appalti senza gara sono al 90 per cento.
La terza è che nei settori speciali (ferrovie, acqua, energia, tlc) che fanno generalmente grandi opere (con una media di 3 milioni di euro contro una media generale di 1 milione) le procedure senza gara sono comunque l’87 per cento. Qui si concentra molta parte della critica di Ance perché parliamo di regole che consentono di procedere informalmente anche per grandi opere.
La quarta e più significativa ragione di preoccupazione è che quasi tutto quel 90 per cento di appalti senza gara nei lavori è anche senza comunicazione alcuna al mercato prima dell’aggiudicazione. Roba da Antitrust. Si tratta di 32.513 appalti in affidamento diretto e 29.567 procedure negoziate senza bando o avviso preliminare contro 450 procedure negoziate con una preventiva comunicazione al mercato. Il buio è tornato, dunque, tutto avviene sott’acqua: di qui l’allarme di Busia che richiama anche l’Unione europea e invita a modificare la norma nel decreto correttivo al Codice degli appalti in preparazione, prevedendo almeno una comunicazione che lasci traccia della volontà di affidare un’opera.

La situa
La partita europea di Giorgia Meloni
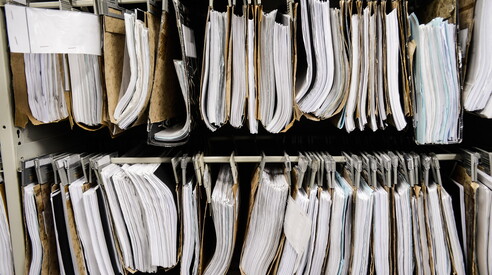

l'editoriale del direttore


