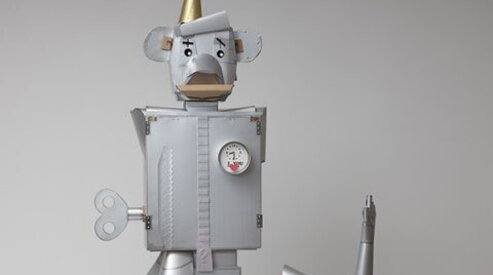
Simon Fujiwara, "Only Whoman" (2021). Fondazione Prada, Milano, fino al 27 settembre
Il Foglio della Moda
Dove stanno le donne nella moda (ve lo diciamo già: ai piani bassi)
Inclusione lontana. Nelle grandi aziende le manager sono poche, con rare eccezioni. La sorpresa sono le pmi, guidate da imprenditrici che valorizzano le colleghe. I risultati della ricerca di PwC per Il Foglio della Moda
In estrema sintesi, le cose stanno così: in Italia la moda è un lavoro femminile, ma lo è soprattutto nelle fasce più basse della qualificazione professionale. Praticamente siamo rimasti ai tempi di Dickens, nemmeno a quelli di Rosa Genoni, Ida Zuecca e Prospero Moisé Loria fondatore dell’Umanitaria che nei primi del Novecento puntavano alla qualificazione professionale delle operaie, perché sappiate fin d’ora che la qualificazione, il digitale, il 4.0, sono i grandi handicap di questa massa di donne che lavora, lavora, lavora, e raramente riesce a migliorare la propria condizione. Sarte, operaie, magliaie, confezioniste, queste ultime in particolare, rappresentano il 70 per cento della forza lavoro nella moda. Ma se vogliono crescere, devono fondare la propria impresa, che nella stragrande maggioranza dei casi resterà di piccole dimensioni.
Eppure, ed ecco il grande paradosso della ricerca sviluppata da PwC per il Foglio della Moda che presentiamo in queste pagine, queste piccole imprese saranno mediamente più virtuose nella flessibilità e nella valorizzazione delle capacità femminili rispetto alle grandi. Con poche eccezioni, fra cui Moncler indicata da tutti i quadri dirigenti interpellati come una delle aziende migliori in cui una donna possa lavorare e dove in effetti la presenza di donne a tutti i livelli supera il 50 per cento, ai vertici delle multinazionali siedono quasi esclusivamente uomini. Nei cda italiani, si è visto e molto commentato dopo la nomina di Chiara Ferragni a consigliere del gruppo Tod’s, le donne eccedono di poco il 20 per cento, contro il 43 per cento della Francia. I casi di una self made woman dai cento milioni e passa di fatturato come Elisabetta Franchi sono rari: la segue da vicino solo Mena Marano di Arav Group, la holding di Silvian Heach, John Richmond e Trussardi Bambino. Il modello di Micaela le Divelec Lemmi, amministratore delegato di Ferragamo (qui la nostra intervista) è ancora più raro, perché in Italia è quasi impossibile che una delle tante imprese familiari della moda, grandi e piccole, affidi le redini finanziari e commerciali a una donna, per di più “esterna”.
Le prime imprenditrici della moda in Italia sono Miuccia Prada, erede della storica pelletteria di Galleria Vittorio Emanuele, sviluppata nella multinazionale della cultura del lusso che è attualmente grazie all’apporto fondamentale del marito, Patrizio Bertelli (uno dei loro figli, Lorenzo, molto brillante, sta per essere cooptato in Cda); Donatella Versace, erede del fratello Gianni, direttore creativo e vicepresidente di un’azienda il cui controllo, però, è passato tre anni fa alla Capri Holdings, e Angela Missoni, anche lei un’erede, della madre Rosita e del padre Ottavio-Taj di cui si è da poco ricordato il centenario della nascita, che nel 2018 ha ottenuto l’appoggio del Fondo Strategico Italiano, entrato nel capitale con una quota del 41,2 per cento. È scomparso o quasi il lascito di Mila Schon, abbiamo poche notizie sulle attività di Krizia (abbiamo chiesto a lungo e invano un’intervista alla proprietaria di Krizia, Zhu Chongyun, proprietaria dell’impero Marisfrolg di Shenzen, ufficialmente in ritiro su un’isola per ragioni personali).
Gode di ottima salute, ed è l’asse ereditario più lungo, Luisa Spagnoli spa, fondata dalla prima vera grande imprenditrice italiana, Luisa Spagnoli Sargentini, e ora guidata dalla pronipote, Nicoletta Spagnoli. Alle manager esterne vengono affidati di solito l’ufficio legale o la gestione dei conti, cioè l’ufficio finanza e controllo, vedi Sabina Galli di Bulgari, un modello per molte. In genere, gli imprenditori italiani della moda si comportano come in quella vecchia battuta di Alberto Sordi: «sposarmi io? E che, mi metto un’estranea in casa?».
Vi siete mai domandati perché tanti imprenditori di prima fascia, anche in queste settimane, parlino di accordi e fusioni? Andate a guardare l’asse ereditario e capirete che non hanno altra via d’uscita, a meno di mettere l’azienda nelle mani di un amministratore delegato esterno, cosa che non vogliono fare, o di eredi che non sono all’altezza, e sarebbe un suicidio per tutti, eredi compresi. Dunque, arrivati a una certa età, di solito i fondatori preferiscono cedere le proprie quote o, ancor più rari in Italia, affidarsi a un family office. Le donne di famiglia, nella moda come altrove, vengono invece indirizzate di solito alle relazioni esterne e alla comunicazione, sull’onda dell’epico slogan della Wind che Sabrina Ferilli recitava tanto bene: «Quanto ce piasce chiacchierà» e come se questa professione non fosse invece fondamentale e richiedesse zero chiacchiere e molte professionalità specifiche, come risulta evidente dalla grande messe di agenzie di comunicazione guidate da donne forti come l’acciaio a cui si affidano queste aziende, giunte alla disperazione per i baloccamenti della cocca di casa fra iniziative no profit a scopi oscuri e influencer cafoni, ma che restano appunto esterne: Karla Otto, Emanuela Schmeidler, Isabella Errani, Francesca Parini fra tutte, ma tantissime, e spesso lavorano anche per il marchio all’estero. Volendo cercare fra i quadri intermedi, ufficio commerciale, merchandising, prodotto, troverete il numero in assoluto più esiguo di donne: la moda che comprate è creata, scelta, adattata, selezionata e venduta perlopiù da uomini, cioè i soli che possano permettersi di stare lontani da casa o da una vita familiare per oltre duecento giorni all’anno, a fare ricerca, selezionare, vendere e controllare le showroom. Le donne che scelgono questa strada sono pochissime e di solito scelgono di non avere una vita personale (qualche considerazione in più la trovate sempre nell’intervista al ceo di Ferragamo).
E ora, ecco i dati. Con il supporto di PwC, abbiamo consultato e incrociato tutte le banche dati disponibili – Istat, Smi e Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda, Assocalzaturifici, Cuoio di Toscana, UNIC, CNA Federmoda – intervistato decine di professionisti anche nella ricerca di personale, come Egon Zhender o HR Generation – e questi sono i risultati. Partiamo da quelli buoni. La piccola imprenditoria femminile di suo sarebbe attivissima, ricca di capacità e di voglia di fare: occupa infatti oltre il 45 per cento del settore, a dati CNA Federmoda, su un complesso rilevato di tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, che dà lavoro a oltre 220mila donne (il 55,5 per cento su 475mila occupati). Molte di queste imprenditrici hanno messo in atto il massimo numero possibile di aiuti sociali per favorire le proprie dipendenti, spesso pagando di persona in termini di credibilità perché, per esempio, il part time è valutato negativamente negli audit delle multinazionali che danno loro lavoro.
Le piccole imprese di pelletteria, maglieria, sartoria, sono il cuore pulsante dell’industria della moda italiana, del celebrato made in Italy, come segnala il responsabile nazionale CNA Federmoda Antonio Franceschini. Questo, però, chiarisce anche perché la crisi occupazionale del 2020, danneggiando in modo molto evidente la moda, abbia colpito soprattutto le donne. Perché alla base della filiera ci sono loro, e loro per prime hanno dovuto assentarsi dai luoghi di lavoro in questo periodo pandemico per seguire i figli in Dad: questo, osserva Franceschini, ha reso evidente «che il rispetto verso il ruolo lavorativo dei coniugi è sperequato, ma allo stesso tempo ha messo in difficoltà le imprese, che per quanto piccole, resilienti e flessibili, si sono svuotate senza preavviso, per la mancanza di una effettiva politica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Sulla base delle elaborazioni effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda su dati di fonte Istat 2017, gli ultimi disponibili, il settore tessile-abbigliamento presenta un’incidenza dell’occupazione femminile molto superiore a quella registrata dall’industria manifatturiera italiana. Nelle aziende tessili la quota di donne assunte è pari al 48,4 per cento, ma sale al 69,4 per cento nelle aziende di confezione, contro una media manifatturiera ferma al 28,4. Anche nel caso dei lavoratori indipendenti e dei lavoratori temporanei, l’incidenza della manodopera femminile risulta superiore al 40 nella filiera a monte; se si considera l’abbigliamento, la quota passa, invece, al 52,8 per cento per gli indipendenti, e cresce addirittura al 78,4 per i temporanei.
Le donne, da questi dati si capisce chiaramente, vengono ingaggiate anche all’ultimo momento, quando arriva una commessa importante, un riordino, e i brand e i façonisti non sanno a chi rivolgersi perché qualcuno faccia le notti in piedi alle macchine. Le donne coprono il 61,6 per cento dei dipendenti totali, il 48,6 per cento nel caso degli indipendenti: insomma, il Made in Italy è prevalentemente femminile, con un range di occupazione che, a seconda della categoria di prodotto, copre dal 55 al 66 per cento. Ma, come si scriveva nelle prime righe, salendo di livello nei consigli di amministrazione italiani, l’universo femminile presente nelle principali multinazionali della moda raggiunge solo il 21 per cento, segnando un importante scarto culturale rispetto ai concorrenti francesi, britannici e statunitensi, dove la quota femminile di presenze nei cda, secondo dati 2020 dell’Area Studi di Mediobanca che al momento della pubblicazione fecero molto parlare, sono pari rispettivamente al 43, al 36 e al 34 per cento. Il gender gap sulle opportunità di accesso alle posizioni manageriali per le lavoratrici in Italia è stato rilevato anche da un recente studio di Kering, che evidenzia come solo il 25 per cento dei board manageriali dei principali marchi di lusso-moda italiani del gruppo sia composto da donne.
Poi, ci sono le eccezioni, come Silvia Gianesin, general counsel di Golden Goose, marchio dell’abbigliamento sportivo di lusso controllato da Permira, che dice di non aver mai vissuto discriminazioni, anzi. Il suo è il genere di curriculum specchiato che forse non arriverà ai cda, ma che si posiziona nella prima fascia del management: dopo la laurea a Bologna e un Master al Cuoa, ha fondato l’ufficio legale di Sinv, una delle più grandi aziende manifatturiere di moda, quindi è entrata in Moncler come legal affair manager, seguendo il processo di quotazione e di cui ricorda «l’assoluta parità di genere rispettata nei ruoli e nelle opportunitàc. Golden Goose, dove si trova ora, è un altro caso singolare: sono donne sia la presidente, Maureen Chiquet, ex ceo di Chanel, sia la wholesale director, Leila Boscaino. Volendo procedere per singolarità, ci sarebbe il quasi incredibile caso delle concerie, dove quasi un terzo delle dirigenti è donna, la quota di impiegate anche ad alti livelli è in crescita costante da sette anni e molte eredità sono passate di padre in figlia, vedi Marta Ghizzani, vicepresidente della Montana di Ponte a Egola, che fornisce pelli da Zara a Diesel e potrebbe intrattenervi ore sulla sostenibilità del suo mestiere, o Eugenia Presot, quarta generazione alla guida della omonima conceria friulana, vincitrice del premio Tecnovisionarie 2020: la sua impresa lavora con una centrale idroelettrica propria, che sfrutta un antichissimo salto d’acqua, e vi lavorano dodici addetti di cinque nazionalità diverse, tutti profughi.
Presot ha destinato loro un ampio terreno, che è stato trasformato in orto. Quando, come in uno degli ultimi studi di Ubs Wealth Management, si dice che una decisa presenza femminile ai vertici delle aziende produca migliori risultati, si dice proprio questo: che le donne pensano globalmente alla crescita del benessere dell’azienda. Ma la realtà che raccontano i dati elaborati da Pwc è ancora un’altra, e ricorda da vicino quel magnifico libro-inchiesta che Federico Fubini pubblicò tre anni fa per Mondadori sulle ragioni storiche dell’immobilismo sociale nel nostro paese: La maestra e la camorrista, sottotitolo perché in Italia resti quello che nasci. Il libro non prende quasi mai in considerazione il genere perché sviluppa l’analisi lungo l’asse ereditario culturale ed economico; siamo però sicuri che, se l’avesse fatto, si sarebbe trovato di fronte agli stessi dati che abbiamo avuto modo di leggere noi, e cioè che le donne impiegate nella moda oggi si trovano più o meno nella stessa posizione che Vittorio Ellena condusse attorno al 1870 per il ministero dell’Agricoltura, Industria Commercio e che segnalava «un fatto notabile: la prevalenza nell’industria tessile delle donne e dei fanciulli. Il 49,32 per cento sono donne; il 23,58 sono fanciulli dell’uno e dell’altro sesso». Ad esclusione del lavoro minorile, diremmo che con le percentuali rispetto alla popolazione ci siamo. «Le nostre donne hanno occhio buono e dita agili e, poverette, si contentano di salari i quali eccedono di poco la metà di quelli che si danno in Francia».
Poverette anche adesso, abbastanza. Segnala PwC che «vi sono altri due importanti divari per la parità di genere su cui c’è molto da lavorare in Italia»: uno, come ovvio, è relativo al differenziale salariale fra i lavoratori uomini e donne, che Camera nazionale della Moda stima al 20 per cento. Il secondo, altrettanto importante, è il miglioramento delle competenze tecnologiche e digitali. Se è certo che questo settore rimarrà a prevalenza di manodopera femminile, e sperabilmente otterrà migliori risultati negli incarici C-level e all’interno dei cda, è però necessario, come sottolinea anche Cna che su questo punto ha avviato uno specifico progetto, che migliori le proprie cultura e la formazione.

Il Foglio della moda
Vesto l'individuo, non il genere. Incontro con Niccolò Pasqualetti

Il Foglio della moda
La sponda della seduzione. Intervista a Sláva Daubnerová in zona palcoscenico



