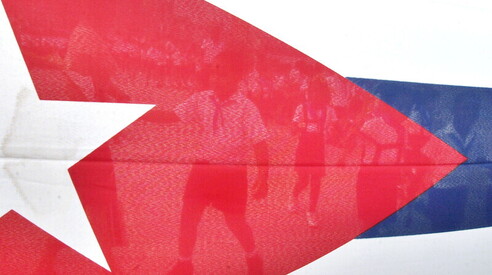Magazine
Tra i colossi di Cina e Usa la via italiana all'intelligenza artificiale
Il modello europeo si fa strada e l’Italia ha un posto tutto suo. Tra università, laboratori e imprese c’è un brulicare di nuove idee e menti brillanti. Alcuni giovani protagonisti ce lo raccontano. Sull’Ai fisica l’Italia ha tre grandi vantaggi: l’eredità manifatturiera, un sistema di piccole e medie imprese e una rete universitaria d’eccellenza
Sono stati educati dalle università italiane, si sono specializzati in quelle straniere, hanno studiato, ricercato, inventato nei laboratori del nuovo mondo digitale, a Oxford, a Sophia Antipolis in Provenza, a Copenaghen, in Australia, nella già mitica Silicon Valley, poi hanno fatto il salto dal laboratorio alla fabbrica virtuale. Sono espatriati, rimpatriati, o anche immigrati; non più solo maghetti degli algoritmi, non più solo inventori, ma innovatori; si sono messi in proprio oppure hanno riplasmato aziende esistenti, a cominciare da quelle delle telecomunicazioni che attraversano la loro metamorfosi da “tel-co a tech-co”. Sono tutti giovani soprattutto per gli standard italiani, e alcuni possiamo considerarli giovanissimi, racconteremo qualche storia di questi nuovi protagonisti nella tumultuosa rincorsa dell’Italia lungo la strada accidentata dell’intelligenza artificiale. Dalla dimensione digitale, l’AI sta entrando in quella umana, si avvicina sempre più a tutti noi, nelle attività quotidiane, nel lavoro, nella sanità, nei servizi. Due mega paradigmi si confrontano testa a testa: quello americano che nasce orizzontale, sul mercato, ed è meno regolato per lo meno a livello federale, oberato di debiti, con costi crescenti e un orizzonte in continuo movimento; quello cinese verticale, dirigista, sotto il controllo del Leviatano rosso che sta facendo man bassa con DeepSeek soprattutto nei paesi in via di sviluppo, anche se resta ancora lontanissimo dagli Stati Uniti. In mezzo si fa spazio un terzo modello, quello europeo, con un codice etico (fiducia, sicurezza, affidabilità) e un impianto giuridico (l’AI Act è la prima legge globale); nel suo seno sta prendendo forma la via italiana.
L’AI sta entrando nella sua dimensione umana, si avvicina sempre più alle nostre attività quotidiane: nel lavoro, nella sanità, nei servizi
Ci riempie di speranza Peter Koerte, tecnologo capo della Siemens, il plurisecolare colosso tedesco che vuol diventare “l’Apple dell’industria manifatturiera”. Secondo lui “l’Italia può dare un contributo significativo in termini di progettazione e produzione dei sistemi di prossima generazione”. Nella fabbrica del futuro l’AI sarà la mente e i robot umanoidi saranno le braccia. Gli operai diventano tecnici in camice bianco per controllare che tutto funzioni come si deve, quelli che oggi sono tecnici o impiegati saranno ingegneri e matematici. Detto, fatto. L’annuale fiera tecnologica di Las Vegas, che si è tenuta dal 6 al 9 gennaio, è stata aperta da Gene (pronunciato “Gin” all’inglese) il robot progettato e costruito dalla Generative Bionics, nata dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con il sostegno della Cassa depositi e prestiti. Presentato da Lisa Su, big boss della AMD, la rivale americana di Nvidia, Daniele Pucci – 41 anni, nato a Velletri nei Castelli romani, laurea alla Sapienza, dottorato in Francia – è apparso accanto alla sua creatura. Gene usa l’intelligenza artificiale per muoversi tra le persone con le quali interagisce; per sembrare ancor più umano è ricoperto in parte da pelle (sintetica, sia chiaro), una mimesi con l’intento di rendere la macchina vicina, amichevole, “simpatica”. E’ un prototipo, ma entro fine anno ce ne saranno già una decina, potrebbero costare dai 40 ai 70 mila euro l’uno, un prezzo abbordabile anche per una piccola azienda. Sempre a Las Vegas, poco lontano, è apparso un altro umanoide italiano, RoBee prodotto dalla Oversonic Robotics di Carate Brianza; non ha la pelle, ma volto e occhi, è alto un metro e 75 (la statura media dei giovani italiani) ed è un po’ sovrappeso (80 chili), pronto per la fabbrica, mentre un suo gemello viene già sperimentato nella sanità, a Milano e a Roma. Non più fantascienza, non ancora industria. Da sempre forte nelle macchine utensili e in quelle automatiche, l’economia italiana ha un’occasione d’oro. Cinquanta erano le aziende tricolore presenti a Las Vegas in questo Consumer electronics show 2026, che non sarà ricordato per un singolo dispositivo o per una tecnologia dirompente, ma perché molte innovazioni esistenti diventano linguaggi e infrastrutture quotidiane che ridisegnano in profondità i sistemi economici, organizzativi e sociali.
Tra il paradigma americano orizzontale e quello dirigista cinese, l’Europa trova il suo spazio con un codice etico e un impianto giuridico
La rimonta
Agli americani la folle corsa verso la digitalizzazione del cervello, agli europei l’umanizzazione degli algoritmi. Vuoi vedere che “l’umanesimo romano”, come lo chiamava con disprezzo Martin Heidegger, così amato nella cerchia di Palantir, si prende la rivincita? La fabbrica che Koerte sposta nel futuro potrebbe arrivare prima del previsto; mente e braccia sono già pronte a mettersi in moto, mentre il tessuto manifatturiero, che ha resistito ai terribili choc degli ultimi quindici anni, è un campo che si prepara ad accogliere i nuovi semi. Come? Non esistono veri campioni italiani, o ci sono imprese in grado di segnare la rimonta dell’Ital-IA? Si vede un brulichio di attività, un tessuto di università, laboratori, ricercatori, imprenditori, finanziatori, uno schema nuovo che s’innesta su quello tradizionale. “Per anni il trend portava verso il gigantismo – ha scritto l’Economist – oggi le aziende più piccole hanno grandi vantaggi”. E qui l’Italia ha molto da dire e da insegnare. Sia chiaro, le economie di scala restano importanti, piccolo può essere bello, ma ha bisogno del grande che lo sostenga. Eppure si aprono nuove finestre dalle quali può entrare l’aria del Mediterraneo, dopo decenni di tormente oceaniche dall’Atlantico e adesso anche dal Pacifico.
Secondo Peter Koerte, cto della Siemens, “l’Italia può dare un contributo significativo alla produzione dei sistemi di prossima generazione”
Siamo partiti in ritardo, adesso possiamo usare i vantaggi di chi arriva dopo, come è avvenuto più volte e non solo in Italia, si pensi al Giappone dagli anni 70 del secolo scorso, oppure oggi alla stessa Cina. Il Canada è il paese che prima degli altri si è lanciato sull’intelligenza artificiale, soprattutto a partire dal 2017. Segue la Svezia, che oggi è al primo posto insieme a Singapore, se calcoliamo gli investimenti in AI divisi per la popolazione. In quantità, gli Stati Uniti superano tutti con oltre 500 miliardi di dollari, metà della spesa globale, seguono la Cina – che comunque investe ancora tre volte meno – poi a grande distanza il Regno Unito, il Canada, Israele e la Germania quasi testa a testa, l’India, la Francia, la Corea del Sud, Svezia e Singapore appaiate. L’Italia risulta ultima tra i paesi europei analizzati dall’osservatorio del Politecnico di Milano (Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Regno Unito e Spagna). Sono indietro soprattutto le imprese minori: solo il 7 per cento delle piccole e il 15 per cento delle medie ha avviato progetti. Il 99 per cento degli italiani ha sentito parlare di Intelligenza artificiale generativa, il 59 per cento ne ha una buona opinione, ma solo il 17 per cento valuta positivamente l’adozione sul lavoro. Eppure, l’Italia è ai primi posti nell’utilizzo di strumenti pronti all’uso: il 53 per cento delle grandi aziende ha acquistato licenze di AI generativa, più di Francia, Germania e Regno Unito; e il 39 per cento di quelle che li utilizzano ha riscontrato un effettivo aumento della produttività.
Fastweb+Vodafone ha sviluppato un suo modello linguistico e possiede un supercomputer basato sull’architettura di Nvidia, uno dei più potenti in Italia
Proprio questo è uno dei punti più controversi. Ha fatto molto discutere uno studio del Massachusetts Institute of Technology secondo il quale l’impatto dell’AI sulla produttività delle aziende finora è pressoché nullo, se non negativo. Solo il 5 per cento dei manager intervistati ha riscontrato risultati positivi. Forse è troppo presto, siamo solo agli albori della nuova èra tecnologica, forse il campione scelto è poco rappresentativo, ma probabilmente la spiegazione è che l’AI non è ancora applicata in modo sistematico in quel che si chiama back office, il lavoro dietro le quinte che in realtà rappresenta il vero nucleo nei processi di automazione aziendale, spiega al Foglio Alessandro Magnino, chief strategy and transformation officer di Fastweb+Vodafone. Laurea in economia a Torino, poi la London Business School, primo lavoro nella Nokia, è entrato in Vodafone nel 2012 fino a ricoprire ruolo di vertice. Con la fusione Fastweb-Vodafone, è diventato il manager che guida la metamorfosi dell’azienda telefonica sempre più azienda tecnologica. Per raccogliere e verificare la gran massa di informazioni interne di un’impresa ci vogliono settimane e montagne di carta, l’AI può farlo in un paio d’ore di lavoro. Le aziende che lo hanno sperimentato, come Fastweb+Vodafone in Italia, possono confermarlo. Non solo. L’economista Luigi Guiso, insieme al Politecnico di Milano, ha costruito un modello chiamato KG: in mezz’ora ha passato in rassegna l’intera legislazione europea e ha impiegato 15 secondi per proporre un emendamento sensato. Le cifre sono impressionanti: le 80 mila leggi italiane usano 86 milioni di parole, quelle europee addirittura 220 milioni. Per leggerle tutte ci vogliono cinque anni dedicandovi 8 ore al giorno feste comprese, per capirle talvolta non basta una vita. Sono due esempi del progressivo avvicinamento di questo strumento esoterico, poco compreso e già molto demonizzato, ai bisogni quotidiani. Ma a questo punto dobbiamo fare un po’ di chiarezza: di quale AI parliamo e quale sta prevalendo nel modello italiano?
Per Uljan Sharka, fondatore di Domyn, l’intelligenza artificiale è ancora in culla. Non basta prenderla in affitto, bisogna svilupparla in proprio
Alec Ross, guru tecnologico americano e consulente del Dipartimento di stato, docente alla Columbia University, alla Johns Hopkins e a Bologna, ha classificato quattro categorie: l’AI percettiva, che con l’uso di sensori legge e interpreta l’ambiente circostante; l’AI chiamata “agentica”, che prende decisioni in base ad algoritmi senza intervento umano a posteriori (è quella usata nelle operazioni di borsa); l’AI generativa, che crea contenuti originali, tipo Chat GPT; e l’AI fisica, che interagisce direttamente con il mondo reale. Proprio in quest’ultima l’Italia può ritagliare il proprio spazio rilevante grazie a tre vantaggi strutturali: un’eredità manifatturiera consolidata, con grande esperienza nella produzione di precisione e nella meccatronica avanzata che favorisce l’integrazione tra hardware e software, macchine e linguaggi; un sistema di piccole e medie imprese innovative; una rete universitaria e centri di ricerca di eccellenza (ad esempio i politecnici o il consorzio universitario Cineca). L’Italia è assolutamente competitiva sul piano accademico, è debole nella messa a terra, nella fase applicativa – che vuol dire finanza, infrastrutture, regole e burocrazia, ma anche rischio imprenditoriale.
Calcoli e linguaggi
Siamo solo al punto di partenza. Oggi l’AI è ancora fondamentalmente uno strumento per un consumo personale, il vero balzo in avanti è usarla in modo produttivo. Prendiamo OpenAI e la sua ChatGPT. Dopo aver raccolto oltre 60 miliardi di dollari e aver raggiunto ricavi annuali stimati intorno ai 20 miliardi, la società si confronta con una dinamica difficile da eludere: i costi computazionali crescono quasi in parallelo ai ricavi. L’addestramento e soprattutto l’inferenza dei modelli restano attività estremamente onerosi, al punto che OpenAI, secondo un documento di Microsoft che è il maggior investitore, potrebbe trovarsi a perdere denaro semplicemente mantenendo operativi i propri servizi su larga scala. Ecco perché allarga il suo perimetro. Opera su un parco dati enorme, ma riguarda sostanzialmente le informazioni pubbliche. Non ha accesso a quelle private delle imprese o delle istituzioni, macina la farina disponibile a tutti. Bisogna invece addestrare modelli linguistici basati su dati nuovi e più sofisticati, i quali vanno pagati. Tutto ciò che è gratis ha meno valore, per l’intelligenza naturale come per quella artificiale. Di qui l’esigenza di costruire Large Language Models (LLM) specializzati, ritagliati sui bisogni specifici: “Dimmi quello che non so ancora”, in altre parole, non mettere insieme soltanto quel che già conosco, anche se lo fai in modo più veloce e completo. Occorre una maggiore potenza di elaborazione dei dati e un approccio diverso, non più generico, ma su misura. E’ quel che stanno cercando di fare alcune aziende, accoppiando propri computer e modelli linguistici fatti in casa, nel nostro caso in italiano. Ce ne sono già diversi per le imprese, per la pubblica amministrazione o le università. Citiamo iGenius per i mercati finanziari o Miia (Modello italiano di intelligenza artificiale) di Fastweb+Vodafone, che ha stretto accordi con editori grazie ai quali garantire la qualità dei dati dalla quale dipende anche il loro valore. Tramonta l’epoca del dato “selvaggio”, rubato a chi ha tanto faticato per elaborarlo (scienziati, imprenditori, giornalisti), e si stanno muovendo i primi passi in un territorio inesplorato.
Adriano Vlad Starrabba, che ha fondato Prometheux a 25 anni, sostiene il connubio tra umanesimo e AI, alla base del modello europeo
C’è però il rischio che si formi una Babele digitale. “Abbiamo creato AI Work, un aggregatore di tanti modelli grazie al quale con un’unica licenza è possibile avere accesso, oltre a Miia, anche a diversi LLM disponibili con la certezza che i dati restano in Italia. Dati sicuri e migliori sul mercato. Già cinquemila piccole aziende lo hanno adottato”, ci dice Magnino. Fastweb+Vodafone non sviluppa solo un proprio modello linguistico, possiede anche un supercomputer, Fastweb AI Factory, basato sull’architettura di Nvidia, uno dei più potenti in Italia. Numero uno è ancora Hpc 6 dell’Eni, poi c’è Leonardo gestito da Cineca nel Tecnopolo di Bologna. Sono rispettivamente il sesto e il decimo al mondo, i primi tre sono americani, il quarto tedesco, il quinto è Eagle di Microsoft, al settimo posto il giapponese Fugaku, poi arrivano la Svizzera e la Finlandia. L’Europa, insomma, non sta così male e l’Italia non è rimasta indietro. La vera rincorsa riguarda il software, e qui piccoli campioni crescono.
Unicorni e capitali di ventura
Linguaggi più supercomputer, la stessa strada è stata seguita anche da Uljan Sharka. Per lui l’intelligenza artificiale è ancora in culla, o come preferisce dire “un motore incompleto”: perché si sviluppi non basta prenderla in affitto, bisogna svilupparla in proprio. Vaste programme, ma Uljan non si scoraggia. Ha cominciato davvero dal basso, nato nel 1992 ricorda la dura infanzia in Albania prima di venire in Italia dove ha coltivato, studiando da solo, la passione per l’informatica. A 16 anni era un clandestino, si è imbarcato per andare a Londra, è stato bloccato dai carabinieri a Milano. Quattro anni dopo, nel 2012, fonda iGenius (oggi si chiama Domyn) con pochi capitali e un solo dipendente (lui stesso che si fa in quattro), trova un sostegno da Google e dall’Enel, così riesce a varare la prima versione di Crystal in grado di classificare in modo automatico, sulla base di informazioni note, le richieste commerciali e conoscere le esigenze degli utenti. Con le tecnologie tradizionali, gli utenti devono inserire migliaia di esempi e domande per addestrare adeguatamente l’AI: Crystal invece classifica i dati in modo automatico, saltando completamente questo passaggio. Ciò consente anche di dimezzare la potenza di calcolo. Domyn ha 100 dipendenti e fattura oltre 3 milioni di euro, ha clienti eccellenti tra i quali anche Intesa Sanpaolo, ma Uljan non si ferma e sta realizzando Colosseum, il supercomputer progettato per consentire alle imprese di sviluppare e governare i propri modelli linguistici.
Luca Ferrari ha cominciato a Copenaghen con l’idea di piegare i cucchiai attraverso la sola forza della mente, come fa il monaco bambino nel film Matrix. Così chiama Bending Spoons, la società che fonda nella capitale danese insieme ad alcuni amici: Francesco Patarnello, originario di Padova, Matteo Danieli di Vicenza e Luca Querella di Torino. Tre laureati all’Università di Padova, uno al Politecnico di Torino; il quinto, Tomasz Greber, è polacco. Ferrari è nato nel 1985 a Settimo di Pescatina, frazione di un piccolo comune nel veronese, dove i genitori fanno i parrucchieri. Si laurea in ingegneria, poi frequenta la Technical University di Copenaghen con in testa Herman Hesse e Benjamin Franklin, i suoi ispiratori, e con una gran voglia di farsi largo nella foresta delle app. Dopo un primo insuccesso, nel 2013 fonda Bending Spoons, che un anno dopo si trasferisce a Milano. Un cervello di ritorno e non solo. Il successo arriva nel 2020 grazie al Covid-19, o meglio grazie a Immuni, l’applicazione scelta dal governo. Da allora è tutta una corsa: nel 2023 acquisisce l’americana Evernote, che si sposta anch’essa a Milano. Poi arriva l’olandese WeTransfer, la piattaforma di condivisione dei file. Il balzo nell’AI avviene ora con Remini, editor di immagini che sta incontrando grande successo.
Luca Ferrari, ceo di Bending Spoons, spiega che l’Italia non ha un problema di mancanza di capitali, ma limiti normativi, burocratici e culturali
Raggiunto il valore di un miliardo di euro, ormai si può considerare un unicorno, come Scalapay (quella del “compra oggi paga domani”) fondata in Australia da Simone Mancini, classe 1987, quinto figlio di due missionari laici immigrati da Empoli (anche lui è tornato, anche lui ha trovato qui l’America). Si sta avvicinando al traguardo la stessa Exein fondata da Gianni Cuozzo. Nato nel 1990 a Darmstadt, in Germania, da una famiglia salernitana, da giovane fa parte di un collettivo di hacker tedesco; sicurezza, difesa e strategia sono le sue passioni, nel 2014 fonda a Malmö, in Svezia, una società per lo sviluppo di armamenti informatici chiamata Prism Warfare, collabora con la Nato e con l’Onu, è considerato uno dei maggiori esperti internazionali di cyber security; nel 2018 a Roma nasce Exein che cresce a più non posso, fin oltre quattro volte l’anno, sfiora i 20 milioni di ricavi, apre sedi all’estero, anche negli Stati Uniti. Una società italiana costretta a crescere all’estero? “Abbiamo venduto le prime licenze in Corea del Sud — ha raccontato Cuozzo al Corriere della Sera — nella pubblica amministrazione italiana è quasi impossibile per una startup entrare: non è un problema di soldi, ma di accesso. Senza una riforma degli uffici acquisti, l’innovazione non passa”. La scelta è stata quindi obbligata: pensare globale dal primo giorno, tanto che “oggi il 40-50 per cento del fatturato arriva dall’Asia-Pacifico”.
Il prossimo obiettivo è andare in borsa nel 2030, e potrà essere aiutata dalla JPMorgan che le sta a fianco. Non più start-up né unicorno, dunque, ma un’altra “azienda giovane”, proprio come si definisce Prometheux, fondata nel 2022 a Londra da un ingegnere romano che allora aveva 25 anni, Adriano Vlad Starrabba. Studi nel prestigioso liceo classico Visconti e a Roma Tre, l’università pubblica con aplomb anglo-americano, dove si laurea. A Oxford per il master, incontra il suo mentore Georg Gottlob, guru austriaco che, partito dalla logica pura, è approdato all’intelligenza artificiale. Ha lavorato spesso anche in Italia e dal 2023 si è trasferito all’università di Calabria, mentre il giovane Vlad Starrabba passava dalla teoria alla prassi. Prometheux processa informazioni nei campi più diversi, dalla farmaceutica alla vigilanza bancaria (l’esordio è avvenuto proprio in questo campo con la Banca d’Italia), l’obiettivo è connettere i dati mettendo insieme intelligenza artificiale e umana. La sede resta a Londra dove comunque “c’è una marcia in più”, ammette con il Foglio il fondatore e amministratore delegato di quella che definisce “azienda giovane più che start up”, anche perché sta raggiungendo una taglia di tutto rispetto. Adriano non si considera affatto un cervello in fuga, passa la vita tra Londra, Roma, Positano (d’estate) e almeno due volte l’anno nella Silicon Valley dove con tutte le possibili stranezze americane c’è pur sempre il “sacro fuoco” dell’innovazione dirompente. Ma crede fino in fondo nel connubio tra umanesimo e intelligenza artificiale, alla base del modello europeo.
L’AI nello stivale
Se le idee frullano e le nuove menti brillano, se abbiamo inventori e innovatori, allora che cosa ha frenato finora l’Italia? I soldi, forse? “E’ una balla che il problema italiano sia la mancanza di capitali”, dice Luca Ferrari. Il venture capital è arrivato in ritardo, ma oggi ci si sono gettati in molti, non solo la Cassa depositi e prestiti che ha comunque il fondo più importante, ma privati come la Exor con Vento, Angelo Moratti con Angel Capital, Alessandro Benetton con 2100 Venture, o le maggiori banche come Intesa con Neva e Unicredit con Start Lab. I limiti, semmai, sono normativi, burocratici e culturali, tra avversione al rischio e scarsa propensione alla pratica: “Tra pragmatismo e teoria, siamo teoria e non pratica. L’altro grande freno è la paura di fallire”. La pensa così anche Adriano Vlad Starrabba ed è uno dei motivi che lo fanno restare a Londra, non a caso è stato Samuel Beckett a scrivere la frase che più piace ai giovani imprenditori: “Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”. Ma non è sempre così. Ci vuole magari una “spinta gentile”, come hanno teorizzato Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein nel loro best seller.
Secondo il presidente della Cdp Giovanni Gorno Tempini, intervistato dal Foglio, l’AI nella manifattura sarà la novità più rilevante dell’anno anche in Italia. E’ inutile inseguire le “magnifiche sette sorelle”, non potremo mai mobilitare trilioni su trilioni di dollari. Ma “l’Europa (e in particolare l’Italia) ha una forza in questo campo che manca agli Usa, il tentativo di Trump di riportare la manifattura negli Stati Uniti è difficilissimo, tanto quanto il tentativo dell’Europa di recuperare il gap con le Big Tech. Se invece parliamo di sposare l’AI con la manifattura abbiamo molto da dire, noi italiani in primo luogo”. Un uso realistico e diffuso dell’AI farebbe compiere un salto al modello europeo che non è di per sé condannato a restare schiacciato tra Cina e Stati Uniti. Un aiuto “gentile” potrebbe essere anche un impegno a far sì che le pubbliche amministrazioni si rivolgano innanzitutto alle imprese del vecchio continente. Paradigma europeo e variante nazionale, un’accoppiata promettente. Il modello italiano basato sull’innesto dell’AI nella solida cultura manifatturiera potrebbe diventare un caso da studiare come lo sono stati i distretti. C’è molto da fare. L’Italia ha ancora un basso livello di alfabetizzazione digitale e non sono sufficienti i laureati nelle facoltà collegate, i cosiddetti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Occorre uno stretto e chiaro rapporto tra pubblico e privato, ma lo sforzo maggiore spetta alle imprese, sia quelle che sviluppano linguaggi o robot, sia quelle che debbono trasformarsi inglobando le nuove tecnologie. E’ lì la culla dell’innovazione; lo stato resta una sovrastruttura, talvolta utile, troppo spesso dannosa.