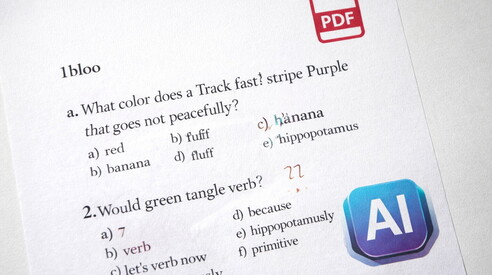Ansa
il foglio ai
La lezione da Crans-Montana: si può raccontare un dolore enorme senza trasformarlo nel processo a un paese. In Italia, quasi mai
La tragedia di Crans-Montana è stata raccontata con sobrietà, evitando di trasformarla in una condanna collettiva. Una lezione che in Italia manca spesso: dove il dolore diventa pretesto per accusare l'intero paese, anziché per cercare la verità
C’è un dettaglio che colpisce, a distanza di tempo, nel modo in cui la tragedia di Crans-Montana è stata raccontata e metabolizzata: la sua ostinata resistenza a diventare altro da sé. E’ rimasta ciò che era – una tragedia – senza essere promossa a simbolo universale del “paese che non funziona”, del “sistema che crolla”, dell’ennesima prova generale di una colpa collettiva. Nessuna scorciatoia morale, nessuna tentazione di usare il dolore come grimaldello per spiegare tutto il resto. E’ un punto che può sembrare secondario, persino freddo, ma non lo è. Perché dice molto del rapporto che una società intrattiene con i fatti, con le responsabilità, con la propria autostima. In Svizzera l’attenzione si è concentrata su ciò che contava: le vittime, l’accertamento puntuale delle cause, le eventuali responsabilità individuali, le misure per evitare che accada di nuovo. Il racconto pubblico non ha chiesto alla tragedia di farsi manifesto, parabola, accusa generale. Non le è stato chiesto di parlare “a nome” del paese. In Italia, molto spesso, succede l’opposto. Ogni disastro diventa immediatamente un racconto totale. La morte non basta: deve dimostrare qualcosa. Deve spiegare perché siamo un paese sbagliato, perché tutto è marcio, perché nulla funziona. E’ una dinamica quasi automatica, che scatta prima ancora che i fatti siano chiari. Il dolore viene arruolato in una narrazione più grande, che spesso ha già un copione pronto. E’ quello che potremmo chiamare, con un termine brutale ma efficace, “schiettinizzazione”: la trasformazione di ogni tragedia in atto d’accusa sistemico, in simbolo definitivo di un fallimento nazionale.
Testo realizzato con ai
Il risultato è paradossale. Da un lato si proclama empatia, dall’altro si toglie alla tragedia la sua specificità. Le vittime diventano comparse di una storia più grande, funzionale a un discorso che prescinde da loro. Il lutto si fa argomento. Il fatto concreto si dissolve nella metafora. E, alla fine, non si capisce più nulla: né cosa sia successo davvero, né cosa andrebbe corretto davvero. A Crans-Montana è successo l’opposto. La sobrietà del racconto non ha significato rimozione, né indifferenza. Ha significato rispetto per la complessità. L’idea, molto poco spettacolare ma molto solida, che una tragedia possa essere valutata, capita, affrontata senza diventare la radiografia morale di un’intera nazione. Che si possa distinguere tra errore, fatalità, responsabilità precise e difetti strutturali, senza fonderli in un’unica accusa indistinta.
C’è anche un altro elemento, più profondo. Non trasformare ogni tragedia in simbolo significa avere fiducia nel fatto che un paese non si spiega solo nei suoi momenti peggiori. Che l’identità collettiva non è appesa a ogni incidente, a ogni crollo, a ogni morte. In Italia, invece, sembra spesso che il racconto nazionale viva di questi picchi negativi, come se avessimo bisogno del disastro per dirci chi siamo. Forse la differenza non sta solo nei media o nella politica, ma in una postura culturale. Nel rapporto con la responsabilità. Nel rifiuto di usare il dolore come scorciatoia narrativa. La tragedia di Crans-Montana, raccontata senza diventare il simbolo di tutto, suggerisce che si può essere severi senza essere autolesionisti. Che si può cercare la verità senza trasformarla in una condanna generale. E’ una lezione delicata, quasi invisibile. Proprio per questo, preziosa.