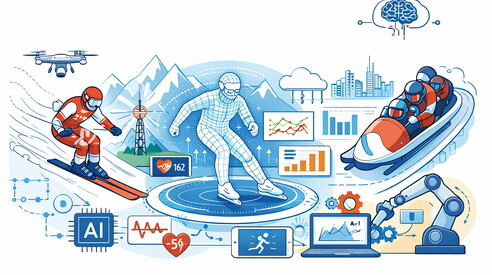Foto: Ansa.
FOGLIO AI
Ilva, la lezione amara dei peggiori “ismi” italiani e dei loro danni
Come la vicenda di Taranto riflette i vizi che frenano l’Italia: ideologia, populismo, immobilismo. Uno studio di Assonime
Ci sono storie che diventano simboli, e ci sono simboli che diventano radiografie. L’Ilva di Taranto è entrambe le cose. È una vicenda industriale, sociale e ambientale che da decenni occupa le prime pagine, e al tempo stesso è la lastra radiografica di un Paese che sa descrivere i suoi problemi ma fatica a risolverli. Lo studio appena pubblicato da Assonime – e che Il Foglio anticipa – lo dice con una chiarezza cristallina: l’Ilva è la cartina al tornasole degli “ismi” italiani. Quegli stessi “ismi” che non solo hanno tenuto intrappolata l’acciaieria più grande d’Europa, ma che continuano a condizionare ogni grande decisione industriale e politica del nostro paese. Ambientalismo ideologico, populismo giudiziario, immobilismo politico. Ma anche clientelismo locale, statalismo senza strategia, nazionalismo industriale mal gestito. È la sindrome italiana elevata a caso di scuola.
Partiamo dall’ambientalismo ideologico. Quando nel 2012 scattarono i sequestri degli impianti dell’Ilva, la motivazione era semplice e comprensibile: ridurre le emissioni, salvare vite, rispondere all’allarme sanitario. Ma la dinamica fu tutt’altro che lineare. Si applicarono prescrizioni tratte da conclusioni europee non ancora recepite nell’ordinamento italiano. Si chiesero abbattimenti delle emissioni in tempi irrealistici, senza adeguate compensazioni né strumenti tecnici pronti. Risultato? Non un miglioramento ambientale proporzionato, ma un crollo produttivo devastante. Un pezzo di verità che lo studio definisce “un esproprio senza indennizzo”: la fabbrica è rimasta al suo posto, ma svuotata di prospettiva, di credibilità e di capacità di produrre. La lezione è amara: quando l’ambientalismo si fa ideologia, il rischio è quello di moltiplicare i danni senza ottenere i benefici. Vale per Taranto, ma anche per il resto del paese, dove transizioni ecologiche annunciate e mai pianificate rischiano di diventare freni più che motori di sviluppo.
Poi c’è il populismo giudiziario. La vicenda Ilva è stata segnata da un uso espansivo e creativo del diritto penale. Sequestri, confische, e inchieste trasformate in politica industriale surrogata. Ogni governo, da Monti a Renzi, da Gentiloni a Conte, si è trovato costretto a varare decreti “Salva Ilva” per aggirare decisioni giudiziarie che paralizzavano l’impianto. Ma ogni decreto alimentava a sua volta un conflitto istituzionale senza fine: procure contro esecutivi, giudici contro ministri, norme emergenziali contro sentenze. In questa spirale, i lavoratori restavano ostaggi, le bonifiche si fermavano, le famiglie di Taranto venivano usate come scudi morali. È la fotografia del populismo giudiziario che non riguarda solo l’Ilva: è la stessa logica che vediamo nelle grandi opere bloccate da esposti e tribunali, nelle infrastrutture ostaggio di carte bollate, nelle aziende scoraggiate dall’investire in Italia per paura che una firma possa trasformarsi in capo d’imputazione.
Il terzo “ismo” è l’immobilismo politico. In undici anni di decreti e commissari, l’Italia avrebbe potuto avviare una transizione dell’acciaio da leader europeo: forni elettrici, produzione di Dri (ferro ridotto diretto), integrazione con le rinnovabili. Il mondo correva in quella direzione, Berlino e Stoccolma investivano miliardi, e noi restavamo al palo. Assonime ricorda con durezza che l’Italia ha perso l’occasione di usare i fondi europei, di attrarre investitori internazionali, di rendere Taranto un laboratorio del green steel. Invece, nulla: scelte rimandate, progetti congelati, soluzioni rimandate a un “anno prossimo” che non arriva mai. È la stessa paralisi che si vede in tanti altri settori: dalla digitalizzazione alla politica energetica, dalla giustizia alla scuola. Un Paese che si muove solo sull’onda dell’emergenza, mai sulla base di una strategia.
Ma non finisce qui. C’è anche il clientelismo locale, che ha reso l’Ilva terreno di contesa per enti e amministrazioni. Ogni autorizzazione un’occasione di scontro, ogni progetto di rigassificazione o di riconversione un’occasione di veto. Nel frattempo, migliaia di famiglie tarantine restavano sospese tra la paura di perdere il lavoro e il timore per la salute. Anche qui, la lezione è nazionale: l’Italia è piena di piccoli feudi amministrativi capaci di bloccare ogni opera strategica, di trasformare ogni investimento in un labirinto di ricorsi, di mettere interessi di corto respiro davanti a obiettivi di lungo periodo.
Infine, lo statalismo senza strategia. Lo Stato è rientrato due volte nell’Ilva: con l’amministrazione straordinaria del 2013 e con quella del 2021. Ma senza un disegno industriale, senza una visione della siderurgia italiana nel mondo globalizzato. Ha accumulato passività per miliardi (oltre 4,7 nel 2025), ha garantito stipendi e tenuto accesa la luce, ma non ha mai deciso se e come rilanciare davvero la fabbrica. È il “nazionalismo industriale” all’italiana: evocato come orgoglio, praticato come rinvio.
Lo studio di Assonime, dunque, non è solo un’autopsia dell’Ilva. È un referto sullo stato della Repubblica. Quegli “ismi” che hanno strangolato Taranto sono gli stessi che impediscono all’Italia di crescere: ambientalismo ideologico che blocca le scelte pragmatiche, populismo giudiziario che sostituisce il diritto alla politica, immobilismo che fa perdere le occasioni, clientelismo che mette la rendita davanti allo sviluppo, statalismo che confonde la tutela con la paralisi.
Ecco allora l’aspetto forse più interessante: l’Ilva non è un’eccezione, è un paradigma. È la stessa logica che ritroviamo in altre grandi vertenze: nelle infrastrutture energetiche, dove i rigassificatori si fanno solo quando la crisi esplode; nelle autostrade e nelle ferrovie, dove i cantieri si aprono e si chiudono al ritmo dei ricorsi; nella gestione dei rifiuti, dove l’ideologia verde impedisce soluzioni tecnologiche adottate ovunque in Europa. È un’Italia che racconta molto bene i suoi problemi, che produce studi e commissioni, che convoca tavoli e annuncia piani, ma che raramente imbocca la strada della decisione.
La domanda allora è semplice: vogliamo continuare a raccontare la tragedia infinita dell’Ilva come un caso unico, oppure vogliamo leggerla come uno specchio? Perché se scegliamo la seconda opzione, la lezione è chiara. Il paese che si indigna a giorni alterni per Taranto è lo stesso che si rassegna a convivere con i suoi vizi strutturali. Ilva non è solo un’azienda, è un avvertimento. E se non impariamo da quella storia, non sarà solo l’acciaio a mancare: sarà la possibilità di essere finalmente un paese capace di decidere.