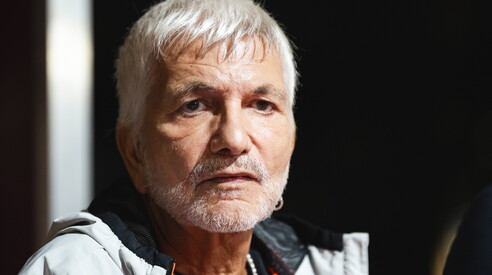FOTO Google Creative Commons
l'intervento
Ragioni solide, e di sinistra, per dire di “sì” alla separazione delle carriere
La sinistra non ha soltanto consentito, ma ha anche guidato, il processo di riforma che oggi può trovare compimento con la separazione delle carriere. Nel 1999 fu il centrosinistra a promuovere il lavoro politico-parlamentare sul principio del giusto processo
La campagna per il referendum sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati requirenti da quelle dei magistrati giudicanti è partita sotto i peggiori auspici. Il primo ad imbrogliare le carte è stato il Ministro Nordio (Il Dubbio-16-11-24): “Siete contenti, cari cittadini, di com’è oggi la magistratura? Se non lo siete, votate sì al referendum confermativo“. Subito seguito da Giovanni Donzelli (FdI): “Il referendum sulla separazione delle carriere lo vincerà il popolo di Garlasco“. A sua volta superato da Francesco Boccia (PD), secondo il quale il vero oggetto del referendum sarebbe addirittura “impedire a Meloni di assumere i pieni poteri… Fermare la riforma per fermare Meloni”.
Nessuno dei principali protagonisti della politica italiana sembra mettere nel conto la possibilità di condurre il confronto sul merito della riforma e del quesito referendario: la separazione è necessaria? E’ coerente con il dettato costituzionale o lo stravolge? La riforma accresce le garanzie per i cittadini o le minaccia? Già vedo i sorrisini di compatimento: veramente pensate che sia possibile l’approccio contrario? Cioè che il voto – su di una questione così complessa – possa essere il risultato di un’attenta valutazione delle soluzioni di riforma adottate, e non di una scelta di collocazione politica più generale: pro o contro il governo; destra o sinistra; Meloni o Schlein? Non sono ingenuo: che il referendum si inserisca come un fattore importante nel contesto del conflitto governo-opposizione è, in una certa misura, inevitabile. Ciò che mi pare inaccettabile è che la lunga esperienza di elaborazione, lotta e proposta politica compiuta – in tema di cura per il nostro malato sistema giustizia – dalla sinistra di governo nel corso di decenni venga completamente obliterata, vittima di un conflitto che traduce tutto in un eterno “o noi o loro”. Perché non solo non è conveniente (occhio ai sondaggi sulle intenzioni di voto per i partiti). Non solo non riconosce i cittadini come adulti capaci di giudicare, ma costituisce un’aperta rottura di continuità con l’atteggiamento politico tradizionale della sinistra in materia di equilibrio del rapporto tra i poteri e, più in generale, di assetto delle istituzioni repubblicane.
Ecco perché noi di Libertàeguale – un’associazione di cultura politica che ha i piedi ben piantati nel centrosinistra italiano e gli occhi puntati sulla realtà del paese, che soffre del cattivo funzionamento del sistema giustizia – ci siamo dati il compito di condurre una campagna per il sì alla riforma che stia al quesito e sia coerente col contributo di iniziativa riformatrice che, su questa materia, ha fornito la sinistra. Un compito difficile, ma non impossibile: in tema di giusto processo e di separazione delle carriere siamo seduti sulle spalle di giganti della cultura del riformismo liberalsocialista come Giuliano Vassalli ed Emanuele Macaluso.
Il primo è da tutti considerato il padre del rito accusatorio, introdotto in Italia alla fine degli anni 80. Con un’onestà culturale cristallina e una coerenza teorica ferrea fu proprio lui, in una memorabile intervista al Financial Times del 19-2-87, a prevedere che, senza la separazione delle carriere, il “suo” rito accusatorio non avrebbe funzionato: “è assolutamente incompatibile con molti altri dei principi destinati a restare in vigore nel nostro diritto e in particolare con il nostro ordinamento giudiziario. In particolare… ho detto che parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, che ha… che non avrà più gli stessi poteri del giudice come li ha oggi, ma che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno degli elementi che non renderanno molto leale parlare di sistema accusatorio”.
Il secondo, Emanuele Macaluso, ha dedicato i suoi sforzi a combattere – nella sinistra italiana – il germe devastante del giustizialismo, che considerava la più importante manifestazione/conseguenza della crisi della politica: le riforme, non il tentativo di sottomettere gli organi di controllo agli ordini della politica stessa, sono la risposta giusta al tentativo della magistratura requirente di esondare dal suo alveo, come dimostra il suo continuo ricorso alla categoria del consenso popolare, propria della politica democratica e non degli organi di controllo.
Sì al giusto processo – accusa e difesa su di un piede di parità di fronte al giudice terzo –, perché la Costituzione presume l’innocenza e non la colpevolezza; riforme per reagire al cancro del populismo giustizialista: fu alla luce di questi due principi ispiratori che il centrosinistra, nella seconda metà degli anni 90 (a proposito di conflitto tra Governo e opposizione: difficile dire che, allora, la contrapposizione non fosse almeno altrettanto aspra dell’attuale), guidò il lavoro politico-parlamentare che condusse - nel 1999 - all’introduzione in Costituzione, con voto quasi unanime, del nuovo articolo 111, col principio del giusto processo. Era la premessa necessaria per giungere a superare l’impedimento strutturale di cui parlava Vassalli più di 10 anni prima. Non fu un caso che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2000, ammettendo il primo tentativo di referendum sulla separazione delle carriere, potesse apertamente sostenere che né la distinzione delle funzioni, né la separazione delle carriere violassero alcun principio costituzionale.
Si può dunque, a buon diritto, sostenere che la sinistra non ha soltanto consentito, ma in larga misura guidato il processo di riforma che può oggi trovare compimento con la separazione delle carriere. La riforma che in queste ore viene approvata dal Parlamento - in un clima di reciproca, pregiudiziale chiusura -, è perfetta? Tutt’altro: il pasticcio del sorteggio per la nomina dei togati dei due CSM, per quanto motivato dall’esigenza di fare i conti con un problema reale, la degenerazione correntizia, resta tale e appare più figlio dell’approccio “uno vale uno” che di una destra liberale. C’erano e sono state proposte (Ceccanti) alternative più equilibrate. Sarebbe stato possibile tentare una soluzione concordata (il Pd vota sì alla separazione, mentre la maggioranza toglie di mezzo il sorteggio). Ora però il referendum impone la scelta tra il sì e il no. Per me, la separazione delle carriere vale più, in positivo, del negativo sorteggio per il CSM.