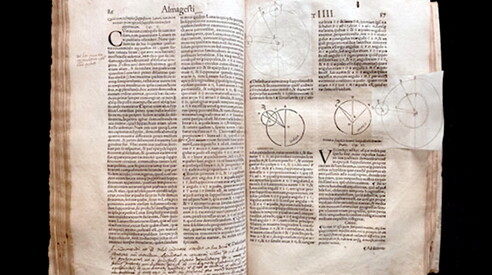Renato Guttuso, “Zolfara”, olio su tela, 1953 (foto Ansa)
Nobili Alfabeti. La Sicilia dalla A alla Z per Pirandello, Sciascia e Camilleri
Se nello zolfo i tre alfabeti dei tre scrittori si incontrano, nelle donne si allontanano. Dolori personali che diventano allegorie universali. La parola come superficie instabile che non coincide mai con la verità
Vedi alla voce Zolfo. L’odore che punge, la polvere che soffoca, la fatica che scava sottoterra. E’ il filo che lega Pirandello, Sciascia e Camilleri: ritorna sempre, come una lettera incisa a fuoco. Se l’Italia si facesse a parole, la Sicilia sarebbe un alfabeto al contrario. Che comincia nelle viscere delle miniere con la Z di Zolfo e finisce con la A di America, la terra promessa che spalanca orizzonti e sogni di riscatto sociale. Accade così quando le cose sono troppo complesse da spiegare: per decifrarle devi ridurle all’osso, trasformarle in lemmi. Semplificare, sì, ma solo in apparenza. Perché in quell’ordine minimo ogni lettera è una miccia: basta nominarla e tutto esplode. E’ l’intuizione che ha guidato Repubblica Palermo quando, nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, ha pubblicato Le parole di Camilleri: un dizionario sentimentale che prova a racchiudere un universo in 24 voci, dalla A di Arancini alla Z di Zolfo. Non per costringerlo in una cornice, ma per aprire corridoi laterali, riportare a galla storie, ricordi, ossessioni. Un gioco serissimo che affonda le radici in una piccola tradizione tutta siciliana, inaugurata da Leonardo Sciascia con l’Alfabeto pirandelliano e poi trasformata in metodo da Matteo Collura con l’Alfabeto eretico, poi ribattezzato Alfabeto Sciascia.
Lo zolfo resta il punto d’incrocio. In Pirandello è un affare di famiglia e una ferita personale. Suo padre, don Stefano, scommette tutto sulla zolfara di Aragona: un azzardo che inghiotte anche la dote della moglie dello scrittore, Antonietta Portulano detta Nietta, settantamila lire bruciate sotto terra. Quel fallimento non è solo economico: brucia speranze, scava rancori, segna la mente fragile di Nietta, trasforma un sogno di ascesa in rovina. E’ la materia stessa di cui si nutre la Sicilia: oro giallo che promette ricchezza e consegna miseria, simbolo di un progresso che si spezza proprio quando sembra a portata di mano. Nella miniera che crolla si riflette il destino di una borghesia fragile, pronta a sognare ma incapace di reggere l’urto. Pirandello impara la lezione presto: la vita può franare all’improvviso, come una galleria che cede. E tutto entra nella sua immaginazione – la polvere delle viscere, il sudore degli uomini piegati dal buio, il rumore sordo dei crolli – trasformandosi in allegoria della condizione umana. Lì dove la Sicilia precipita, il suo teatro trova la radice più autentica.
Lo zolfo, oro giallo che promette ricchezza e consegna miseria. Nella miniera che crolla si riflette il destino di una borghesia fragile
In Sciascia lo zolfo è un destino familiare e collettivo. Il nonno carusu, poi capomastro e impiegato. Il padre nella stessa miniera, come il fratello Giuseppe, morto suicida a venticinque anni, con un colpo di pistola alla testa, durante uno sciopero di zolfatari nelle campagne di Assoro, in provincia di Enna. “Forse proprio in quella morte sta la radice della sua inquietudine morale”, scrive Collura. Non è solo un dettaglio biografico: è il fondale di un’intera opera. Perché, dice Sciascia, “senza l’avventura della zolfara non ci sarebbe stata l’avventura dello scrivere, del raccontare”. La miniera è la lente che gli permette di leggere la disuguaglianza, il lavoro sfruttato, la disperazione di un popolo costretto a vivere sottoterra. Collura, nel suo alfabeto, lega i due destini ricorrendo alle parole della figlia di Sciascia, Anna Maria: “Entrambi figli dello zolfo, con una differenza: i Pirandello gestivano le miniere, gli Sciascia vi lavoravano. Due tragedie si consumano nelle due famiglie all’ombra dello zolfo: la follia di Antonietta, il suicidio di Giuseppe”. E’ in questa frattura che si misurano due forme diverse di letteratura: Pirandello trasforma la rovina in metafora della fragilità dell’io, Sciascia muta il lutto in coscienza critica. Per entrambi, però, la miniera resta simbolo di annientamento, matrice oscura da cui nasce la necessità di scrivere.
In Camilleri lo zolfo è, invece, radice genealogica che diventa memoria collettiva. Il legame risale al nonno Giuseppe, che sposò Carmelina Fragapane in un “matrimonio di surfaro”: un’alleanza tra famiglie di piccoli imprenditori legati alle miniere. Doveva essere un trampolino di prosperità, si rivelò invece un’illusione presto sgretolata dal predominio delle grandi compagnie straniere, la Anglo-Sicilian Sulphur Company degli Ingham e dei Florio. Da quel momento è un lento impoverimento: la famiglia Camilleri scivola in quella che Andrea definisce una “dignitosa miseria”, marchio di una borghesia che aveva sfiorato il progresso senza mai afferrarlo davvero. Nei suoi romanzi lo zolfo non appare come ferita privata né come destino civile, ma come memoria condivisa: come odore, polvere che impregna le parole dei personaggi, cicatrice di un passato che ancora grava sul presente. E’ la voce corale di un territorio che non dimentica. Gaetano Savatteri, che firma la prefazione dell’alfabeto camilleriano, lo spiega netto: “La Z di Zolfo è centrale per Camilleri, per Sciascia, per Pirandello. Lo zolfataro veniva pagato ogni settimana con la giusta. Il sabato si comprava i vestiti nuovi, giocava a zecchinetta, beveva in taverna. Poi tornava sottoterra, con la paura di non risalire più. Negli zolfatari c’era la disperazione assoluta”.
Se nello zolfo i tre alfabeti si incontrano, nelle donne si allontanano. In Pirandello la N di Nietta è la ferita intima che plasma un’intera drammaturgia. Sciascia la mette al centro del suo alfabeto: “Nietta, la moglie, è la follia che scava, ma anche la fedeltà di un uomo che non abbandona”. Pirandello le resta accanto fino alla fine. Le figure femminili che attraversano i suoi testi portano le stesse crepe: dalla protagonista di Vestire gli ignudi, fragile e ferita, alla signora Ponza di Così è (se vi pare), che incarna l’impossibilità di afferrare una verità unica. In Nietta c’è il seme di tutte loro: non simbolo astratto, ma dolore personale che diventa allegoria universale.
Per Sciascia, invece, la donna non è ferita né ossessione, ma genealogia morale. Viene tutto dalle zie, “donne forti, con poche tenerezze e molta fermezza: da loro Sciascia imparò a non concedere indulgenze”, scrive Collura. Figure appartate, severe, custodi di disciplina e senso critico, “vivevano in un mondo di sobrietà e silenzio, capace di lasciare impronte più profonde di tante parole”. Non diventano personaggi romanzeschi, ma restano radici private che alimentano una coscienza pubblica. Con Camilleri lo scenario cambia. Nei suoi romanzi le donne sono figure laterali. Elvira Seminara, alla quarta lettera dell’alfabeto, le scompone e ricompone: “Non protagoniste, ma figure di cornice, a volte stereotipi, a volte lampi di vitalità”. Livia rimane distanza, più che azione. Le altre compaiono e scompaiono. Non c’è indulgenza, né volontà di elevarle a eroine: sono specchi obliqui, frammenti che si accendono e si spengono. Qui Camilleri non si piega: consegna figure più verosimili che salvifiche, relazioni che si logorano a distanza, come con Livia, o che si consumano in incontri rapidi, sensuali, destinati a spegnersi senza lasciare traccia. Quando una donna emerge, lo fa per restituire la misura di una quotidianità fatta di corpi, desideri, gelosie. Pennellate d’inchiostro che illuminano per un attimo le pagine, prima di rientrare nell’ombra, lasciando al lettore il compito di cercare altrove il centro.
La lingua è l’altro terreno decisivo. Pirandello la scardina dall’interno: la parola per lui è inganno, superficie instabile che non coincide mai con la verità. Non descrive, ma tradisce, è un continuo cortocircuito tra ciò che si dice e ciò che si è. “Il linguaggio umano non è mai aderente al pensiero”, annota Sciascia leggendo Pirandello, e questa frattura diventa il motore della sua drammaturgia: identità che si sbriciolano, dialoghi che si contraddicono, parole che aprono abissi invece di chiuderli. In Pirandello la parola sembra sempre sul punto di incrinarsi. Nei suoi testi, “ogni parola è maschera, e dietro la maschera c’è un’altra maschera ancora”. La lingua diventa specchio del relativismo: non restituisce mai una verità unica, ma costringe il lettore a muoversi dentro il paradosso.
La parola come superficie instabile che non coincide mai con la verità. Pirandello frantuma, Sciascia lima, Camilleri inventa
Sciascia prende la direzione opposta. Se Pirandello frantuma, lui lima. La sua è una lingua che sembra trasparente, ma dietro quella limpidezza c’è la lama. Collura insiste su questo punto: “La sua prosa è priva di orpelli, asciutta, quasi scarnificata”. Ogni parola è scelta per colpire, non per intrattenere. E’ la lingua della denuncia, della verità che non consola, della cronaca che diventa letteratura senza perdere la sua precisione. Il ritmo è quello di una deposizione, l’effetto quello di una condanna. La lingua diventa atto civile. Ogni parola è scelta, ogni frase un colpo secco. Non c’è compiacimento né barocchismo: il modello è la prosa illuministica, quella che riduce al minimo l’ambiguità per illuminare le zone d’ombra. Lo stesso Sciascia rivendica il suo bisogno di chiarezza: “Scrivo per capire e per farmi capire”. Ma dietro la limpidezza si nasconde la sferzata critica. Nei romanzi come Il giorno della civetta o A ciascuno il suo, la lingua è il luogo in cui si rivela la doppiezza del potere: le mezze frasi dei politici, i silenzi dei magistrati, le parole piegate alle convenienze. Sciascia contrappone a questo linguaggio corrotto la sua scrittura nitida, quasi matematica.
E poi c’è Camilleri, che ribalta ancora una volta la prospettiva. La sua lingua non è né corrosione né incisione, ma invenzione. Il vigatese – quell’impasto di dialetto siciliano e italiano – è la mossa che spiazza: non colore locale, ma codice narrativo nazionale. Nessun glossario, nessuna traduzione, eppure tutti capiscono. Perché quel miscuglio suona naturale, restituisce ritmo e concretezza, fa entrare nella pagina il parlato di una comunità intera. Non a caso, tra le voci del suo alfabeto c’è “Cabbasisi”, l’espressione preferita del dottor Pasquano, il medico legale brontolone che collabora con Montalbano: da sfogo popolare diventa patrimonio condiviso. E c’è “Koinè”, che spiega come la sua lingua sia “corpo vivo, miscela capace di farsi capire ovunque”. Il confronto è netto. Pirandello mostra la frattura tra parola e realtà, Sciascia usa la lingua come strumento di verità civile, Camilleri la reinventa come laboratorio democratico. Tre linee che non si sovrappongono ma si incrociano, perché tutte partono dallo stesso presupposto: le parole non sono mai innocenti. Nel vigatese che esplode tra le pagine, nella prosa secca che inchioda i potenti, nei dialoghi che svelano la menzogna, la lingua non è ornamento ma sostanza. E, forse, un gesto politico: mostra che l’Italia non è monolite, ma pluralità. E’ qui che gli alfabeti diventano più che giochi letterari: sono radiografie del rapporto fra scrittore e lingua, mappe di un territorio in cui la parola è sempre questione di vita, di potere, di identità.
Il senso di tre alfabeti: non compendi d’autore ma mappe critiche, non esercizi di stile ma modi per leggere la Sicilia e l’Italia intera
Ma perché proprio un alfabeto? Perché la Sicilia, per essere letta, ha bisogno di parole che siano al tempo stesso lampi e fenditure. Collura lo spiega: “E’ una messa a punto, una lente d’ingrandimento sulle pieghe del pensiero, una chiave per leggere la realtà. E’ anche un gioco, certo, ma di quelli che aiutano a comprendere meglio il mondo”. Un gioco che però non ammette leggerezze: per costruire un alfabeto bisogna selezionare, scartare. E’ un lavoro certosino di ricerca: andare a setaccio nel mare magnum delle parole, scegliere quelle capaci di illuminare un universo intero. Non è semplificazione, ma profondità. Con un vantaggio. “Rimettere ordine in un pensiero e nella biografia di uno scrittore, con la presunzione di completezza: provare ad agguantare l’inafferrabile, comprimere un universo che di per sé è inesauribile”, spiega Savatteri. L’alfabeto funziona perché accetta la parzialità: non dice tutto, ma apre porte. Ogni voce è un ingresso, ogni lettera è un grimaldello. E quelle porte, aperte una dopo l’altra, finiscono sempre per ricondurre a un dato elementare: tre scrittori, tre paesi, venti chilometri di distanza. “Pirandello era di Agrigento, Sciascia di Racalmuto e Camilleri di Porto Empedocle – ricorda Savatteri – Un caso? Camilleri aveva la risposta: no, perché scrivere non costa niente. La povertà è un osservatorio drammatico e privilegiato”.
E’ in questa distanza ravvicinata che si capisce il senso di tre alfabeti: non compendi o Bignami d’autore ma mappe critiche, non esercizi di stile ma modi per leggere la Sicilia e, attraverso di essa, l’Italia intera. Per Pirandello nominare significa esporre la frattura dell’io, per Sciascia smascherare il potere, per Camilleri restituire voce a una comunità. Tre alfabeti diversi, ma mossi dalla stessa convinzione: che le parole non siano mai neutre. Lo sapeva Pirandello, lo sapeva Sciascia, lo sapeva Camilleri. E allora non resta che questo: continuare a nominare. Ogni lettera è una scintilla, ogni voce è una ferita che si riapre, ogni parola un modo per guardare il presente. Se l’Italia si fa a parole, la Sicilia resta il suo alfabeto più inquieto e necessario.