
Una scena de “La terrazza” (1980) di Ettore Scola
magazine
Chi sono gli intellò, schiere conformiste contro i politici con le radici nel Novecento
In principio fu Émile Zola con il suo celebre "J'accuse" a incarnare la voce pubblica della conscienza e l'interprete della purezza, per poi scivolare pian piano in un lamento e in una recriminazione continua. Niente di nuovo da ciò che vediamo anche oggi
La prima volta dell’entrata in scena degli intellettuali in senso moderno è quella dei philosophes del 700 che avevano fornito l’arsenale ideologico alla Rivoluzione francese. Ma il capostipite, il modello, l’archetipo dell’Intellettuale si chiama Émile Zola con il suo celebre “J’accuse” in difesa dell’ufficiale ebreo Alfred Dreyfus perseguitato per un reato mai commesso nella Francia che odiava gli ebrei a cavallo tra Otto e Novecento. L’intellettuale che denuncia. Che proclama. Che declama. Che si indigna. L’interprete della purezza. L’incarnazione della linea Giusta. L’unica anima di una politica senz’anima. La voce pubblica della coscienza. Ma nel corso del tempo Zola è diventato l’intellò, il nome di una posa, di un modo d’essere. Il tuono è diventato via via lamento e recriminazione.
Ora Marcello Veneziani, Marco Tarchi, Franco Cardini si esibiscono nella migliore performance dell’intellettuale in vena di recriminazioni: la destra al governo non è una vera destra, ha sostituito la Politica con l’amministrazione incolore e prosaica, ben altri furono gli ideali, e così via. Ma è sempre stato così. La fenomenologia dell’intellettuale lamentoso, perennemente deluso da una politica che in cuor suo vorrebbe dirigere verso mete più elevate ha una storia gloriosa alle spalle. Di destra e di sinistra. E pure di centro. Un simil-Zola, ma trasversale.
Intanto già la parola “intellettuale” merita una precisazione. Ci sono gli scrittori, gli artisti, i musicisti, gli architetti, i registi, i filosofi, i drammaturghi, gli scienziati e così via i quali, ciascuno nel proprio ambito, sono ammirevoli e brillanti. Poi però, richiamati da un appello incombente, escono dalle loro collaudate competenze, si ricordano di quello stentoreo “J’accuse” e rivivono in una nuova categoria. Diventano intellettuali, intellò. E diventano intellettuali perfettamente conformi al modello non appena abbandonano il campo in cui eccellono e si autoproclamano maestri e maestre del pensiero, fari dell’opinione pubblica, sismografi dello spirito dei tempi, cenacolo di spiriti magni, arbitri del gusto e del buongusto, esperti dell’allarme democratico, custodi della purezza politica e soprattutto etica: cioè quando si avventurano nelle nebbie di un mondo tutto loro e cominciano a straparlare di immagini e concetti di cui non hanno la minima competenza.
Jorge Semprun la chiamava “emiplegia intellettuale”: nella prima metà, nel campo in cui sono sommi rappresentanti, appaiono e sono figure acute, sensibili, luminose; nella metà riservata alla politica sono ottusi, sciatti, spenti, ripetitivi. Disprezzano la fattualità, così grigia e noiosa. Si incantano solo per la grandiosità della “visione del mondo” che la politica da loro sognata dovrebbe illuminare. Anche se Max Weber, un gigante del pensiero, suggeriva che per avere una gradevole e pure istruttiva “visione del mondo” convenisse andare al cinema piuttosto che declamare banalità da un palco. Per di più sommersi dall’applauso della folla che ama gli intellettuali star, i veri progenitori degli odierni influencer, i quali influencer, a loro volta, conquistata la leadership del discorso pubblico, hanno dettato agli intellettuali di nuova generazione lo stile del moderno opinion maker. Tendono al gregarismo, adorano agire in gruppo, si mimetizzano in un confortevole lessico comune, sono terrorizzati dalla solitudine, il conformismo è la loro ragione sociale.
Nel Novecento, il secolo degli intellettuali, degli esteti armati, dei filosofi che vogliono andare al potere come nella “Repubblica” di Platone, hanno sfornato con cadenza pressoché quotidiana, una rivista, un settimanale, un mensile, un bimestrale per dettare collettivamente la Linea giusta, ma soprattutto per “stare insieme”, per far parte dell’elenco dei citabili, per allineare la propria firma a quella dei sodali. Per la tossica ossessione dell’“insiemitudine”, come la definiva Alberto Ronchey, uno studioso maniacalmente fedele agli imperativi del rigore culturale che dal conformismo del “ceto dei colti” si è sempre tenuto lontano. Sono posseduti da una fame bulimica di rassicurante appartenenza. Amano talmente mostrarsi come adepti di una Nobile Causa da piombare talvolta nel ridicolo. Come George Bernard Shaw che elogiava simultanemente i misfatti, che per lui erano eroiche imprese, di Stalin e quelli di Mussolini. O Corrado Alvaro, che nel ‘48 aggiunse la sua prestigiosa firma all’appello per la sinistra con il faccione di Garibaldi e subito dopo, insaziabile di firme, a quello per lo Scudo Crociato.
In Italia gli intellettuali fautori della visione del mondo sono stati costantemente lamentosi e risentiti, a sinistra come a destra: sembra il loro marchio di fabbrica. Sono sempre stati le incarnazioni del disincanto, della delusione, dell’insofferenza per una politica che non è mai all’altezza, ai loro occhi, “per ciò che combattemmo”: il Risorgimento “tradito”, la “vittoria mutilata”, la Resistenza incompiuta. Veneziani, Cardini e Tarchi sono solo gli ultimi, cronologicamente parlando, a sentirsi delusi da una destra al governo che invece di rivoluzionare la visione del mondo si accontenta prosaicamente di esibire un eccellente bilancio dei conti pubblici.
Tranquilli, è successo anche alla sinistra: “Di’ qualcosa di sinistra” rivolto al politico di sinistra è il motto imperituro dell’intellettuale disilluso. Del resto già Gaetano Salvemini definiva Giolitti “il ministro della malavita” in un’Italia guidata con prudente realismo da quest’ultimo con risultati pratici e concreti (due brutte parole, poco visionarie) tra i migliori nella storia dello stato unitario. Gabriele D’Annunzio, il Vate che aveva come programma politico la poesia dell’impresa di Fiume, non apprezzava affatto il prosaico Mussolini del regime, da cui peraltro continuava a ricevere laute prebende: non per questo “combattemmo”.
Nel dopoguerra Elio Vittorini deplorò l’eccesso di realismo di Palmiro Togliatti, ebbe l’ardire di proclamare il suo rifiuto di “suonare il piffero” della rivoluzione e ne fu ricambiato con il ruvido e brutale comunicato del carismatico leader del Pci che suonava così: “Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato”. Del resto Togliatti, con la leggenda della sua stilografica con inchiostro verde e le sue maliziose introduzioni agli scritti di Voltaire, amava addirittura bullizzare con la sferza dell’ingiuria sarcastica gli intellettuali “organici” che si erano permessi di coltivare qualche sia pur sporadico interesse per la psicanalisi: “Purtroppo quando si parte da Freud si può andare a finire molto lontano, in una casa Merlin o in un manicomio”.
Per non finire come profetizzava il Segretario Generale, gli intellettuali, che si vogliono sempre così ardimentosi, trascurarono disciplinatamente per decenni di prendere in considerazione Freud. Perché gli intellettuali, al contrario di ciò che tramanda la vulgata, sono molto più portati per l’ortodossia che non per la spregiudicatezza critica. Sono conservatori, frenatori, sacerdoti del sacro. E i politici, almeno così è accaduto in Italia a destra come a sinistra, sono spesso un passo avanti a loro. Persino nella Dc l’integralismo religioso e culturale di Giuseppe Dossetti si scontrò con la saggezza politica di De Gasperi e Dossetti, per non farsi contaminare dai compromessi democristiani, scelse la fede e abbandonò la politica.
Nel Msi, le menti più intellettualizzate tra i giovani erano molto più attratte dalla visione del mondo tradizionalista di Pino Rauti che non dai vertici del partito irretiti nella politica politicante, più inclini a cavalcare la tigre con Julius Evola e a celebrare con lui il rito del solstizio d’estate che non a piegarsi nel pragmatismo parlamentarista di Giorgio Almirante (e prima di lui del burocratico Michelini). Insofferente alle critiche, Bettino Craxi liquidava con l’epiteto “intellettuale dei miei stivali” chi osava obiettare. Quando, sotto le macerie del muro di Berlino, il Pci di Occhetto spense le insegne comuniste per rinascere in una Quercia post-comunista, moltissimi intellettuali “d’area”– l’intellighenzia – più raffinata, si accalcarono numerosi e risentiti all’Eliseo, Natalia Ginzburg in testa, per denunciare l’insopportabile tradimento: con la fine del Pci, sarebbe mancato loro “il bambolotto di pezza”, replicò con cattiveria un dirigente allora molto in auge nel partito, Fabio Mussi. Il “bambolotto di pezza” era, come al solito, la confortevole, rassicurante, calda “visione del mondo” lasciata libera di fiorire nell’eterna opposizione. Ora quella nicchia stava scomparendo. Oltre che “dire”, era il momento di “fare” qualcosa di sinistra. Al governo del paese, giammai: “non per questo combattemmo”, la purezza primigenia della bandiera non si doveva nemmeno sfiorare.
A differenza di Émile Zola, che infatti dopo la sua temeraria difesa dell’innocente Alfred Dreyfus e la condanna che ne era seguita venne isolato e abbandonato dagli intellettuali antisemiti di destra e dagli intellettuali antisemiti di sinistra, gli intellettuali con il tesserino vidimato amano con militante ardore la libertà d’espressione: solo la loro, però. Mai quella valida erga omnes, invece rivendicata abusivamente da chi si permette di manifestare pubblicamente il suo disaccordo e di cui, con militante ardore, si auspica la reclusione in un recinto infetto. Selezionano con cura le Cause cui consacrarsi. Se a uno di loro viene negata la prima serata in tv, si grida al martirio e ci si paragona a Giacomo Matteotti (che peraltro in vita – prima di essere ammazzato dai fascisti – era detestato da Gramsci e dall’intellettuale Gobetti – prima di essere linciato dai fascisti – perché troppo incline al pragmatismo riformista). Ma i loro animi sono refrattari all’ardore militante quando a patire la mancanza della libertà d’espressione sono gli intellettuali imbavagliati per dir così lontani da casa, cioè dall’occidente. Nel regime cinese si aprono i campi di concentramento per i dissidenti: indignazione non pervenuta. Le impiccagioni e l’esilio di chi si oppone al dispotismo degli ayatollah non meritano attenzione, povera Azar Nafisi, cacciata da Teheran. La Russia che avvelena Anna Politkovskaja? Reazioni blande e tardive. Boualem Sansal, prigioniero del fanatismo islamista? Reazioni blande e tardive (e meno male che c’è la Germania a salvarlo). Chissà perché questa collettiva attitudine all’alternanza: la vis polemica si accende e si spegne. Tutti insieme contemporaneamente. Devono essere gli effetti di ondate epidemiche di “emiplegia intellettuale”, a sinistra come a destra.
A differenza di Zola, gli intellettuali del Novecento insieme ai loro nipoti del ventunesimo secolo che lamentano la sconfortante prosa di una politica cieca alla “visione del mondo”, non annoverano il coraggio tra le loro virtù principali. Anzi, appena si è instaurata una dittatura, un totalitarismo, un dispotismo, sono accorsi pavidi a sostegno del tiranno di turno. Su circa 1200 professori universitari solo in 12 dissero di no all’obbligo di giurare fedeltà al regime fascista. In Germania (o nella Francia occupata e nel regime fantoccio di Vichy) la svastica scaldò i cuori di molti solerti intellettuali che aderirono alle campagne per la persecuzione degli ebrei, salvo piagnucolare davanti ai giudici di Norimberga. Nell’Unione Sovietica che spediva legioni di intellettuali (che si erano rifiutati di diventare “ingegneri dell’anima” secondo le direttive del Cremlino) a svernare nel Gulag, Stalin si divertiva a giocare come il gatto con i topi e terrorizzare i superstiti come Boris Pasternak telefonando di notte per captarne i segni del panico. A Solzhenitsyn andò pure peggio: descrisse l’inferno dei campi di concentramento, e in occidente gli intellettuali eccepivano che quel loro collega riottoso scrivesse troppo male per essere preso in considerazione. Del resto uno slogan del ‘68 diceva che era meglio “avere torto con Sartre piuttosto che ragione con Aron”. Partivano gli applausi a chi aveva torto ma era trasfigurato da una visione del mondo, e questa lezione è stata incamerata dai discepoli nostri contemporanei, a cui un palco martirologico e una Causa nobile e buona a cui dedicarsi con ritrovato ardore non vengono mai negati. Ha scritto Joseph Schumpeter che furono i monasteri a forgiare “l’intellettuale del medioevo, ma fu il capitalismo a liberarlo e a fornirgli il torchio da stampa”. Troppo cinismo, poca visione: il vanto degli intellettuali intesi come corporazione è di detestarlo, il capitalismo.
Poi nell’occidente si scivola nella nostra piccola storia di provincia, mica le tragedie planetarie del Novecento. Ma ancora non si vuole capire che nelle società democratiche ai partiti e alle associazioni si aderisce solo su base volontaria. Se non ti piacciono, invece di fare la lagna sulla malvagità dei politici che ti tagliano la lingua o peggio ti ignorano, puoi sempre dire addio e immergerti nei tuoi amati studi. Al massimo i politici reagiranno con un “se n’è ghiuto e soli ci ha lasciato”. E ci faranno rimpiangere persino Palmiro Togliatti: imperdonabili.

evitamento organizzato
Viviamo l'èra dell'essenzialità muta. Ma parlate, fatevi questo piacere!
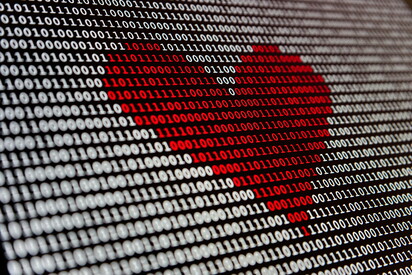

L'editoriale dell'elefantino


