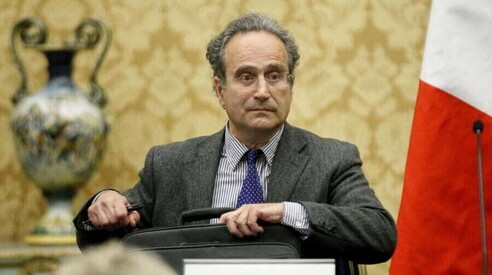foto Unsplash
Tre parole per sintetizzare il caotico puzzle globale contemporaneo
Riconoscimento, misconoscimento e conflitto. Siamo nell'epoca della smania del riconoscimento, mentre il misconoscimento è il meccanismo con cui si opera una rimozione delle strutture sociali attorno alle quali siamo organizzati. E il conflitto sembra l'unico ordine possibile
Dall’Ucraina al medio oriente, dall’espansionismo economico cinese ai conflitti africani, dall’ondivaga situazione latinoamericana agli Stati Uniti di Trump fino alla fragile e maldestra Unione europea, tralasciando ovviamente molte altre componenti del caotico puzzle mondiale contemporaneo. Si potrebbe trovare un modo, per quanto riduttivo, di riassumere la situazione in corso?
Il termine “permacrisis” in utilizzo da qualche anno è senz’altro più adeguato di “guerra mondiale a pezzi”. Quest’ultima espressione, infatti, poggia su una storia troppo specifica, ossia quella delle due grandi guerre del primo Novecento per potersi davvero prestare a un nuovo utilizzo. Permacrisis, invece, descrive certamente bene la situazione in cui ci siamo ritrovati a vivere, con crescente costanza, a partire, convenzionalmente, dall’11 settembre del 2001.
Tuttavia, anche questa espressione non va alla radice della questione, si limita a illustrarla. Cercando allora dei concetti che possano spiegare questa situazione, rimanendo pur sempre sull’inevitabilmente generico legato all’idea stessa di concetti esplicativi di situazioni tanto diverse, potremmo provare a immaginare una sintesi dell’attuale situazione basata su tre termini: riconoscimento, misconoscimento e conflitto. Il primo ha una lunga e nobile tradizione filosofica. Senza andare chissà quanto indietro, basta pensare che la “dialettica del riconoscimento” tra servo e signore nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel è una specie di Moloch con cui si sono dovute confrontare, per un verso o per l’altro, tutte le teorie socio-politiche degli ultimi duecento anni. Il riconoscimento, in estrema sintesi, è ciò per cui uno è disposto a sacrificare anche la propria vita pur di ottenerlo. Il riconoscimento da parte degli altri è ciò che ci rende effettivamente esistenti. Essere riconosciuti vuol dire assumere una legittimità all’interno di una comunità, significa avere il proprio spazio garantito e acquisito. Significa essere ammessi all’interno della comunità con un certo ruolo e una certa posizione.
Si capisce come la questione del riconoscimento valga a tutti i livelli, dal contesto familiare, a un gruppo di amici, dall’ambiente lavorativo cui desideriamo accedere, su su fino all’accettazione di uno stato nella comunità internazionale. Oggi siamo nell’epoca della smania del riconoscimento. Non è forse, infatti, proprio questo il tratto più comune alla nostra situazione di permacrisis? Al di là dei giudizi che ne possiamo dare, la Russia non vuole forse che le venga riconosciuto un nuovo (antico?) ruolo sullo scacchiere internazionale? La Palestina non vuole essere riconosciuta come esistente e indipendente? Israele non vuole che il suo riconoscimento sia un fatto insindacabile? La Cina non vuole che le sia riconosciuto un ruolo neoimperiale? L’America trumpiana non vuole essere riconosciuta come the greatest nation ever? I vari movimenti woke e le loro infinite minoranze suscettibili, con le loro sigle ricche di consonanti, non vogliono essere tutti riconosciuti? Non è quindi il desiderio di riconoscimento la vera cifra distintiva della nostra epoca? Si potrebbe dire che solo l’Europa non vuole essere riconosciuta, forse perché è da sempre colei che aveva le “chiavi” del riconoscimento, o forse, più probabilmente, perché non avendo idea di cosa sia, o di cosa voglia essere, non può neppure desiderare di essere riconosciuta. Per questo non riesce a giocare un vero ruolo: non sa cosa rivendicare per se stessa.
Il secondo termine, misconoscimento, è stato reso celebre da René Girard. Nel senso che qui ci interessa, però, possiamo dire che il misconoscimento è il meccanismo attraverso cui viene operata una sorta di rimozione della base sacrificale, violenta, delle strutture sociali intorno alle quali siamo organizzati. Ogni ordine non è altro che la sacralizzazione di un atto violento fondativo, celato dall’ordine istituzionalizzato che viene creato su quelle spoglie. Ampliando il significato di questo concetto, si può pensare al misconoscimento come al meccanismo che ci fa ritenere un ordine come inamovibile, come dato in maniera assoluta, celandone la natura contingente. Quando è, allora, che un’epoca cambia? Quando le strutture, in apparenza sacrali e assolute, che precedentemente inquadravano un certo ordine scompaiono, si consumano o vengono abbattute. Quindi, quell’ordine salta. Ma perché ciò avviene? Perché viene meno, appunto, quello che qui chiamiamo misconoscimento, ossia il dare per “vere” e “accettate” da sempre determinate strutture che sembrano perdersi nella notte dei tempi e che invece, improvvisamente, saltano perché vengono meno le condizioni che le avevano rese possibili. Condizioni che apparivano necessarie e insuperabili, addirittura metafisiche, improvvisamente si mostrano nella loro provvisorietà. Come se cadesse un velo.
Ecco, allora, il terzo termine: conflitto. Nel momento in cui l’ordine precedente perde la sua aura sacrale, come idoli che lasciano la doratura sulle dita di chi li sfiora, improvvisamente si genera disordine e bisogno di nuovo ordine. Il conflitto sta qui, nella cancellazione del misconoscimento e nella necessità di nuovi riconoscimenti. Il riconoscimento, infatti, non è un dono del cielo ma una guerra, intesa nel senso più ampio possibile. E’ un conflitto tra chi vuole essere riconosciuto e chi deve essere “costretto” a riconoscere. Ma, fino a che i nuovi riconoscimenti non vengono coperti dalla stabilità di un nuovo misconoscimento, dal velo di certezza e di stabilità che questo comporta, ossia della nuova accettazione totale dell’ordine dato, è il conflitto l’unico ordine possibile. Transitorio, certo, ma continuativo. Ed è forse, il dis-ordine del conflitto anche l’ordine più antico, più profondamente umano, il modo attraverso cui l’umanità si supera, si rimescola, si trasforma e si dà nuovi orizzonti.
E’ chiaro, quindi, come questa sia la fase più lontana dalla stabilità, perché un intero e nuovo processo di riconoscimento è in corso. In tale situazione due potenze appaiono come dominanti, una nel breve e l’altra nel lungo periodo: la prima è la forza (la potenza più antica e necessaria, e quella che abbiamo tentato di rimuovere) per cercare di farsi riconoscere, la seconda è una nuova sacralizzazione (in chissà quale senso, perché non potrà essere un senso già stato e quindi per sempre superato) di quello che sarà l’ordine raggiunto.