
Ansa
Magazine
Così la Nasa chiamò gli artisti a documentare imprese insuperate
Fin dalle prime fasi della propria attività, per iniziativa di James Webb, l'agenzia cercò di coinvolgere il mondo dell’arte. Uno dei momenti più significativi fu nel quadro delle missioni Apollo, in particolare la Apollo 11 che portò per la prima volta gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna il 20 luglio 1969
"Un francese, parigino, artista altrettanto faceto quanto audace, domandò di rinchiudersi in una palla per andare alla Luna e fare una ricognizione del satellite terrestre. Quell’intrepido avventuriero si chiamava Michel Ardan. Egli arrivò in America, fu ricevuto con entusiasmo, tenne delle conferenze, si vide portare in trionfo, riconciliò il presidente Barbicane col suo mortale nemico il capitano Nicholl e, come pegno di riconciliazione, li decise ad imbarcarsi con lui nel proiettile”. E’ un artista, nei romanzi di Jules Verne Dalla terra alla luna (1865) e Intorno alla luna (1870), il primo a offrirsi come volontario per partire in un razzo all’esplorazione del satellite. Il personaggio di Michele Ardan fu ispirato a Verne dall’amico Gaspard-Félix Tournachon, più noto come Nadar, bizzarra figura di fotografo e al tempo stesso pioniere del volo aerostatico, celebre tra l’altro per le proprie foto aeree.
Non è dato sapere se i dirigenti della Nasa ricordassero il personaggio dei romanzi di Verne, ma quello che è sicuro è che fin dalle prime fasi della propria attività l’agenzia cercò di coinvolgere il mondo dell’arte. Un tema che torna di attualità oggi. Di questi giorni, infatti, è la notizia che la Nasa pianifica, a partire dal febbraio 2026, la missione “Artemis II” che prevede il sorvolo lunare da parte di un equipaggio con quattro astronauti e durerà dieci giorni. Sarà il primo volo umano oltre l’orbita terrestre bassa dopo oltre cinquant’anni; l’ultimo fu quello della missione Apollo 17, del 1972. Dall’esito della missione Artemis II dipenderà la pianificazione della missione Artemis III, che nel 2027 dovrebbe riportare astronauti sulla luna. Una previsione ritenuta da molti esperti poco realistica, anche perché dipende dagli sviluppi di SpaceX Starship, di proprietà di Elon Musk. Vi è infatti la possibilità che il ritorno dell’uomo sulla luna sia concretizzato, ancor prima che dalla Nasa, dall’Agenzia spaziale cinese (Cnsa) il cui programma sembra procedere a passo ben più spedito. Ma l’idea di coinvolgere anche l’immaginazione degli artisti risale a ben sette anni prima dello storico allunaggio del luglio 1969.
L’iniziativa partì direttamente dall’allora amministratore della Nasa, James Webb. Ex-marine, abilissimo nelle relazioni con la politica e la burocrazia federale, Webb fu nominato dal Presidente John Fitzgerald Kennedy nel 1961, tre anni dopo l’istituzione della Nasa, ed ebbe un ruolo decisivo nello sviluppo dell’agenzia. A destare la sua attenzione per una possibile partnership con gli artisti fu un ritratto di un astronauta realizzato dal pittore Bruce Stevenson nel 1962 (Portrait of Alan Shepard). Webb scrisse una nota di due paragrafi al responsabile delle relazioni pubbliche dell’agenzia. “Gli eventi importanti possono essere interpretati dagli artisti per offrire una prospettiva unica sugli aspetti più significativi dei nostri progressi nella conquista dello spazio. Una testimonianza artistica del programma nazionale di esplorazione spaziale avrà un grande valore per le generazioni future e potrà costituire un contributo significativo alla storia dell’arte americana”.
Il responsabile girò la richiesta a un dipendente con un background artistico, James Dean. Con l’aiuto di un curatore della National Gallery, Dean reclutò un primo gruppo di sette artisti nel 1963 per documentare l’ultimo volo del programma Mercury. Tutti gli artisti ricevettero una lettera di tre pagine e un rimborso spese di 800 dollari. Il coinvolgimento degli artisti, spiegava la lettera, era giustificato dal fatto che “I primi passi nell’esplorazione dello spazio segneranno una svolta nel destino dell’umanità. Da quando i pesci polmonati sono strisciati fuori dal fango del Paleozoico, nessun altro essere vivente ha cercato di cambiare il proprio ambiente, e dall'epoca di Colombo nessun altro uomo ha osato avventurarsi in regioni tanto pericolose e misteriose”. Accettando l’incarico, gli artisti si impegnavano a conservare ogni proprio abbozzo e appunto intermedio, a scegliere supporti permanenti e a donare almeno una delle opere d’arte realizzate alla Nasa Art Collection. Si raccomandò inoltre di privilegiare la pittura, se possibile, rispetto ad altri mezzi quali fotografia e film (“la macchina fotografica vede tutto, ma non capisce niente” si diceva perentoriamente nella lettera).
Il timore iniziale era che scienziati e ingegneri fossero infastiditi dalla presenza degli artisti, ma in realtà accadde il contrario: li accolsero a braccia aperte. “Ingegneri, scienziati e artisti hanno in comune l’uso dell’immaginazione. A un certo livello trovarono una connessione profonda” spiegò Dean “quando un artista trasforma il tuo luogo di lavoro in un’opera d’arte, sai, questo dà valore a tutto ciò che hai fatto”. Il programma fu esteso e negli anni successivi furono coinvolti artisti già molto noti come Norman Rockwell. Il programma spaziale in questo caso era Gemini (1961-1966), dedicato a sviluppare tecniche di viaggio spaziale avanzate da utilizzare in seguito per le missioni Apollo. Rockwell realizzò l’opera “Grissom and Young” (1965) documentando la fase in cui gli astronauti vengono equipaggiati con le loro speciali tute. L’artista chiese in prestito una tuta per preparare gli schizzi, ma la Nasa non era favorevole. Alla fine gli fu concessa, ma un tecnico rimase a sorvegliarlo durante tutto il lavoro, tanto che Rockwell ritrasse anche lui nel quadro. Un altro artista, Paul Calle, catturò invece un momento successivo, quello in cui gli astronauti entravano nella capsula. Settanta opere realizzate furono esposte nel 1965 in una mostra alla National Gallery of Art, “Eyewitness to Space”, che ebbe un successo notevole.
Il coinvolgimento degli artisti nelle attività della Nasa conobbe uno dei momenti più significativi nel quadro delle missioni Apollo, in particolare la Apollo 11 che portò per la prima volta gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna il 20 luglio 1969. Qui trovarono spazio anche opere più astratte come “Crossroads” di Alexander Calder (1967), che fu scelta anche come poster per pubblicizzare l’inaugurazione del National Air and Space Museum. Ma uno dei quadri più memorabili fu ancora una volta opera di Rockwell: “Astronauts on the Moon” (1967), in cui l’artista immaginò due anni prima, con sorprendente accuratezza e capacità visionaria, la scena del famoso “piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Tra gli artisti coinvolti in questi anni ci fu anche Robert Rauschenberg, e venne organizzata una seconda mostra alla National Gallery nel 1969. Dopo le missioni Apollo il rapporto della Nasa con gli artisti continuò, ma con minor vigore. Da un lato si dette più spazio a collaborazioni individuali invitando “artists in residence”: la prima, nel 2002, fu la musicista e artista visiva Laurie Anderson, che realizzò lo spettacolo “The End of the Moon” (2004). Dall’altro si ampliò la gamma delle modalità espressive coinvolgendo anche fotografi come Annie Leibovitz, scrittori come Ray Bradbury e musicisti come Terry Riley e Kronos Quartet. Webb dal canto suo aveva lasciato la Nasa nel 1968, dopo aver gestito con grande sapienza e cautela il tragico incidente dell’Apollo 1 (in cui persero la vita durante un test tre astronauti) e la relativa commissione d’inchiesta.
La collezione continuò comunque ad arricchirsi grazie all’acquisto di opere in tema, anche se non direttamente commissionate dall’Agenzia, come “Moonwalk” di Andy Warhol (1987), contribuendo a incrementare la Nasa Art Collection che oggi annovera oltre 800 opere firmate da 250 artisti. Un caso interessante è quello di Alan Bean, quarto astronauta a mettere piede sulla luna con la missione Apollo 12, che nel 1981 dette le dimissioni dalla Nasa proprio per dedicarsi a tempo pieno alla pittura, attingendo così alla propria esperienza diretta.
Ma gli artisti direttamente coinvolti dal programma artistico della Nasa non erano ovviamente gli unici a trovare nell’esplorazione spaziale una fonte di ispirazione significativa. Un’ispirazione che anche, tra gli artisti italiani spesso risaliva a molti anni prima, quando erano iniziate a circolare le prime foto della Terra scattate dai razzi su riviste come Life o in televisione. Si legge nel “Secondo manifesto dello spazialismo” (1948) firmato, tra gli altri, da Lucio Fontana: “Se, dapprima, chiuso nelle sue torri, l’artista rappresentò se stesso e il suo stupore e il paesaggio lo vide attraverso i vetri, e poi, disceso dai castelli nelle città, abbattendo le mura e mescolandosi agli altri uomini vide da vicino gli alberi e gli oggetti, oggi, noi, artisti spaziali, siamo evasi dalle nostre città, abbiamo spezzato il nostro involucro, la nostra corteccia fisica e ci siamo guardati dall’alto, fotografando la terra dai razzi in volo”. Lo stesso Fontana - alle cui opere in ceramica la Collezione Guggenheim di Venezia dedica proprio in questo periodo una bellissima mostra curata da Sharon Hecker (“Mani-Fattura”, visitabile fino al 2 marzo 2026) - realizzò a Torino nel 1961 con lo Studio Monti l’ambiente spaziale “Fonti di energia” per l’esposizione Italia ‘61.
“Al primo incontro” ha raccontato Anna Monti a Marinella Venanzi “(Fontana) ci parlò del lancio dell’uomo nello spazio che era avvenuto in quei giorni (quello che portò nello spazio Yuri Gagarin), di quel ‘cielo nero da incubo’ che l’astronauta aveva visto. Sembrava che nello spazio fosse tutto nero e la cosa lo aveva colpito molto. Così voleva realizzare qualcosa che fosse di questa luce nera, un nero che doveva assorbire e attrarre verso le profondità spaziali” (M. Venanzi, Fontana e lo spazio, 2012). “Sfregia i quadri alla ricerca del dolore degli astronauti” fu la sintesi di un quotidiano dell’epoca. Sempre Fontana dichiarò nel 1969: “La scoperta del Cosmo è una dimensione nuova, è l’Infinito: allora io buco questa tela, che era alla base di tutte le arti e ho creato una dimensione infinita”.
Al momento non si hanno informazioni sul possibile coinvolgimento di artisti nelle nuove missioni Artemis II e III e nelle prossime attività programmate dalla Nasa. Negli ultimi decenni anche altre agenzie spaziali, tra cui la European Space Agency, hanno avviato programmi di collaborazione e residenze di artisti. Ma probabilmente quella avviata da Webb e Dean negli anni Sessanta resta un’esperienza significativa e per certi versi unica, espressione di una fase di entusiasmo forse irripetibile per l’esplorazione spaziale. In fondo, per quale motivo un’agenzia spaziale dovrebbe investire una parte delle proprie risorse nell’arte? Una possibile risposta viene dallo scrittore di fantascienza e divulgatore Arthur C. Clarke, che nel 1968 divenne celebre anche come co-autore della sceneggiatura di uno dei capolavori di Stanley Kubrick, “2001: Odissea nello spazio”. Commentando la mostra allestita dalla Nasa negli anni Sessanta, Clarke spiegò: “L’artista astronomico sarà sempre molto avanti rispetto all’esploratore. Può rappresentare scene che nessun occhio umano vedrà mai, a causa del loro pericolo o della loro lontananza nel tempo e nello spazio”.

cattivi scienziati
Perchè serve riportare sui dati la discussione sul digiuno intermittente

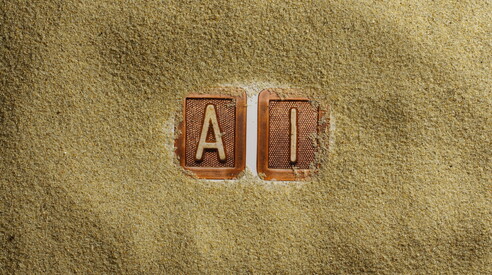
cattivi scienziati





