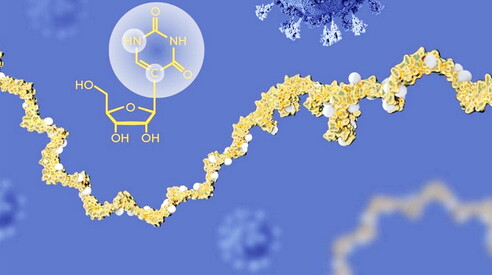
Ansa
Cattivi scienziati
Un vaccino basato su mRNA potrebbe aiutare il sistema immunitario contro il cancro
Se gli studi saranno confermati, si aprirebbero due orizzonti complementari: l’uso dei vaccini già approvati come coadiuvanti a basso costo dell’immunoterapia e lo sviluppo di vaccini universali progettati per massimizzare la stimolazione immunitaria in presenza del tumore
I vaccini a mRNA, sviluppati per contrastare il SARS-CoV-2, stanno rivelando un effetto inatteso e se confermato di grande importanza clinica: sembrano potenziare la risposta antitumorale nei pazienti trattati con immunoterapie. I dati, presentati al congresso annuale dell’European Society for Medical Oncology a Berlino e discussi su Science, mostrano che i pazienti oncologici trattati con immunoterapici e che avevano ricevuto un vaccino a mRNA – anche non diretto contro antigeni tumorali – vivevano significativamente più a lungo di quelli che non lo avevano ricevuto prima dell’inizio della terapia immunologica.
Un gruppo del MD Anderson Cancer Center di Houston, guidato da Steven Lin con la presentazione di Adam Grippin, ha analizzato retrospettivamente le cartelle cliniche di oltre mille pazienti affetti da tumori cutanei e polmonari avanzati trattati tra il 2019 e il 2023 con inibitori dei checkpoint immunitari, farmaci che rimuovono i freni fisiologici del sistema immunitario per consentirgli di riconoscere e attaccare le cellule tumorali. È emerso che i pazienti che avevano ricevuto un vaccino a mRNA anti-COVID-19 entro 100 giorni dall’inizio dell’immunoterapia avevano una sopravvivenza mediana quasi doppia rispetto a quella dei pazienti non vaccinati: 37,3 mesi contro 20,6 nel caso del carcinoma polmonare avanzato. Gli autori hanno verificato che il fenomeno non dipendeva semplicemente dal fatto di essere vaccinati: nei pazienti che avevano ricevuto altri vaccini, come quelli antinfluenzali o antipneumococcici – tutti basati su proteine o polisaccaridi e non su mRNA – non si osservava alcun miglioramento comparabile. Questo suggerisce che il meccanismo d’azione sia specifico della piattaforma a mRNA.
I risultati si inseriscono in una linea di ricerca che lo stesso gruppo aveva inaugurato pochi mesi prima, con un lavoro su modelli murini pubblicato a luglio 2025, in cui un vaccino mRNA generico, non diretto contro alcun antigene tumorale specifico, aveva amplificato l’efficacia degli inibitori dei checkpoint in tumori refrattari. In quel caso, la proteina codificata dall’mRNA era irrilevante: il fattore chiave era l’mRNA stesso, che agisce come stimolatore dell’immunità innata, capace di attivare vie infiammatorie e citochiniche che mettono in allerta l’intero sistema immunitario. L’ipotesi è che l’mRNA, una volta introdotto nell’organismo, agisca come una sorta di segnale di pericolo per le cellule dell’immunità innata, inducendo la produzione di interferoni di tipo I, le stesse molecole responsabili dei sintomi post-vaccinali più intensi. Questi interferoni attivano cellule dendritiche e linfociti T nei tumori, stimolando la loro migrazione verso i linfonodi, dove avviene l’addestramento immunitario che porta nuove cellule T a riconoscere e distruggere le cellule tumorali.
Di fronte a questa offensiva, i tumori rispondono esprimendo il recettore PD-L1, che serve a inibire i linfociti T e a sfuggire alla distruzione. Gli inibitori dei checkpoint, come gli anticorpi contro PD-1 o PD-L1, bloccano questo meccanismo e consentono di mantenere la risposta immunitaria attiva. In tale contesto, la stimolazione generata dal vaccino a mRNA amplifica l’efficacia di queste terapie, fornendo un numero maggiore di linfociti T già attivati e rendendo più difficile per il tumore riorganizzare le proprie difese. Secondo diversi esperti indipendenti, i risultati sono di grande interesse nonostante la natura retrospettiva dell’analisi e mostrano un’associazione robusta fra vaccinazione mRNA e sopravvivenza; resta però necessario verificare l’effetto con studi prospettici e randomizzati, già in fase di progettazione da parte del gruppo di Lin.
Il valore di questa osservazione va oltre il caso specifico dei vaccini anti-COVID: essa suggerisce che qualsiasi vaccino basato su mRNA, anche se codifica per una proteina irrilevante dal punto di vista tumorale, può potenziare l’immunoterapia agendo come un adiuvante intrinseco capace di risvegliare il sistema immunitario e predisporlo a una risposta più vigorosa contro il cancro. Se confermato, questo aprirebbe due orizzonti complementari: l’uso dei vaccini a mRNA già approvati come coadiuvanti a basso costo dell’immunoterapia e lo sviluppo di vaccini universali a mRNA progettati non per colpire un singolo antigene, ma per massimizzare la stimolazione immunitaria in presenza del tumore. Tuttavia, la prudenza resta indispensabile. I dati presentati a Berlino non sono ancora stati pubblicati in forma peer reviewed e derivano da un’analisi retrospettiva, esposta per sua natura a bias di selezione e a errori di temporizzazione. In questo tipo di studi è frequente l’immortal time bias: se la vaccinazione è definita come avvenuta entro un certo intervallo dopo l’inizio della terapia, i pazienti che rientrano in quella categoria devono per forza essere sopravvissuti abbastanza a lungo da riceverla, e ciò può generare un vantaggio apparente rispetto ai non vaccinati. Anche fattori clinici non perfettamente controllabili – come lo stato funzionale, il carico di malattia, la presenza di metastasi cerebrali, l’uso concomitante di corticosteroidi o antibiotici, le differenze di accesso alle cure durante le varie fasi della pandemia – possono introdurre distorsioni non eliminabili a posteriori.
La letteratura sugli effetti delle vaccinazioni nei pazienti in trattamento con immunoterapie, pur ricca di segnalazioni positive, soffre spesso degli stessi limiti metodologici. In vari studi osservazionali, inclusi quelli sulle vaccinazioni antinfluenzali, è stato documentato un miglioramento della sopravvivenza o una minore tossicità senza che vi fosse una chiara dimostrazione meccanicistica. In molti casi, il cosiddetto healthy vaccinee bias – cioè la tendenza dei pazienti in condizioni migliori a essere vaccinati – spiega parte dei risultati. Sarà quindi decisivo verificare, in studi prospettici e controllati pubblicati su rivista e non annunciati ad un convegno, se l’effetto ipotizzato esista realmente e se sia riproducibile in diversi tipi di tumore. Solo un’analisi meccanicistica diretta, basata su prelievi seriati di tessuto e sangue, potrà chiarire se la vaccinazione a mRNA induce effettivamente una risposta interferonica misurabile, un incremento dell’infiltrato linfocitario nei tumori o un cambiamento nei profili di espressione di PD-L1 e di altre molecole immunoregolatrici.
Anche la componente preclinica, benché promettente, richiede conferme: i modelli murini mostrano che l’mRNA può agire come un potente adiuvante, ma il passaggio all’uomo implica differenze di scala e di contesto immunologico difficili da prevedere. Non si può escludere che l’effetto osservato sia parziale, transitorio o dipendente da specifiche combinazioni di terapia e timing vaccinale. Aspettare, dunque, e pazientare: la via è aperta, ma la strada da fare è lunga prima di poter escludere tutti i fattori che portano a falsi positivi, in campi come questi.

Ambiente, balle, fatti e realtà




