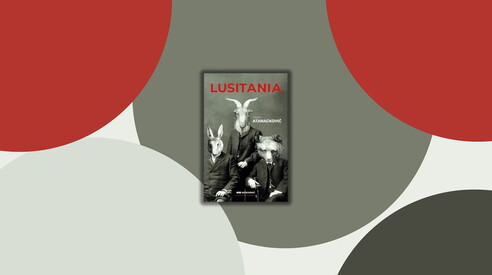Getty
Piccola posta
L'altra faccia dell'occupazione italiana
Le testimonianze degli internati sloveni e croati nei campi italiani tra il 1941 e il 1943 riemergono dal silenzio: un libro raccoglie le voci dei bambini di allora, oggi ultimi testimoni di una storia rimossa
Nella primavera del 1941 la Germania nazista invase la Yugoslavia, seguita subito dopo dagli alleati fascisti italiano e ungherese. L’occupazione italiana durò fino al settembre del 1943, si avvalse dell’esperienza di ferocia razzista accumulata nelle colonie, con la peculiare tinta di odio e di paura che le veniva dalla vicinanza alla gente slava, cristiana e in Slovenia e Croazia, cattolica, che fin dal 1918 aveva segnato la persecuzione e l’italianizzazione forzata delle minoranze annesse al regno. Un gran numero di cittadini e intere famiglie slovene e croate, molte decine di migliaia, vennero deportate e internate, sia nel territorio occupato, come nell’isola croata di Arbe / Rab, dove passarono in migliaia, sloveni croati ed ebrei, e almeno 1.400 morirono di fame e stenti, o in campi di internamento nel territorio italiano, dalla friulana Gonars a molti altri centri nell’intera penisola, da Ventotene a Ustica a Casoli (Chieti). Uomini dapprima, dunque sospetti per definizione, poi donne e bambini, con qualche parentela con partigiani, o semplicemente per l’atto di nascita. Slovenia e Croazia furono il laboratorio prediletto dal proposito di Mussolini di liberare il soldato italiano, l’erede di Roma, dalla cattiva fama di buonismo, come si disse poi, di pietismo, come si diceva allora. “Deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali incapaci di essere duri quando occorre... Questa gente non ci amerà mai. Quindi nessuno scrupolo”.
Fra il luglio e il novembre 1942 una vasta offensiva condotta nel territorio sloveno falcidiò i civili e deportò fra le 30 e le 40 mila persone. La loro storia è stata a lungo ignorata e rimossa, nonostante memorie tempestive e studi importanti. Ora, quando le due metà di Gorizia celebrano insieme la cultura europea, l’editore Donzelli ha pubblicato un libro, La memoria dimezzata, dedicato alle testimonianze slovene dell’internamento. Le cui condizioni, scrive il retro di copertina, erano spesso “paragonabili a quelle dei campi nazisti”. I nostri giorni consigliano prudenza quanto ai paragoni e ai loro effetti di emulazione, ma è un fatto che sono terribili e insieme consueti i racconti e i documenti dei trasporti nei camion, nei carri bestiame, della fame, e ancora di più della mancanza di acqua. “Ad Arbe, d’estate, ‘i prigionieri attaccarono la cisterna con le gamelle in mano sgomitando fra loro per qualche goccia d’acqua’. Gli italiani non tentarono nemmeno di organizzare la distribuzione dell’acqua”. E delle denudazioni e delle rasature, delle disinfezioni e delle malattie e dei pidocchi e dei vermi, dei cadaveri nascosti a oltranza per non perdere la loro razione, delle umiliazioni dei bisogni corporali e delle torture, dei bambini rapiti o “regalati” dalle madri ai carcerieri, purché sopravvivessero: danno il colpo di grazia all’italiano brava gente, se ce ne fosse bisogno. Dicono anche, quando succede, delle italiane e degli italiani che furono davvero brava gente.
Non pochi dei superstiti, alla liberazione, si unirono ai partigiani, già in Italia. Ci fu anche l’altro Dopoguerra, quello in cui “essere stati in un campo era umiliante… Una grossa macchia, sulla tua carriera e sulla tua personalità”. La memoria, si sa, non è la storia. Ma la storia a volte è troppo sazia. Un ex internato a proposito di uno storico pieno di sé: “Il mio libro è basato solo su documenti, vanta lui. Ma se il documento dice ‘ogni internato deve ricevere metà della razione militare’, secondo voi l’abbiamo mai ricevuta?”
La ricerca ha due autrici, Marta Verginella e Urška Strle, e un autore, Oto Luthar, che hanno raccolto le testimonianze di 47 ex internati, soprattutto negli anni 2012-2015. Il confronto fra le date lascia subito capire che i testimoni erano bambine e bambini al tempo dell’internamento. Dettaglio che accresce, con l’attenzione di metodo, l’interesse per i loro ricordi. “Negli ultimi 5 anni è scomparsa più della metà dei nostri interlocutori... Ci stiamo avvicinando al momento in cui non ci saranno più testimoni”. I loro racconti sono incrociati con la memorialistica e con la narrativa accumulata via via. E danno notizia dei primi, tardivi e dapprincipio timidi tentativi di erigere monumenti nei luoghi di quelle sofferenze e di quelle perversioni. Veri monumenti, o targhe, cartelli – volonterose segnalazioni. Leggete. Qualcuno dei reduci di allora ha avvertito che ciò che è successo in Yugoslavia dopo la dissoluzione ha ripetuto e continuato alcuni caratteri dell’altra guerra, quella mondiale, mentre questa era solo “balcanica”… Quanto alla storia orale, pensate a che giacimenti milionari di racconti si stiano accumulando sotto i nostri occhi. Un dì vedranno generazioni di storiche e storici orali, e documentaristi e romanziere errar sotto le loro recentissime ombre, e brancolando penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne, e interrogarle. Finché il Sole risplenderà su le sciagure umane – ché anche lui è estenuato.