
Ansa
L'intervento
Il processo non è uno scontro tra bene e male, ma una competizione tra verità parziali
La separazione delle carriere doveva essere la conseguenza scontata del nuovo codice di procedura penale di fine anni ’80, di cui Vassalli era il padre. Tutta la storia che ci ricorda che separare le carriere è una battaglia progressista
Come ha già chiarito ieri Enrico Morando, richiamando le chiare parole di Giuliano Vassalli, la separazione delle carriere doveva essere la conseguenza scontata del nuovo codice di procedura penale di fine anni ’80 di cui Vassalli era il padre. La separazione non riguarda solo la impossibilità di passare da una carriera all’altra, ma anche tutta la gestione di carriere, sanzioni, ecc, in modo che non vi sia interferenza reciproca. Impostazione che comporta il superamento dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura e delle connesse correnti che sono unitarie tra accusatori e giudici perché si modellano su di esso. Non fu possibile affrontare il tema nella parte finale della legislatura 1987-1992, né in quelle brevi 1992-1994 e 1994-1996, che vennero a sovrapporsi col clima di Tangentopoli.
Il tema cominciò a maturare parzialmente in quella 1996-2001 anzitutto con la Bicamerale D’Alema. In quella sede fu il relatore Marco Boato (Verdi), a riaffermare la tesi. Si era però nel pieno dello scontro tra Berlusconi e una parte della magistratura, causa non ultima del fallimento della Bicamerale. Non potendo quindi affrontare di petto il tema, buona parte di quei lavori confluì poco dopo nel 1999 nella revisione consensuale dell’articolo 111 della Costituzione, che derivava dai testi Pera (centrodestra) e Salvi (centrosinistra), articolo che afferma che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Esso voleva essere, in modo trasparente, un primo passo proprio verso la separazione che si sarebbe potuta varare una volta spento quel conflitto. Non lo dico per costruzioni complottistiche o giornalistiche, facevo allora il consulente di vari parlamentari del centrosinistra e posso testimoniare direttamente che il nuovo 111 era visto come tappa di avvicinamento largamente condiviso verso la separazione. Il clima di Tangentopoli non aiutò non tanto per il potere di veto che una parte del potere giudiziario si auto-attribuiva, ma per una stortura culturale generale. La separazione suppone l’idea che il processo non sia uno scontro tra il bene (identificato in un blocco accusa-giudice perché a priori l’accusatore, oltre che il giudice, incarna il bene) e il male (la difesa sarebbe un male, pur necessario, a favore di qualcuno che se sospettato deve aver fatto comunque qualcosa di male), ma una competizione tra verità parziali tra cui arbitra un giudice terzo.
E’ la stessa ragione per cui molti, che partono dallo schema bene (la nostra parte) e male (gli altri), sono culturalmente ostili alla democrazia maggioritaria. Anche a causa della revisione nel 1999 dell’articolo 111, nel 2000 e nel 2022 furono ritenuti ammissibili quesiti abrogativi su leggi ordinarie che si muovevano in quella direzione. Il dibattito non può quindi essere ricondotto alla divisione destra-sinistra o maggioranza-opposizione. Molti sono i difetti e le forzature che la maggioranza ha accumulato. Nel merito la scelta sbagliata del sorteggio per la composizione dei Csm, quando credo che per i componenti non eletti dal Parlamento sarebbero stati sufficienti i collegi uninominali. Nel metodo la contrazione anomala dei tempi di discussione e di votazione e il rifiuto aprioristico di emendamenti sono stati i principali. Tuttavia, va detto, le forze prevalenti dell’opposizione sono sembrate in realtà contente di questa chiusura, non l’hanno sfidata con una posizione chiara quale sarebbe stata la disponibilità a votare la riforma se emendata dal sorteggio, perché per tutta la legislatura tali forze si sono mosse su una posizione di rifiuto del dialogo sulle istituzioni del tutto speculare a quella di Governo e maggioranza. Ragion per cui l’elettore nel referendum non può che esprimere un giudizio di prevalenza sul merito e qui gli aspetti positivi, di coronamento del nuovo codice, prevalgono.
Stefano Ceccanti, costituzionalista, ex senatore del Pd
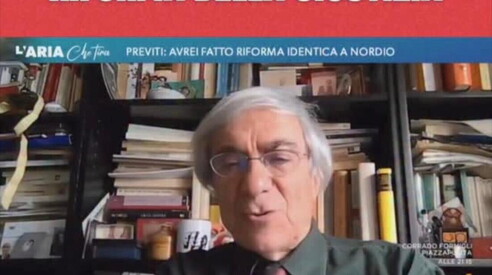
testimonial per un attimo




