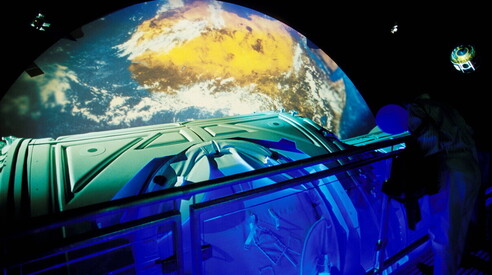Donald Trump (foto LaPresse)
magazine
Alle origini delle derive trumpiane
L’ostilità all’Europa, la retorica imperiale, le torsioni autoritarie. Ma ciò che osserviamo nell’America di oggi viene da lontano
Com’è possibile che sia stato rieletto presidente chi ha cercato di impedire una pacifica transizione dei poteri, avallando l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021? Com’è possibile che quattro anni dopo abbiano deciso di votare per lui settantasette milioni di americani, il numero più alto di sempre per un candidato repubblicano?” (Mario Del Pero, Buio americano, il Mulino, ottobre 2025). Ancora oggi molti studiosi si interrogano sulle cause dell’ascesa di Donald Trump. E offrono una pluralità di risposte, da quelle più strettamente economiche e sociali a quelle più propriamente politiche, culturali e istituzionali. Risposte riconducibili due chiavi di lettura, non del tutto alternative.
La prima sostiene che il trumpismo non è un’anomalia nella storia della democrazia statunitense. Basta pensare alla questione razziale, centrale nella retorica del tycoon newyorkese. Questione tuttora irrisolta in un paese nato schiavista, dove fino a non molto tempo fa vigeva un codificato sistema di segregazione della minoranza nera. E dove ancora oggi molteplici parametri – di reddito, istruzione, accesso a servizi essenziali – tracciano una “linea del colore” spesso insuperabile. Il trumpismo, con i suoi tratti estremi e radicali, appartiene quindi a un’esperienza storica in cui i diritti civili e politici sono stati spesso violati. Da Lincoln, che sospese l’habeas corpus durante la guerra di secessione, fino al maccartismo e alle restrizioni del “Patriot Act” del 2001, ogni baratto tra sicurezza e libertà ha sempre generato derive illiberali.
Lo stesso vale per il problema dei flussi migratori, considerati un pericolo esiziale per la supremazia dei bianchi di discendenza europea. Un “Immigration Act” del 1924, approvato con un’ampissima maggioranze dalle Camere, sbarrò le porte agli immigrati africani e asiatici. Con un lessico che ha evidenti assonanze con quello di Trump, il deputato dell’Indiana Fred Purnell allora dichiarò: “C’è poca o nessuna somiglianza tra i ceppi consapevoli e autonomi che hanno generato il popolo americano e questo flusso di relitti irresponsabili e malridotti, che sta riversando nella linfa vitale dell’America le malattie sociali e politiche del Vecchio Mondo […]. Non si può trasformare un cavallo pesante in un purosangue tenendolo in una scuderia […]. Non si possono cambiare esseri superiori in esseri inferiori”.
La seconda chiave di lettura, invece, è più ancorata al passato recente. In questo senso il trumpismo è un fenomeno legato alla grande recessione del 2008. Evento che ha delegittimato le istituzioni e che è stato vissuto come un tradimento delle promesse costitutive del sogno americano: garantire pari opportunità di vita a tutti. Da quel momento inizia la caccia di Trump al suo elettore tipo: maschio, bianco, con redditi medi e livelli d’istruzione bassi. Nel 2016 riesce così a catturare il suo voto in un paese colpito non solo dalla chiusura delle fabbriche, ma dalla crisi di quell’asset fondamentale di risparmio – l’abitazione – che aveva permesso alti consumi e, indirettamente, una certa protezione sociale. In un paese, inoltre, spaventato da profonde trasformazioni demografiche che sembravano alterare, se non rovesciare, consolidate gerarchie razziali. In un paese, infine, disilluso dalla onerosa politica estera del ventennio precedente, fosse anche quella di esportare la democrazia in Iraq e in Afghanistan.
Ciononostante, gli Stati Uniti non hanno mai abdicato al loro ruolo di potenza planetaria. Continuano a vantare primati indiscussi nel campo militare come dell’innovazione tecnologica, della ricerca scientifica, dell’istruzione universitaria. Tra le prime dieci corporation mondiali, ben otto sono statunitensi, tra cui cinque colossi digitali che detengono posizioni di monopolio inscalfibili. E continuano a beneficiare di un “privilegio esorbitante”, come lo definì nel 1964 l’allora ministro delle Finanze francese Valéry Giscard d’Estaing: l’egemonia del dollaro.
Nella narrazione di Trump, tuttavia, questi primati e questo privilegio non solo non vengono ammessi, ma vengono apertamente negati. Il suo è un mondo in cui gli Stati Uniti sono costantemente raggirati o truffati da rivali commerciali, alleati parassitari, élite politiche corrotte. Nelle due campagne elettorali vincenti, The Donald ha rilanciato una visione delle relazioni internazionali apocalittica. Perché responsabile della “carneficina dell’America” (“American carnage”), come affermò nel discorso inaugurale del suo primo mandato (dicembre 2017). Un messaggio che ha fatto breccia negli americani che vivono in aree rurali sempre più povere; nel degrado delle periferie urbane; tra le rovine industriali del Midwest; nei villaggi dei minatori di carbone della Pennsylvania; nelle contee in cui la diffusione di oppiacei sintetici miete migliaia di vittime, perlopiù tra i giovani.
Erroneamente etichettata come “isolazionismo”, la grande novità del secondo Trump è l’esplicito ricorso a una retorica imperiale, quasi assente nella sua prima Amministrazione. In un mondo in cui non esistono amici o valori ma solo interessi nazionali (oltre che familiari e privatistici), l’unico principio ordinatore diventa quello della forza. Una forza, quella delle armi o dei dazi, con cui regolare i rapporti sia con gli “stati canaglia”, sia con la Cina e l’Ue. Una dottrina ribadita e, in certa misura, sviluppata nel “National Security Strategy” reso noto nei giorni scorsi. Il documento dedica un esteso capitolo proprio all’Europa, dipinta come un continente in irreversibile declino. Affetto da bulimia normativa, crollo delle nascite, politiche migratorie lassiste che mettono a repentaglio perfino la sua civiltà. Un atto d’accusa pesantissimo, dunque, che segna una rottura clamorosa tra le due sponde dell’Atlantico. Lo provano tre punti cruciali del documento: lo stop all’allargamento della Nato (Putin ringrazia); il compiacimento per la forte crescita “dei partiti patriottici europei” (Afd, Rassemblement National e FdI, si può supporre); la denuncia di quei governi europei (Germania e Francia?) che calpestano le regole della democrazia per sopprimere l’opposizione.
Niente di nuovo sotto il sole, almeno in parte. A febbraio, infatti, nel suo controverso intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, J. D. Vance aveva già rassicurato la Russia. Perché “ciò che più mi preoccupa – disse – è l’arretramento dell’Europa dai suoi valori più fondamentali, tra cui la libertà di espressione e il rispetto della democrazia”. Per altro verso, è ormai sempre più lampante la convergenza di vedute tra il “commander in chief” e lo “zar”. Per entrambi l’Europa è vecchia, smarrita di fronte alle sfide della modernità, spiritualmente vuota, moralmente esausta (del tramonto dell’èra liberale il tiranno del Cremlino aveva parlato già nel 2019, in una famosa intervista al Financial Times). Una “entente cordiale” suggellata da un probabile accordo sull’abbandono dell’Ucraina al suo destino.
All’esibizione muscolare esterna di Trump, si affianca specularmente il suo tentativo di aggirare la Costituzione mediante un diluvio ordini esecutivi presidenziali. Siamo quindi di fronte un cambiamento di regime? Se con questa espressione si intende il passaggio a un sistema politico nuovo di zecca, siamo fuori strada. Ma un problema c’è. Prendiamo la questione delle tariffe doganali. L’articolo I della Costituzione parla chiaro: solo il Congresso può deliberare su questa materia. Ma una legge del 1977, firmata da Jimmy Carter, autorizza il presidente a imporre sanzioni negli scambi internazionali, ove si manifesti una “minaccia straordinaria alla sicurezza, alla politica estera o all’economia degli Stati Uniti”. Per attivarla, occorre una dichiarazione di “emergenza nazionale” (che va rinnovata ogni anno). E’ esattamente questa la legge invocata da Trump nel suo ordine esecutivo dell’aprile scorso, il quale richiama i persistenti deficit commerciali degli Usa per giustificare il ricorso ai dazi.
Secondo il Brennan Center for Justice, un prestigioso istituto di tendenze progressiste della New York University, in realtà non c’è nessuna emergenza, nessuna minaccia all’economia nazionale. I poteri conferiti dalla legge sono destinati a sanzionare stati ostili, non il mondo intero, e i dazi neanche vi sono nominati. Per giunta, quei poteri servono per reagire con tempestività a una crisi improvvisa, non per affrontare problemi strutturali di lungo periodo. E’ vero che il Congresso potrebbe bloccare un ordine esecutivo con un suo atto. Per superare il veto presidenziale, però, dovrebbe essere approvato dai due terzi dei deputati e dei senatori, impresa impossibile con le Camere in mano ai repubblicani. Da questa forzatura cruda ed estrema dei poteri presidenziali si può concludere che l’America di Trump sta scivolando verso una sorta di neobonapartismo? Difficile rispondere. Anche se Tocqueville, Weber e Franz Neumann hanno osservato che forme di illiberalismo più o meno “mite” possono emergere anche in contesti democratici.
In ogni caso, diversamente dai suoi predecessori, Trump ha soffiato sul fuoco di divisioni razziali che si sono violentemente riaccese. Con un linguaggio puerile e brutale ha contribuito all’imbarbarimento del dibattito pubblico. Né nasconde la sua ambizione di creare una “presidenza imperiale”, come la chiamò Arthur Schlesinger Jr. più di mezzo secolo fa. Un disegno che ha esasperato i conflitti con l’organo giudiziario. E quando le sue sentenze contraddicono un ordine esecutivo, il più delle volte vengono annullate da una Corte suprema a chiara maggioranza conservatrice. La stessa dialettica tra governo federale e governi statali non è un confronto tra uguali, perché il primo dispone di leve che i secondi non hanno. Può sospendere il trasferimento di fondi limitando notevolmente le capacità di spesa degli stati. Il terzo contrappeso agli abusi presidenziali è costituito ovviamente dai media. Tra i quali non mancano voci critiche. Sono quelle che Trump osteggia con ogni mezzo – legale e illegale – ed esclude dalle sue conferenze stampa, in cui sono ammessi soltanto giornalisti, blogger e tv del suo “inner circle”.
C’è poi, per concludere, la debolezza degli avversari. Debolezza politica, organizzativa, di leadership. Debolezza certificata da sondaggi degli ultimi mesi, secondo cui il Partito democratico è inviso a sei americani su dieci. Le ragioni di questa impopolarità sono tante. Tra queste, spiccano alcune cervellotiche battaglie sui “diritti di genere” non accolte con favore dall’opinione pubblica. Come la battaglia per consentire agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive studentesche con il sesso acquisito dopo la transizione. Si tratta di un tema che rappresenta, o dovrebbe rappresentare, una “non questione”. Al contrario, è stato posto al centro della campagna elettorale. Trump ha colto la palla al balzo, e ha subito emanato l’ennesimo ordine esecutivo: “Keeping Men Out of Women’s Sports” (Tenere gli uomini fuori dallo sport femminile). Morale della favola: un prezzo elettorale salatissimo per i democratici.
Nel 2008, Barack Obama annunciava l’inizio di una nuova epoca scandendo lo slogan: “Change You Can Believe In” (Un cambiamento in cui credere). E’ durata lo spazio di un mattino. “La barriera razziale è caduta”, titolava in prima pagina il New York Times. Paradossalmente è stata proprio quell’elezione a riproporre la questione razziale: per gli afroamericani che, malgrado la presenza di una famiglia nera alla Casa Bianca, non hanno smesso di subirne le ferite; e per i bianchi che da quella famiglia nera si sono sentiti espropriati.
Dopo il liberal Obama, è arrivato nel 2016 il primo Trump: rudemente antistatalista, nazionalista, volgarmente maschilista, sprezzante con i burocrati di Washington ma affabile con gli oligarchi multimilardari della Silicon Valley. Nel 2020 è stata la volta di Joe Biden, che ha promosso politiche che guardavano all’America riformatrice e internazionalista del Novecento, a Woodrow Wilson e al New Deal. Nel 2024 è stato soppiantato dal ritorno straordinario di Trump, che guarda ancora più indietro, alla fine dell’Ottocento, all’America “free-market” protezionista di William McKinley e Teddy Roosevelt.
Come ha sottolineato Arnaldo Testi, a ogni tornata elettorale lo scontro è diventato più radicale e polarizzato, ma i risultati numerici non sono stati mai travolgenti (Il secolo degli Stati Uniti, il Mulino, settembre 2025). I presidenti hanno vinto con vantaggi modesti. Nel 2016 Trump ha perso il voto popolare, nel 2024 lo ha vinto con il margine minimo degli ultimi cinquant’anni. Tutti i presidenti sono entrati alla Casa Bianca con un Congresso controllato dal loro partito, ma per un pelo, per pochi seggi, e solo per il primo biennio del loro mandato. Dopo, a ogni elezione di midterm, il partito di opposizione ha conquistato la maggioranza in almeno una delle Camere.
Che ci sia in ballo un “regime change” in vista delle elezioni di midterm dell’anno prossimo è un’ipotesi da non scartare. Ma popolo non si è ancora pronunciato. La giuria per ora è in camera di consiglio, in attesa di emettere il verdetto.