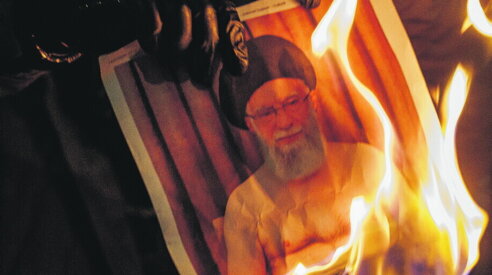L'influenza cinese nelle università italiane è ancora un rischio. Il caso "Settimana Italia-Cina della Scienza"
Il rettore della Federico II Lorito invita i docenti a partecipare alla XIV Settimana Italia-Cina della Scienza. Ma gli esperti (e pure il governo italiano) segnalano rischi legati a collaborazioni in settori sensibili come intelligenza artificiale, biotecnologie e scienze polari. Tra innovazione e sicurezza nazionale, i rischi dell'ambiguità
La scorsa settimana tutti i docenti dell’Università Federico II di Napoli hanno ricevuto nella loro posta elettronica una email da parte del Rettore, il professor Matteo Lorito. Già di per sé la notizia è “piuttosto sensazionale”, dice al Foglio una fonte a conoscenza dell’argomento che preferisce restare anonima, perché non è così frequente il coinvolgimento in prima persona del rettore nelle varie iniziative universitarie. La scorsa settimana, però, il rettore Lorito – il cui nome circola molto come possibile candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania – ha fatto un’eccezione. E l’ha fatta per invitare i docenti a partecipare alla XIV Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, che si terrà dal 13 al 17 novembre nelle città di Pechino e Hangzhou. Casa Cina di Città della Scienza di Napoli è da molto tempo sotto la lente d’osservazione dell’intelligence europea, così come il suo hub principale, e cioè la Fondazione IDIS - Città della Scienza di Bagnoli, dove per almeno 15 anni le collaborazioni nel capo scientifico e tecnologico con la Repubblica popolare cinese sono andate avanti pressoché senza controlli sulla sicurezza nazionale. Ora però la posizione di Pechino nel mondo è un po’ più chiara, i suoi metodi coercitivi e il suo furto di tecnologie sono sempre più alla luce del sole, ma nelle collaborazioni scientifiche e sensibili sembra quasi che l’Italia faccia fatica a stare al passo con i provvedimenti del governo stesso.
“La scienza deve essere aperta quanto possibile, chiusa il necessario. La sicurezza è imprescindibile per garantire una sempre maggiore libertà”, aveva detto la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini un anno fa, lanciando un nuovo programma di sicurezza che è già operativo in tutte le università ed enti di ricerca: la fase sperimentale è già iniziata a gennaio e il sistema, non proprio chiarissimo, ma fatto di linee guida e confini di cooperazione con alcuni paesi considerati “sensibili”, dovrebbe essere pienamente operativo a partire dal 2026. “Perché la ricerca sicura è il futuro: l’Italia, grande produttrice di idee, deve poterle proteggere”, diceva Bernini. Ci si augura che questo spirito costruttivo possa essere tutelato anche a metà novembre quando la ministra stessa partirà per la Cina in occasione della quattordicesima edizione della “Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione”, che l’anno scorso si era svolta a Napoli e due anni fa, a Pechino, era stata l’occasione per porre la firma al protocollo fra Farnesina e ministero della Scienza e della Tecnologia cinese. Quest’anno ci sarà la possibilità di firmare accordi tra università alla presenza di Bernini e del segretario del Partito comunista cinese per la Scienza e la Tecnologia, Yin Hejun. Tra gli argomenti oggetto della settimana, con “la partecipazione di esperti, ricercatori e innovatori”, ci sono materie sensibili per la leadership cinese come il “Diritto ed etica dell’Intelligenza artificiale”, “Scienze della vita e Scienze della salute”, di cui fanno parte le biotecnologie a cui Pechino è sempre più interessata, e “Scienze marine e Scienze polari”, che riguardano anche Artico e Antartide, aree strategiche per la Cina. Per fare qualche esempio, l’anno scorso l’Università di Bologna ha attivato un accordo quadro di cooperazione con lo Harbin Institute of Technology, considerato dal think tank australiano Aspi “ad altissimo rischio per le sue credenziali di sicurezza top secret, l’elevato numero di laboratori e aree di ricerca nel settore della difesa, l’inclusione in vari elenchi di entità e sanzioni, i forti legami con l’industria della difesa e i collegamenti con lo spionaggio economico. L’università è anche un nodo centrale nella cooperazione scientifica e tecnologica sino-russa”. Nel 2023 la Federico II di Napoli ha stretto ben 9 accordi con università ed enti di ricerca cinesi, tra cui la Southern University of Science and Technology, che secondo Aspi “sfrutta la cooperazione internazionale per migliorare i risultati della ricerca del proprio centro di trasferimento tecnologico”.