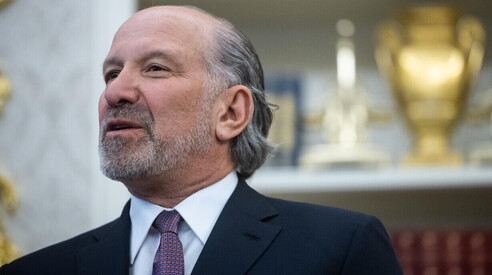Foto di Madalyn Cox su Unsplash
I bonus ci sono, i figli no
La crisi demografica non si combatte solo a colpi di assegni unici. I nuovi dati sulla natalità
I bonus servono, ma non aiutano a fare più figli. Probabilmente, a guidare le decisioni sulla natalità nei paesi sviluppati sono più i fattori culturali che quelli economici. E intanto la spesa per le famiglie cresce vertiginosamente
La demografia è senza alcun dubbio la più grave emergenza, economica e sociale, dell’Italia. Secondo i dati dell’Istat, nel 2024 è stato toccato il record negativo di nascite: 370 mila, 10 mila in meno rispetto al 2023, con una variazione negativa del 2,6 per cento. Il tasso di fecondità nel 2024 è sceso a 1,18 figli per donna, superando il record negativo del 1995 (1,19), quando però era molto più ampio il bacino di potenziali genitori. Per giunta all’epoca, quando c’erano molti meno immigrati, era più alto il tasso di fecondità delle donne italiane attualmente precipitato a 1,11 figli per donna (1,79 per le straniere). Insomma, ci sono molti meno giovani che fanno, in media, meno figli.
Per giunta, aumenta costantemente l’età media al parto delle madri, che nel 2024 ha raggiunto i 32,6 anni, e questo è un fattore che riduce ulteriormente la natalità. Più tardi si fanno i figli, meno se ne fanno. La correlazione tra posticipazione e calo della fecondità è chiara, nei dati dell’Istat, nel caso attuale delle isole (la Sardegna ha la fecondità più bassa e tardiva, mentre la Sicilia ha le madri più giovani e una fecondità tra le più alte del paese). Ma è anche un’evidenza storica incontrovertibile: le donne nate nel 1947 hanno avuto una media di 2,01 figli (dato prossimo al tasso di sostituzione di 2,1) con un’età media al parto di 26,9 anni, mentre le donne nate nel 1975 hanno concluso il proprio percorso riproduttivo nel 2024 con un’età media al parto di 31,4 anni.
Il declino delle nascite prosegue inesorabile dal 2008, quando si è registrato il record di 576 mila nati (oltre 200 mila in più rispetto al 2024), e proseguirà nel futuro. I dati sui primi sette mesi del 2025 dicono che le nascite sono 198 mila, in diminuzione di 13 mila unità rispetto al record negativo del 2024. Lo stesso vale per il tasso di fecondità che nel periodo di gennaio-luglio 2025 è stato di 1,13 figli per donna, in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo del biennio precedente (1,21 figli).
Cosa fare quindi per invertire questa tendenza? La risposta più frequente è sostenere i redditi delle famiglie attraverso il sistema fiscale (meno tasse o più sussidi). E’ un problema reale, dato che in Italia il tasso di povertà è molto più elevato nelle famiglie con minori (fare un figlio è uno dei fattori che maggiormente aumenta il rischio di diventare poveri), e su cui il nostro paese sconta un ritardo storico. Per molti anni le famiglie hanno avuto scarsa considerazione nel sistema fiscale, rispetto a paesi come la Francia, basti pensare che nel 2010 la spesa per le famiglie era solo lo 0,8 per cento del pil rispetto all’1,5 per cento della media Ue. Però qualcosa negli ultimi anni è cambiato notevolmente con l’istituzione nel 2021 (governo Draghi) dell’Assegno unico per i figli, che ha sostituito varie prestazioni precedenti e incrementato le risorse. L’Assegno unico, poi ulteriormente potenziato dal governo Meloni, ora vale circa 20 miliardi di euro, circa 6 miliardi in più rispetto a tutte le misure precedenti. Non è abbastanza? Forse non è esattamente questo il punto.
Gli economisti Massimo Baldini e Stefano Toso, in un articolo pubblicato sulla rivista Politica Economica Journal of Economic Policy, hanno fatto un confronto con i sistemi fiscali (tax-benefit) degli altri paesi, misurando di quanto varia il reddito disponibile di una famiglia rispetto al numero dei figli. Il risultato è sorprendente. In Italia il reddito disponibile di una famiglia aumenta del 4 per cento al primo figlio, dell’11 per cento al secondo figlio e del 19 per cento al terzo figlio. Questa variazione è superiore a quella di tutti i paesi considerati: Germania, Spagna, Svezia, Stati Uniti e persino la Francia del famoso “quoziente familiare”. La spesa monetaria per le famiglie è salita all’1,36 per cento del pil ed è superiore a quella di quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale.
Eppure l’Assegno unico, questa grande innovzione del welfare italiano, non sembra aver portato molti bebè in più. Da un lato perché non è sufficiente, nel senso che la spesa per servizi (asili nido) in Italia è ancora inferiore alla media europea. Dall’altro perché, molto più probabilmente, a guidare le decisioni sulla natalità nei paesi sviluppati sono più i fattori culturali che quelli economici. Ma di questo si discute molto meno che del bonus mamma.