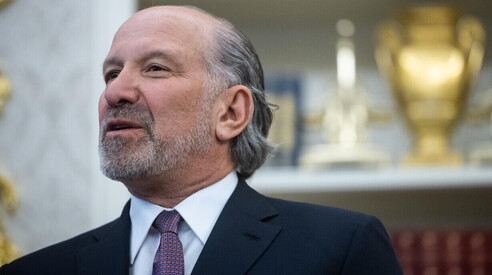Manfredi Catella (foto Ansa)
l'anticipazione
Generare città, idea su idea
Un libro di Manfredi Catella non solo su Milano ma sul futuro globale. Leadership generative e politica autoreferenziale. Il “piano industriale” pubblico che si è fermato. Il ruolo dei privati. Cosa sono i capitali
Pubblichiamo, in anteprima, l’estratto del capitolo “Responsabilità” dal libro di prossima pubblicazione “Otto” di Manfredi Catella, founder e amministratore delegato di Coima Sgr. Il capitolo integrale sarà pubblicato a breve sul profilo Linkedin dell’autore. Insieme a “Inspiring Cities”, pubblicato per i 50 anni di Coima, e a “Noi” – il rapporto di impatto per i primi 20 anni della Fondazione Riccardo Catella – vuole rappresentare un contributo alla riflessione sullo sviluppo di città generative.
Uno dei valori in cui come famiglia crediamo profondamente e che abbiamo perseguito e trasmesso rigorosamente, con l’esempio e con le parole ai nostri figli, è quello di assumersi sempre le proprie responsabilità nel doveroso rispetto di quelle altrui.
Con questo spirito, quando il Giudice delle indagini preliminari mi ha interrogato il 23 luglio su alcune interlocuzioni svolte dalla mia dirigenza, ho serenamente espresso, senza alcuna esitazione, che in quanto amministratore delegato e con la diligenza del buon padre di famiglia assumo sempre le responsabilità per tutte le persone di Coima certo di comportamenti sempre integri sia eticamente, sia deontologicamente.
Questa condotta ritengo faccia la differenza anche tra leadership autoreferenziali e leadership generative. Questo si applica sia alle persone, sia alle organizzazioni siano esse aziende, associazioni, assemblee, espressioni politiche o altro. La leadership autoreferenziale, nel rischio di sopravvivenza, tende a cercare la propria salvezza e non esita a sacrificare qualunque cosa o persona che consenta di distrarre l’attenzione su altro, pronta a girare pagina e proseguire con l’illusione che il tempo non lascerà tracce indelebili. La leadership generativa, al contrario, assume le responsabilità, mette in discussione apertamente e senza timori anche e soprattutto i propri comportamenti e ragioni concretamente per dare soluzioni e contributi pensando innanzitutto agli altri nello spirito che l’Arcivescovo Delpini esprime straordinariamente quando si riferisce al “noi”.
In questo momento di messa in discussione dell’architettura culturale, etica e deontologica di Milano ma che in realtà si riferisce ad un tema più generale di Paese e di modello di sviluppo delle società occidentali, è importante che si componga un dialogo, costruttivo e necessario, aperto ad ogni opinione espressa sempre nel rispetto della legalità, per alimentare un’evoluzione virtuosa che da una parte preservi i molti ingredienti positivi e risultati concreti generati in questi anni e dall’altra sviluppi i contenuti necessari. Si tratta di compensare ciò che è mancato, piuttosto che dibattere su modelli teorici sostitutivi e Milano ha già uno straordinario modello ambrosiano da preservare e tramandare.
Il paradigma economico adottato dalle società occidentali negli ultimi decenni, fondato sul profitto come sintesi di equilibrio e basato sull’assunzione di risorse illimitate, ha generato evidenti squilibri imponendo una rivalutazione su come integrare il modello con obiettivi anche sociali e ambientali oltre che finanziari. Si tratta di un’evoluzione culturale, economica e politica che richiede responsabilità e competenza. Sfruttare le tensioni sociali che si sono formate in molti luoghi del mondo occidentale attraverso azioni strumentali, come ad esempio alterare la realtà fino a descriverne versioni non corrispondenti al vero, è pericoloso. L’omicidio di Charlie Kirk, 32 anni e padre di due figli, a prescindere dalle posizioni personali, dovrebbe fare riflettere tutti i soggetti rappresentativi di collettività. Il rischio di deriva con conseguenze drammatiche, in questa fase storica, è evidentemente alto e richiede una responsabilità etica volta a coinvolgere tutti per unire e non per dividere. E’ il momento delle responsabilità. Partiamo da qui.
La riflessione che propongo si articola su tre pilastri: 1) Visione e piano industriale. 2) Organizzazione e regole. 3) Capitali.
Visione e piano industriale
Ogni forma di organizzazione ha bisogno di una visione che definisca l’orizzonte e un piano industriale che ne abiliti la realizzazione attraverso obiettivi chiari e risorse adeguate. La città in questo senso è una forma di organizzazione e la visione e il piano industriale compete al pubblico. Il privato, se invitato al tavolo, al più può contribuire al dibattito attraverso le proprie esperienze operative. I flussi demografici, confermati anche dopo l’esperienza della pandemia, determineranno un aumento della popolazione mondiale che vivrà nelle città che arriverà fino al 70 per cento, ossia un miliardo di persone in più si sposterà a vivere in città. Appare quindi evidente come la città rappresenti una delle forme organizzative più importanti della nostra specie.
Milano, ad esempio, è una città che ha vissuto una fase propulsiva durata 14 anni dal 1997 al 2011. Sono gli anni in cui la rigenerazione urbana ha preso forma attraverso alcuni progetti urbani emblematici riconosciuti per qualità e per sostenibilità a livello internazionale. La fase successiva fino ai giorni nostri, dal 2011 al 2025 e ancora in corso rispetto alla durata del mandato politico fino al 2027, rappresenta un periodo che ha innanzitutto beneficiato di una dote importante di risorse generate nella fase precedente. In questi anni lo sviluppo urbano è proseguito. Il merito principale è da riconoscere alle università che hanno saputo diventare motori di trasformazione del territorio con progetti eccellenti come, ad esempio, quelli promossi da Bocconi, Politecnico, Cattolica, Statale e altri atenei.
Il consenso sull’importanza di sviluppare città inclusive è unanime. Tutti siamo d’accordo. Il punto è come realizzare questo obiettivo in modo sostenibile. E’ su questo che, in particolare, gli attori pubblici, hanno la responsabilità di pianificare o meglio avrebbero dovuto attuare soluzioni in tempi realistici dopo la precedente fase propulsiva così da trovare una composizione complessiva equilibrata evitando l’acuirsi di tensioni sociali. Con spirito costruttivo e guardando avanti, condivido alcune brevi considerazioni come contributo ad un tema, certamente non semplice, che richiede inevitabilmente più linee di azione simultanee sia a livello nazionale, sia locale.
Innanzitutto fermare i cantieri significa avere meno offerta di case e quindi alimentare un incremento dei prezzi oggi insostenibile da quasi tutti. Proprio dai progetti in corso o pronti per la fase produttiva potrebbero già essere generate migliaia di abitazioni e di posti letto per gli studenti nell’arco di 3-5 anni. Ad esempio, solamente il nostro progetto di riqualificazione urbana previsto dal piano attuativo di Porta Romana dopo quattro anni è ancora in attesa delle autorizzazioni. Il piano prevede anche la realizzazione di case convenzionate e in edilizia popolare, attraverso la collaborazione con Consorzio Cooperative Lavoratori, con 800 famiglie socie che stanno aspettando.
Il Villaggio Olimpico, che abbiamo realizzato in 30 mesi essendo un’opera di interesse pubblico indifferibile, sarà convertito nel più grande studentato convenzionato in Italia con 1.700 posti letto disponibili a partire dall’anno accademico 2025-2026. Le tariffa media a posto letto è del 25 per cento inferiore alla media di mercato con 450 posti letto con tariffa agevolata di euro 427, oltre servizi e Iva. E’ un’opera che ha unito le forze tra investitori, tra imprese italiane, tra pubblico e privato ed in prospettiva tra studenti di tutte le facoltà e università della città. Sono numerosi i progetti anche di altri operatori che contribuirebbero in pochi anni a mettere a disposizione delle famiglie migliaia di case a valori accessibili.
Esiste poi un ampio patrimonio immobiliare privato oramai obsoleto, prima ancora di quello residenziale pubblico. Una buona parte degli edifici per uffici, ad esempio, costruiti in particolare tra gli anni Sessanta e Ottanta. Milano ne conta per oltre 350 mila metri quadrati. Roma ha numeri altrettanto rilevanti in particolare per gli edifici della pubblica amministrazione. Questo è un patrimonio edilizio già esistente che può essere riconvertito in funzioni residenziali in tempi brevi se vi fossero regole certe e un sistema di incentivi trasparente ed efficace.
L’Italia ha poi una risorsa straordinaria rispetto ad altre nazioni che deriva dalla nostra storia, che ha composto un territorio costellato di città vicine tra loro. Le infrastrutture, e in particolare i collegamenti metropolitani e ferroviari con connessioni accelerate grazie all’alta velocità, avvicinano ulteriormente le città. In meno di un’ora – il tempo minimo necessario per attraversare Londra – è possibile raggiungere più città sia da Milano, sia da Roma. Questo contributo, attivato investendo in infrastrutture di mobilità, limiterebbe inoltre il consumo del suolo, riattiverebbe economie locali e sarebbe realizzabile in tempi brevi essendo le case già disponibili ma oggi non occupate per le migrazioni demografiche. E’ evidente che questa tessera del mosaico può rispondere ad una parte del ceto medio e famiglie e non certo, ad esempio, a categorie di lavoratori che ogni giorno fanno funzionare la città in settori vitali come i trasporti, le scuole, la sanità, la sicurezza, i servizi alla collettività, che invece hanno bisogno di soluzioni abitative vicine al posto di lavoro. D’altra parte i nuclei urbani di prossimità sono altre realtà territoriali che possono contribuire alla soluzione.
Ci sono certamente molte altre soluzioni, già oggetto di elaborazione nell’ambito dei piani casa nazionale e locali anche nell’ambito di programmi della comunità europea e di iniziative di attori primari quali Cdp, il mondo cooperativo e attori del settore no profit, che possono comporre un complessivo approccio industriale efficace.
Organizzazione e regole
Ogni visione e piano industriale di qualunque organizzazione ha poi evidentemente bisogno di regole e di risorse. Rimanendo nell’esempio di Milano, la legittimità delle regole urbanistiche ed edilizie applicate in questi anni dalla pubblica amministrazione è oggetto di indagine generando sospensioni di cantieri e incertezza. Le regole sono una derivata della visione e del piano industriale che per definizione sono di competenza del settore pubblico. Se il pubblico si sottrae da questo ruolo fondamentale di garante di norme e regolamenti trasparenti e della relativa applicazione, il mercato si ferma con tutte le relative conseguenze. L’evoluzione delle nostre città in un’epoca di transizione così profonda, anche dal punto di vista energetico e tecnologico, dipende necessariamente da un aggiornamento anche normativo a partire dall’attuale legge urbanistica che risale al 1942. In questo senso l’iniziativa legislativa in fase di promozione a livello nazionale potrebbe contribuire a comporre le indispensabili risposte.
Ogni visione e piano industriale ha poi bisogno di risorse e in particolare di persone. Rimaniamo a Milano come esempio. Le pratiche edilizie dal 2015 ad oggi sono cresciute esponenzialmente, d’altra parte le risorse nell’organico del settore dell’urbanistica e dell’edilizia del Comune sono rimaste al più sostanzialmente invariate. Nella nostra esperienza la criticità non è quindi la professionalità e la deontologia dei funzionari pubblici, ma semmai è l’ampiezza dell’organico rispetto alle esigenze esecutive che inevitabilmente, se non adeguata, aumenta il rischio operativo che può tradursi quindi in minore produzione, tempi più lunghi, incertezze o una combinazione di questi effetti.
La commissione del Paesaggio è un altro esempio organizzativo emblematico prevedendo membri: 1) non remunerati per la durata del mandato; 2) autorizzati ad assumere incarichi professionali per sostenersi; 3) responsabili dell’onere di dichiarare conflitti di interesse con la conseguente necessità di una regolamentazione inequivocabile, una formazione adeguata e una governance rigorosa di controllo regolare.
Un simile assetto organizzativo, modificato solo di recente, lo scorso 12 giugno, non ha consentito un ingaggio adeguato nel rapporto tra pubblico e privato e ha generato, insieme all’assenza di chiarezza delle regole, danni ingentissimi innanzitutto sociali sia a carico delle famiglie sia dell’intera filiera produttiva di mercato.
Capitali
Per finanziare la transizione è importante comprendere le caratteristiche anche del mercato dei capitali privati rappresentato da attori strutturalmente diversi rispetto agli operatori del passato.
Oggi gli operatori in Italia sono principalmente rappresentati da soggetti vigilati da Banca d’Italia e da Consob con rilevanti strutture di controllo e di governance, come ad esempio le società di gestione del risparmio (SGR), rappresentando un sistema ampiamente presidiato. Gli investitori, nazionali e internazionali, sono principalmente fondi pensione, assicurazioni, fondazioni, banche e fondi sovrani. Istituzioni che hanno l’obiettivo inderogabile di ottenere un rendimento finanziario dagli investimenti. Ad esempio i fondi pensione generano le risorse per pagare le pensioni ai propri contribuenti dai rendimenti degli investimenti. Il livello di rendimento è una derivata del livello di rischio. Il così detto “risk free” è quello espresso dai titoli di Stato, ogni altro investimento deve necessariamente avere un rendimento superiore coerente con il relativo livello di rischio.
Un mercato dei capitali così rappresentato richiede regole chiare e trasparenza per operare. L’inchiesta in corso ha già interessato operatori che gestiscono oltre 40 miliardi di euro di investimenti immobiliari in Italia e che rappresentano investitori primari a livello globale con un patrimonio complessivo che supera ampiamente i 5 trilioni di euro. L’ampia diffusione mediatica a livello internazionale ha poi amplificato l’arresto degli investimenti in sviluppo interrompendo anche i relativi impatti positivi economici, ambientali e sociali. Appare quindi evidente come sia determinante identificare un percorso che consenta di far rientrare un potenziale rischio sistemico che non contribuirebbe certamente a generare città generative e più inclusive. Guardando avanti, ritengo che la filiera industriale e professionale italiana nel settore sia matura, ampiamente competente e qualificata e che siano molte le iniziative e i progetti positivi già attuati, così come sia possibile in prospettiva fare bene nell’interesse di tutte le comunità. Sarebbe certamente utile in questo senso un’assunzione di responsabilità anche da parte delle associazioni di categoria, ad esempio, rendendo pubblica un’analisi approfondita di quale sia stato l’impatto consolidato della filiera complessiva di settore.
A titolo di esempio, riferendoci ai dati di nostra competenza, solamente i progetti che abbiamo realizzato a Milano negli ultimi 10 anni hanno consentito riusi edilizi e rigenerazioni per 27 iniziative per 3 milioni di metri quadrati lordi inclusa la riqualificazione di 500 mila metri quadrati di aree pubbliche con attivazione di programmi civici e culturali con oltre 500 mila partecipanti. Gli investimenti complessivi in progettazione e in costruzione sono stati di oltre 5 miliardi di euro con un impatto occupazionale complessivo di 26 mila persone, con attivazione per oltre il 50 per cento di fonti energetiche rinnovabili e ad oggi oltre 300 milioni di euro di contributi al Comune di Milano.
Solamente la riqualificazione dello scalo ferroviario dismesso di Porta Nuova, che abbiamo realizzato tra il 2005 e il 2025, inclusi gli interventi in corso e di prossimo avvio tra cui il Pirellino con il progetto di riqualificazione di Elizabeth Diller, vincitrice del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2025, ha generato, secondo lo studio di impatto pubblicato insieme al centro di ricerca di Tiresia del Politecnico di Milano e a The European House di Ambrosetti, un impatto complessivo significativo nel periodo di sviluppo con oltre 10 miliardi di valore economico generato, 50 mila occupati, oltre 600 milioni di contributi pubblici, oltre 13 mila tonnellate di CO2 evitate annualmente. Appare evidente come un bilancio complessivo di impatto del settore composto dal contributo di tutti gli operatori e filiere offrirebbe una rappresentazione ben più significativa e certamente importante per condividere valutazioni su basi oggettive. E’ innanzitutto però il momento dell’assunzione di responsabilità su cui torniamo.
Il ritardo di oltre 10 anni di una pianificazione che consentisse di rispondere alle esigenze abitative delle fasce più fragili destinato evidentemente ad aumentare, in particolare a Milano data la propulsione dello sviluppo economico e urbano degli anni precedenti, ha causato la dinamica che oggi è diventata emergenza e che richiederà necessariamente molti anni prima di essere risolta, contribuendo a generare tensioni e contrapposizioni con effetti negativi per tutti. Allo stesso modo una mancata revisione di un quadro normativo urbanistico ed edilizio aggiornato, nazionale e locale, con regole chiare e tempi certi derivato da una strategia e da un programma di sviluppo del territorio ben strutturato, ha determinato la situazione attuale di stallo dei cantieri con le note gravi conseguenze per le famiglie ed effetti economici che avranno impatti significativi sulle imprese e sul mercato del lavoro.
Non sarà la retorica dei grattacieli e dei residenti stranieri benestanti, né l’accusa al mercato come capro espiatorio a generare città inclusive, ma piuttosto l’assunzione di responsabilità pubblica con la volontà adesso di unire per affrontare, con soluzioni concrete, quello che è mancato.
Questo è il momento in cui le più alte istituzioni del Paese e la classe dirigente, lavorando insieme, hanno l’opportunità di sviluppare soluzioni che consentano di affermare la reputazione italiana nel mondo interpretando lo sviluppo del territorio come atto responsabile su un bene per definizione di interesse collettivo ed evitando che capitali domestici e internazionali vengano dirottati altrove con i relativi impatti sull’economia nazionale.