
Al vertice in Alaska non è stato invitato Zelensky, ma nemmeno Xi. Entrambi aleggiano attorno al tavolo di Trump e Putin (foto GettyImages)
magazine
La partita del petrolio si gioca fra pochi giganti. Tra strategie e ricatti
È il convitato liquido al vertice in Alaska. Un approccio mercantile a Washington, una questione esistenziale a Mosca
Il vertice di Ferragosto in Alaska è stato preceduto da un tam tam mediatico che nemmeno a Jalta tra Stalin, Churchill e Roosevelt nel 1945, o a Reykjavik nel 1986 tra Reagan e Gorbaciov. Certo, sono in ballo le sorti del mondo, l’America agli americani, l’Eurasia ai russi e fanfaluche del genere. E’ vero, sono in discussione le guerre in Ucraina e a Gaza, ma diciamo le cose come stanno: per Donald Trump l’Ucraina è una questione europea, quindi russa; mentre Gaza secondo Vladimir Putin è affare americano o piuttosto di Benjamin Netanyahu che “Zar Vlad” deve ringraziare per non essersi impegnato come avrebbe potuto (e dovuto) in difesa degli ucraini. Ma nei giorni prima del meeting s’è materializzato un convitato di pietra, anzi liquido: il petrolio o meglio l’oil & gas, come si dice. Per entrambi gli sfidanti è lo strumento per una prova di forza, ma in modo diverso. Per Trump prevale il lato mercantile e clientelare, far soldi per sé e per gli amici petrolieri che lo sostengono, per Putin è una questione di sopravvivenza. Il paradosso è che si trovano bloccati in quello che gli studiosi chiamano l’equilibrio di Nash, cioè il punto in cui nessuno può prevalere, una situazione senza vincitori né vinti.
Il petrolio è una partita tra pochi giganti: se prendiamo i maggiori produttori abbiamo oggi nell’ordine gli Stati Uniti, la Russia e l’Arabia Saudita; se consideriamo quanto incidono gli idrocarburi nell’economia di ciascun paese non in moneta, ma in produzione per abitante, allora è prima di gran lunga l’Arabia Saudita, poi vengono la Russia e gli Stati Uniti, non solo per via del numero degli abitanti, ma anche per il diverso livello di sviluppo industriale. I tre grandi esportatori sono di nuovo Usa, Russia e Arabia Saudita. Calcolando i consumi energetici, gli americani battono tutti, seguiti da Cina e India che in questo primo quarto di secolo si sono fatte avanti allargando il terzetto originario, più Brasile, Canada, Indonesia, potenze minori ma importanti. Comunque la si giri, l’oro nero, dopo anni in cui sembrava una materia prima tra le altre, ridimensionata dalle energie rinnovabili, è di nuovo un’arma politica e conta tanto quanto l’oro giallo, forse di più.
Non sappiamo se Putin e Trump hanno letto Nash e la sua teoria. Certo la conoscono i russi che vantano scienziati di prima grandezza, mentre gli americani l’hanno applicata nella corsa agli armamenti durante la Guerra fredda e la seguono ancor oggi quando si tratta di equilibrio nucleare. Immaginiamo che The Donald abbia visto il film “A Beautiful Mind”, con John Nash interpretato da Russell Crowe. In ogni caso, detta in soldoni, la tesi che è valsa il Nobel al geniale matematico americano è questa: “Un gioco può essere descritto in termini di strategie dei giocatori: l’equilibrio c’è quando tutti compiono la stessa mossa ritenendola la migliore possibile per non essere battuto, ma nessuno riesce a migliorare in maniera unilaterale il proprio comportamento temendo che gli altri facciano lo stesso”. A differenza di quanto sostenevano Adam Smith e la teoria neoclassica, è vero che ogni soggetto agisce perseguendo il proprio interesse, tuttavia questo comportamento conduce a una sorta di stallo, non a un bene comune. Per cambiare, dice Nash, “occorre agire insieme”, può non essere ottimale o efficiente, ma è l’unica via d’uscita. Ebbene, il gioco petrolifero oggi è arrivato a questo punto.
Il nocciolo della questione per Trump si chiama shale. Estrarre petrolio e metano da scisti argillose bombardandole con potentissimi getti d’acqua era una tecnica nota fin dall’Ottocento (la si usava anche nella corsa all’oro), ma per una serie di motivi (la quantità di idrocarburi più facili da tirar fuori con i pozzi, anche quelli marini nel Golfo del Messico, la tecnologia ancora arretrata, i costi compresi quelli dell’uso del terreno, i prezzi di mercato e via dicendo) è stata applicata in modo massiccio solo in questo secolo. Ha raggiunto il vertice cinque anni fa, ha attraversato una seria crisi che ha prodotto, come sempre accade, una dura selezione, e ha trasformato gli Usa nel primo produttore ed esportatore mondiale, lasciando indietro russi e sauditi. Adesso, ha raggiunto quello che molti analisti considerano il punto di non ritorno soprattutto per quel che riguarda il gas naturale. I dati sono ufficiali e vengono dall’Amministrazione americana sull’energia, sbrighiamoci a leggerli prima che Trump licenzi anche il direttore dell’Eia. Nel 2010 la produzione annuale era 40 miliardi di piedi cubi al giorno (poco più di 13,19 miliardi di metri cubi) da pozzi scavati nel suolo o nel fondo marino e 20 milioni da scisti. Poi è arrivata la rivoluzione shale: nel 2020 il picco è stato di 80 miliardi da scisti e 20 da pozzi, dopo di che la curva ha cominciato a flettere e lo scorso anno per lo shale gas la crescita è stata negativa. I metanieri americani debbono trovare nuovi sbocchi se non vogliono restare soffocati dai debiti, infatti la maggior parte delle imprese si sono rette prendendo i soldi in prestito soprattutto dal florido mercato dei junk bonds, i titoli spazzatura che servono ad alimentare i settori industriali ad alto rischio nella speranza di trarre buoni guadagni grazie agli interessi più elevati e scommettendo sul successo delle imprese le quali a loro volta possono far fronte ai debiti solo con profitti sempre maggiori. Il circuito si è interrotto già nel 2020 e ha fatto molte vittime, clamorosa la bancarotta della Chesapeake, tra le pioniere del fracking, azienda simbolo della nuova rivoluzione, incapace di pagare gli interessi per 13,5 milioni di dollari.
Da allora è diventato chiaro che l’intero settore ha bisogno di una spinta esterna. Se non viene dalla domanda mondiale che sta rallentando anche per colpa dei dazi, allora deve arrivare dal governo. Il mercato di per sé non aiuta perché i prezzi sono ben al di sotto del punto in cui lo shale gas & oil è profittevole: 90 dollari al barile sarebbe la quota ideale, meno di 75 è un prezzo critico e oggi siamo attorno ai 63 dollari per il West Texas. Trump sta ricattando i paesi che si approvvigionano altrove, con una evidente forzatura politica. Per il gas, che viaggia per nave in forma liquida, l’Europa diventa lo sbocco naturale: è la fonte energetica principale in Germania e in Italia, i due maggiori paesi manifatturieri (sommando i loro consumi, sarebbero i quinti al mondo dopo Usa, Russia, Cina e Iran). In realtà l’Europa è già piena di metano, dalla Norvegia, dal Nord Africa e dal Caspio, dal Golfo Persico, dalla stessa America e ancora dalla Russia che fino all’invasione dell’Ucraina era la venditrice numero uno. Per placare l’ira funesta di Trump, l’Italia ha cominciato a comprare di più dagli Stati Uniti, ma che l’Ue possa dare 750 miliardi di dollari agli americani, come nell’accordo con Ursula von der Leyen, è campato per aria. Quanto al petrolio, The Donald tuona contro i paesi, a cominciare dall’India, dalla Cina o dal Brasile, che ne acquistano da Putin, eppure dice di voler normalizzare gli scambi con la Russia. E’ il suo solito bluff: lui può comprare dove vuole, tutti gli altri a cominciare dagli alleati debbono comprare solo da lui. Funziona? Non funziona, non più.
E qui incontriamo l’altro giocatore, Vladimir Putin. Per lui vendere più oil & gas non è solo un obiettivo di potere, è una questione di sopravvivenza. E’ stato aiutato dalla Cina e in particolare dall’India. Prima della guerra in Ucraina, il greggio russo era solo lo 0,2 per cento delle importazioni indiane, adesso è arrivato al 36. E’ stato sostituito soprattutto il petrolio americano anche se ne hanno pagato le conseguenze l’Arabia Saudita e l’Iraq. Mosca ha venduto con forti sconti e oggi il suo greggio è molto conveniente, naturalmente questo riduce i margini di guadagno, ma la Russia punta sulla quantità, sul flusso di dollari che entra nella banca centrale e in questi anni ha tenuto a galla l’economia: Mad Vlad dovrebbe erigere un monumento a Elvira Nabiullina, l’economista che dai sogni liberali della gioventù si è convertita, all’insegna del vecchio detto “giusto o sbagliato, è il mio paese”.
E qui incontriamo l’altro giocatore, Vladimir Putin. Per lui vendere più oil & gas non è solo un obiettivo di potere, è una questione di sopravvivenza. E’ stato aiutato dalla Cina e in particolare dall’India
Secondo il Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), Mosca ha raggiunto nel 2023 il record assoluto di vendita di petrolio all’estero, l’Occidente credeva di aver intaccato le fonti di guadagno del Cremlino, ma non c’è riuscito. Si parla di 37 miliardi di dollari di combustibile venduto, e nel rapporto Crea si legge che nei paesi che hanno imposto sanzioni a Putin circola almeno il 3 per cento di prodotti petroliferi ottenuti dal greggio russo per circa 8,5 miliardi di euro. Mosca è arrivata a esportare quattro milioni di barili al giorno, alla faccia dei tagli alla produzione e delle sanzioni che sono state aggirate abbastanza facilmente. Le compagnie petrolifere indiane raffinano parte del petrolio russo per consumo interno, ma ne destinano un’altra quota all’esportazione verso l’Europa (soprattutto gasolio). L’embargo, d’altronde, non colpisce i beni energetici raffinati fuori dalla Russia. Nel 2023 l’India ha venduto per quasi 87 miliardi di dollari prodotti lavorati, diventando il secondo maggior esportatore mondiale, dicono le cifre del National Bureau of Asian Research. Così il greggio russo va in India, viene raffinato e poi finisce nei paesi che hanno sanzionato Mosca: Unione europea, Stati Uniti e Regno Unito.
Pechino resta il primo cliente e lo scorso anno ha importato 108,5 milioni tonnellate dalla Russia, pari a quasi un quinto dell’acquisto totale di petrolio, con sconti del 20-25 per cento sui prezzi; un balsamo per un’industria che stenta a sostituire con il mercato interno il mercato estero (le esportazioni sono tornate a crescere). Nei mesi scorsi il flusso petrolifero è proseguito anche se a un ritmo meno intenso. Ha inciso il rallentamento dell’economia cinese e anche il braccio di ferro sui dazi. Trump ha deciso di concedere a Pechino altri 90 giorni di tempo, ma ha rinnovato la minaccia di un ulteriore 25 per cento sulle importazioni. Il principio di non ingerenza diventa lo scudo ideologico di Pechino. Rifiutando l’ultimatum, Xi Jinping ha lanciato un messaggio preciso: non accetterà mai di essere ridotto a un attore subordinato sulla scena globale. Il petrolio russo diventa così il simbolo tangibile della costruzione di un’alleanza alternativa al blocco occidentale, un asse che si muove al di fuori dei circuiti controllati dal G7 e dalle istituzioni finanziarie anglo-americane. Si tratta di un legame strutturale, non episodico: la dipendenza reciproca tra Russia (come fornitore) e Cina (come acquirente strategico) crea un legame che offre protezione a entrambi. Questo patto energetico assume un forte valore simbolico: mentre l’occidente punta sull’embargo e sull’isolamento, Pechino e Mosca rispondono con la creazione di circuiti paralleli di approvvigionamento, pagamento e distribuzione. Un modello in cui l’autosufficienza energetica si fonde con la capacità di aggirare le sanzioni e di costruire un’infrastruttura di cooperazione non occidentale (in alcuni casi apertamente anti occidentale) che include l’Iran, il Venezuela, l’Arabia Saudita e alcuni paesi africani.
La strategia cinese più il ricatto tariffario americano rischiano di avviare un effetto domino su scala mondiale. Sarebbe catastrofico per la Cina, ma non solo. Checché se ne dica il commercio è strettamente interconnesso, anche se la “politica della porta aperta” viene rinnegata da Trump, le porte non si possono più chiudere. La globalizzazione è cambiata profondamente, ma non è finita, non ancora. Davanti al ricatto petrolifero americano, Pechino mette sul tavolo le tre questioni che gli stanno a cuore. La prima è Taiwan e qui vale il principio di non ingerenza. La seconda è l’alta tecnologia, in particolare i microchip. Terza la transizione verde nella quale la Cina ha una posizione leader, tra minerali strategici, batterie, pannelli solari, pale eoliche. Tuttavia Xi Jinping si trova di fronte a un dilemma complesso: difende meglio i suoi interessi se continua l’escalation dazio su dazio, oppure se tratta come hanno fatto ormai tutti gli altri? Anche lui si trova di fronte al teorema di Nash.
La strategia cinese più il ricatto tariffario americano rischiano di avviare un effetto domino su scala mondiale
Al vertice in Alaska, non è stato invitato Zelensky, ma nemmeno Xi. Entrambi tuttavia aleggiano attorno al tavolo sul quale Trump e Putin calano le loro carte. Alla finestra s’affollano l’Europa, l’India e tutti gli altri. I giocatori sono più di due, ma questo non cambia né la teoria né la prassi. Chi conosce le strategie aziendali sa che non seguono Smith, ma Nash. Si possono fare molti esempi anche semplici. Aprire i negozi là dove ci sono i concorrenti per controllarli e magari sfruttare la loro scia (se tutti lo fanno nessuno se ne avvantaggia). Scegliere se sviluppare una propria tecnologia o comprare da chi già ce l’ha, in funzione a quel che fanno tutti gli altri concorrenti. E così via. Nel film “A Beautiful Mind” c’è una scena molto efficace: appare nel pub degli universitari un gruppo di ragazze guidate da una bellissima bionda e tutti i giovani genietti di Princeton, pieni di birra e whisky, si girano incantati. Ognuno si fa avanti per conquistarla, pensando che se poi non vince può sempre agganciare una delle amiche, ma lei li lascia con un palmo di naso e se ne va seguita da tutte le altre. Spiega Nash-Crowe: l’errore è puntare tutti sulla bionda, vi siete intralciati a vicenda e in più avete perduto le altre ragazze che non sopportano di essere considerate un ripiego. La teoria classica sostiene che il miglior risultato si ottiene quando ciascun componente del gruppo fa il meglio per se stesso, Nash dice che si raggiunge quando fa il meglio per se stesso e per gli altri. Se scendiamo dall’iperuranio all’iper-realtà, allo stato attuale dei rapporti internazionali, tra Stati Uniti e Russia in particolare, scopriamo di essere caduti nella trappola della bionda. Per uscirne bisognerebbe “agire insieme”, ma questo oggi è solo un sogno da premio Nobel.
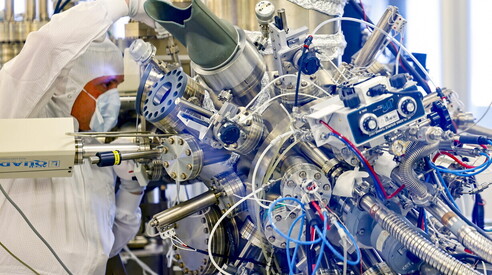


lottizzazione e lauree



