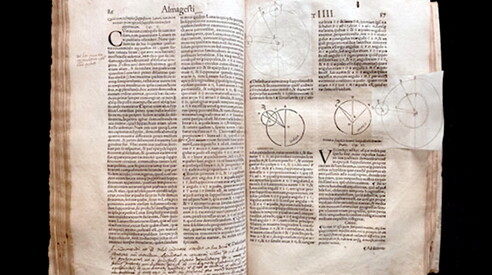Foto Lapresse
Magazine
In lode di un capro espiatorio. Cent'anni fa nasceva Carlo Mazzantini
La ricerca del riscatto a Salò e l’infamia sulla generazione sbagliata. Nessuno prima di lui aveva messo a nudo con tanta passione e dolore l’atmosfera torrida di quei giorni vissuti e sofferti dalla “parte sbagliata”. Oggi il suo nome sparisce: troppo irregolare, troppo inetichettabile
Avevano tutti sui diciott’anni, qualcuno addirittura sedici, e persino “quindicenni sbranati dalla primavera”, quelli cantati da Francesco De Gregori nella sua splendida “Il cuoco di Salò”. Giovanissimi ancora imberbi come Carlo Mazzantini, di cui in questo finale del 2025 ricorre il centesimo della nascita, ma per i festival letterari conformisti e le kermesse culturali alla moda il suo nome sparisce, condannato nel dimenticatoio, troppo irregolare, troppo inetichettabile. Mazzantini, neanche diciottenne all’epoca, e questi disperati adolescenti mollarono tutto, travolti dallo “smarrimento” abissale di ragazzini che vedevano tutt’intorno sfasciarsi nella vergogna il loro mondo, con la “sensazione di essere uno sradicato”, “privato d’un tratto della capacità di reggermi in un mondo che aveva perduto il suo centro e si era rotto in frammenti senza più legami”. Inseguirono ciecamente il riscatto andando “a cercar la bella morte” a Salò, nella Rsi di un Mussolini invecchiato e irriconoscibile e sconfitto, a sparare l’ultima raffica in una partita dove non avevano niente da perdere perché sentivano di aver perduto già tutto, tra il 25 luglio e l’8 settembre del ‘43. Il giorno del “tutti a casa”. Nessuno prima di Mazzantini aveva messo a nudo con tanta passione e tanto dolore l’atmosfera torrida di quei giorni vissuti e sofferti dalla “parte sbagliata”, la formula che i vincitori hanno ritagliato per la messa al bando dei vinti.
Erano cresciuti nel fascismo come se fosse un ambiente naturale, per sempre e non dentro una parentesi storica destinata a un inizio e a una fine, come pesci in un’acqua che consideravano quel liquido il loro habitat immodificabile, come l’ossigeno per noi umani. Ma se chiedi a un pesce cos’è l’acqua, ha scritto David Foster Wallace, non saprebbe cosa rispondere, non saprebbe come concettualizzarla. E così fu per loro: nuotavano nel fascismo, ma se gli chiedevi cosa fosse il fascismo non avrebbero risposto: c’era, punto. Percepivano nei primi anni della loro vita di crescere in un “universo concorde di voci, di atti, di immagini”, un unanimismo chiassoso, il dissenso delle piccole minoranze zittito. La realtà non era così, c’era la dittatura, l’olio di ricino, il confino, l’esilio per l’esile pattuglia che disse “no”. Ma tra marce, marcette, divise e sabati fascisti avevano succhiato avidamente il latte del regime vissuto come qualcosa di sacro.
Tra marce, marcette, divise e sabati fascisti Mazzantini e i suoi coetanei avevano succhiato il latte del regime vissuto come qualcosa di sacro
Si erano appassionati con quella sloganistica trionfalistica e trucibalda, “giovinezza, giovinezza”, “colli fatali”, “vincere”, “meglio un giorno da leoni”, il Duce atleta, il Duce aviatore, il Duce istrionico sul balcone, l’Impero, “spezzeremo le reni”, le fanfaronate, le smargiassate che riscaldavano ed esaltavano il sentimento di appartenere a qualcosa di elettrizzante, di bello, di potente, di indistruttibile, di eterno. E adesso tutto andava miserabilmente in pezzi, per la gioia dei “traditori” che dopo il 25 luglio del ‘43 buttavano giù i busti di Mussolini venerati fino al giorno prima, le spillette del partito strappate dai baveri e gettate nelle fogne per far dimenticare il passato. E quei ragazzini, inebriati dal culto dell’onore scapparono di casa, esaltati da una mistica del sacrificio: a cercar “la bella morte”.
Dopo il 25 luglio del ’43 quei ragazzini, inebriati dal culto dell’onore e da una mistica del sacrificio, andarono a cercar “la bella morte”
La maggioranza di loro non morì nel conflitto armato, ma furono sconfitti, si rinchiusero nelle catacombe dei vinti, maledetti. Loro che avevano combattuto per l’onore, dopo il 25 aprile si ritrovarono emblemi del disonore, esposti al pubblico ludibrio, sicari e fantocci dell’occupante hitleriano, spesso inseguiti casa per casa. Tutto attorno a loro divenne luttuoso, funebre, mortuario. Quando nacque il Msi, che doveva raccogliere le truppe sparse e lacere dei fascisti sconfitti, si scelse un inno che anziché celebrare una nuova nascita declamava sin dalle prime parole lo sbigottimento di una fine: “Siamo nati in un cupo tramonto”. Mazzantini, diventato ventenne, nell’Italia liberata non si arruolò sotto le insegne di un’adunata di reduci. Giovanissimi e già “esuli in Patria”, come li ha definiti Marco Tarchi, alcuni si mobilitarono per organizzare immaginarie e velleitarie rivincite. Altri “rinnegarono” sé stessi e passarono dall’altra parte, la “parte giusta” contro cui, volontari della “parte sbagliata”, avevano combattuto. I più si ritirarono dalla vita pubblica. Si appartarono. Ricominciarono da zero. Attraversarono il deserto della solitudine e dell’amaro disincanto.
Mazzantini lascerà l’Italia per andare a insegnare a Parigi, poi a Galway in Irlanda, un posto incantevole con un porto che si affaccia sull’Oceano Atlantico, poi a Tangeri, tornando infine in Italia, ma non in una grande città: a Tivoli, immerso nella campagna e nella natura. Si sposerà con una brillante e vulcanica artista irlandese, Anne Donnelly. Nasceranno quattro figlie, Moira, agente e produttrice di spettacolo, Giselda Volodi, attrice, Margaret, scrittrice, Cristina, giornalista. Ma nei decenni un uomo divorato dalla passione della vita non ha fatto che meditare e rimuginare sul suo passato, sulle sconfitte, sulle delusioni, sull’iniquità di una dannazione che va ben al di là del trattamento solitamente e civilmente riservato ai perdenti. I giovani che andarono a Salò erano i reietti, indicati al linciaggio da chi invece aveva fatto carriera nel fascismo, e ne venne gratificato con prebende, incarichi, sovvenzioni, cattedre (anche quelle usurpate agli ebrei cacciati dall’Università con le leggi razziali del ‘38: ma un vero pentimento per una cosa così abietta, dopo), e su cui l’antifascismo ufficiale scaricò “le colpe che erano dell’intera nazione”. Lo stesso Mazzantini scrisse che ai suoi coetanei in camicia nera nei reggimenti della Rsi venne assegnata nel dopoguerra democratico la terribile funzione dei “pharmakoi”, dei capri espiatori su cui imprimere il marchio d’infamia che avrebbe piuttosto meritato la generazione precedente, quella dei “vecchi con gli stivali” presi di mira beffardamente da Vitaliano Brancati, quella che nel fascismo visse come topi nel formaggio, salvo abiurare, svicolare, spergiurare, cancellare le tracce, fuggire, trasmigrare al primo accenno della disfatta che avrebbe travolto l’Italia fascista. Con uno stravolgimento crudele delle parti in causa, proprio i conniventi con il regime divennero i principali accusatori degli ultimi arrivati, dei “Balilla che andarono a Salò”, come si intitola un altro libro bellissimo (pubblicato dalla Marsilio) di Carlo Mazzantini.
Questo libro del 1995 è dedicato “ai partigiani caduti per la libertà. Ai soldati della Rsi caduti per l’onore”. Subito si gridò all’inammissibile “parificazione”, alla mancata menzione della “parte giusta” e alla mancata autofustigazione della “parte sbagliata”. Ma Mazzantini non voleva parificare, voleva solo capire. Non giustificare, ma comprendere e farsi comprendere, far comprendere soprattutto cosa avesse mosso in quei giorni amari di fuoco i reietti oramai cacciati in un recinto infatti nell’Italia postfascista. Voleva capire perché Elio Vittorini - uno fra i tanti, squadrista negli anni della presa del potere da parte del fascismo mussoliniano, figura di rilievo nella cultura del regime e la cui “ultima apparizione ufficiale” risaliva alla partecipazione “con i quisling della letteratura nei Paesi occupati dai nazisti” al convegno degli scrittori europei di Weimar nell’ottobre del 1942, presente addirittura il grande regista della propaganda nazista Goebbels - perché dunque uno scrittore così avesse avuto l’ardire di chiamare “figli di stronza” meritevoli di essersi tolti di mezzo, i giovanissimi che, come i tanti Mazzantini, indossarono la divisa sbagliata. In un libro, poi, intitolato “Uomini e no”, che sbandierava il crimine morale e ideologico della “bestalizzazione” del nemico, della sua riduzione e degradazione ad animale spogliato di ogni diritto umano. Come gli “Untermenschen”, i “sottouomini” dei nazisti, denunciava Mazzantini con l’enfasi di un torto subito con tanta spietatezza, che dava diritto e legittimità all’espulsione dei reprobi non solo dal consorzio civile dell’Italia postfascista, ma dalla stessa casa comune dell’umanità.
Passarono quasi quarant’anni, quarant’anni di dolore, di solitudine, di auto-macerazione ma anche di auto-difesa, prima che Mazzantini riuscisse a portare a termine l’opera che gli lavorava dentro sin dai giorni della sua gioventù bruciata: “A cercar la bella morte”.
Quarant’anni di dolore e di solitudine per portare a termine l’opera che gli lavorava dentro sin dai giorni della sua gioventù bruciata
Politicamente era uno senza casa, si era avvicinato ai Radicali di Pannella per il suo spirito libertario e anticonformista. Isolato com’era, fuori dai circuiti editoriali, non sapeva a chi consegnare questo manoscritto costato tanto sudore, e sconsolato si diceva che forse non sarebbe stato mai pubblicato, o forse soltanto “postumo”. Ma la figlia Margaret Mazzantini, al tempo ancora alle prima armi come attrice e poi scrittrice di valore, si fece carico di mandare in giro quelle pagine così scottanti, e tra molti e sconfortanti dinieghi, sordità e incomprensioni, trovò finalmente udienza prima in Guido Davico Bonino e poi in Giordano Bruno Guerri, che decise di pubblicare il libro presso la Mondadori in cui lavorava. Quarant’anni di elaborazione e di attesa: ma alla fine il romanzo di Mazzantini, peraltro mai reticente con gli orrori e la atrocità di parte repubblichina che insanguinarono quegli anni di guerra e di morte e descritte con una puntuale vena cronistica, attirò l’attenzione in un clima culturale paradossalmente migliore di quello dei nostri giorni, sempre più lontani dagli anni del fascismo e della guerra civile eppure mai tanto intossicati da una radicalizzazione iper-semplificata che cancella, con l’anatema e la censura, ogni rilettura critica di quegli anni e la stessa discussione pubblica sulla nostra storia. Quando Mazzantini pubblicò il libro sui cui aveva lavorato nei decenni, in Italia il dibattito culturale sul proprio passato era molto più vivace di quello, mortifero e dottrinario, che avvilisce i nostri giorni con i suoi furori neo-dogmatici. Per la prima volta nella storiografia antifascista il tabù della “guerra civile”, prima monopolio della pubblicistica fascista e neo-fascista, era stato infranto da uno storico di valore come Claudio Pavone. L’appena eletto presidente della Camera Luciano Violante, un passato nel Pci, volle ricordare nel suo discorso di insediamento la storia dei “ragazzi di Salò” raccontata nei testi di Carlo Mazzantini. Scoppiavano furiose polemiche sulle ricerche di Renzo De Felice, certo, ma almeno si discuteva e non si scomunicava: il ghiaccio si stava sciogliendo negli ultimi anni del Novecento per poi riformarsi, rigido e prepotente, nel corso dei primi decenni del Ventunesimo secolo.
Il romanzo di Mazzantini, mai reticente con gli orrori repubblichini, attirò l’attenzione in un clima culturale molto meno dogmatico del nostro
E fece breccia l’autoesame di Mazzantini, spietato con sé stesso ma anche con il tradimento dei chierici più anziani che con il fascismo erano scesi a patti, sulla rivolta generazionale che alimentò quella scelta di andare a Salò. In una condizione d’animo di scoramento e di disorientamento, abbandonati a sé stessi, in possesso solo dei frammenti di ciò che è stato”, quei ragazzi si trovarono a dover compiere il passo fondamentale della loro esistenza: l’uscita dall’adolescenza e l’ingresso nell’età adulta”. “Ma come sottrarci all’onta che ricadeva su tutta la nostra gente? Come manifestare quel nostro rifiuto, quella rivolta? Come dargli nome?”. Si insinua qui il paradosso tragico che farà dei “balilla che andarono a Salò” i capri espiatori delle brutture della dittatura fascista: “Per manifestare la rivolta contro la generazione adulta che aveva ‘osannato impudicamente il fascismo’ per poi volgergli le spalle in quel modo così repentino, e per conservare una continuità di sentimenti con il nostro passato, raccogliemmo i simboli che quelli avevano gettato nella polvere per agitarli rabbiosamente davanti ai loro occhi a sfida e provocazione”: una rivolta che prendeva le forme un po’ allucinate di una “regressione nel passato, in un ripiegamento sul mondo fantastico dell’infanzia”.
Un paradosso che Mazzantini attraversò fino alla sua morte nel 2006. Negli ultimi anni Dino Messina riuscì a riunire attorno a uno stesso tavolo lui, il balilla che era andato a Salò, e Rosario Bentivegna, il partigiano del commando dei Gap che nella Roma occupata dai nazisti, a Via Rasella, fece esplodere la bomba destinata a uccidere 32 soldati del Battaglione Bozen. Fu un incontro difficile, con Mazzantini, carattere tempestoso, che recalcitrava all’idea di interloquire e addirittura dibattere con un ex nemico di tale statura. Ma alla fine Messina ebbe ragione di resistenze e dinieghi e ne scaturì un libro, “C’eravamo tanto odiati” pubblicato da Baldini&Castoldi, che oggi, nell’atmosfera avvelenata e fanatizzata in cui ci tocca vivere, sarebbe quasi impensabile. “Si odia ciò che non si capisce”, ha scritto Mazzantini, “ciò che risveglia oscure paure che con l’odio si cerca di allontanare e di esorcizzare”. La lezione di una vita difficile di un uomo nato esattamente cento anni fa, un’altra èra della storia.