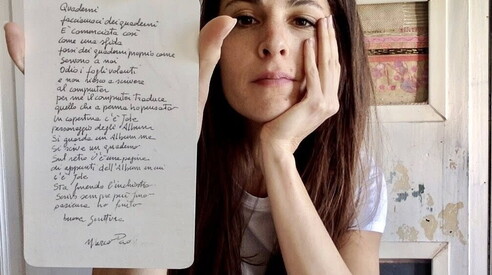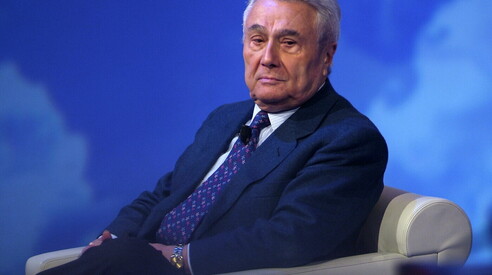
LaPresse
Un libro straordinariamente bello
Fratelli coltelli d'Italia. La genesi del gran romanzo di Arbasino
Torna in libreria la prima versione del 1963, con un saggio di Giovanni Agosti. Tra le varie peculiarità di questo romanzone epocale ora ci sarà anche quella di essere disponibile in due taglie, una diciamo bagaglio a mano e una da stiva. È il "Preghiere esaudite" italiano
Sessantatré, settantasei o novantatré? Non sono i numeri del lotto (da giocare ovviamente sulla ruota di Voghera) ma le edizioni di “Fratelli d’Italia”, il gran romanzo arbasiniano, bibbia per noi adepti. L’arbasinologia è infatti scienza che forse appartiene alla numerologia o alla comparativistica, e se una delle caratteristiche di AA era quella di riscrivere in continuazione molti dei suoi libri, il più importante, appunto “Fratelli d’Italia”, road movie di un gruppo di scapestrati belli e dannati su e giù per l’Italia del boom, “sorge” nel 1963, ma poi viene riscritto nel 76, e infine nel 1993 (c’è anche una versione con cambiamenti “light” nel ‘67). Adesso torna in libreria la prima edizione, quella smilza, di “sole” 532 pagine, pubblicata come l’originale da Feltrinelli (mentre il romanzo poi crebbe fino alle quasi 1.400 della versione Adelphi tuttora in commercio).
Dunque ecco che tra le varie peculiarità di questo romanzone epocale ora ci sarà anche quella di essere disponibile in due taglie, una diciamo bagaglio a mano e una da stiva. Quella Ryanair (del resto il romanzo si apre con un celebre incipit “siamo qui a Fiumicino”) ha i suoi estimatori, mentre altri preferiscono l’intermedia Einaudi del ‘76 e taluni quella con pochissimi cambiamenti del ‘67 ma con copertina azzurra col Vittoriano a pois, di nuovo Feltrinelli. Ma insomma. Adesso torna in libreria la prima, smilza e meno rifinita, con una copertina gialla “lime” come l’originale sebbene non nel design di Albe Steiner, e soprattutto con una lunga postfazione di Giovanni Agosti, arbasinologo di lungo corso, una grande “storia del romanzo”, di questo romanzo, e anche un saggio sociologico su cos’era quell’epoca e quell’Italia lì.
E’, anche e soprattutto, una storia di giovani. Il libro esce che Arbasino ha 33 anni, si è trasferito da poco a Roma, dopo la Voghera della guerra, gli studi deludenti prima di medicina (per essere psicanalista), e poi di giurisprudenza (per essere diplomatico). Prima a Pavia, poi a Milano, tanti amori infelici, e un male di vivere che non dà tregua. Finalmente a Roma (“nato a Voghera, rinato a Roma”, dirà di sé). L’angoscia è la cifra, dietro la maschera dello scrittore-saggista-amuseur plurilingue vestito bene che non riesce a stare nello stesso posto per più di mezz’ora e che poi conobbi anch’io, già anziano. Ma c’è un prima e un dopo Roma. Nella capitale è andato ad abitare all’ ultimo piano in via Mario dei Fiori, all’angolo con via Frattina, in un appartamento appena lasciato da un trio toscano venuto a fare fortuna: il pistoiese Mauro Bolognini e i fiorentini Piero Tosi e Franco Zeffirelli. Chi avvista Arbasino lo descrive come febbrilmente impegnato a muoversi su quel nuovo scacchiere: il 18 agosto 1958 il critico d’arte Marco Valsecchi nota che gli sembra “preda di un’agitazione nervosa, giovanile, che non ti lasciava il tempo di condurre un discorso fino alla fine; qualcosa che assomigliava all’ebrietà, a un’allegrezza incontenibile, che poteva però anche far male”. Roma del resto per AA è stata uno choc culturale, sociale, linguistico, che si innesta evidentemente su un uomo già complicato e stratificato.
Sotto una “Impassibilità del tutto di facciata” aleggia la “tragedia dell’erudizione”, sostiene Agosti. La frase su cui si regge tutto è “Ne cherchez plus mon coeur”, rimando a Baudelaire che, via Adorno, compare in esergo proprio all’edizione ‘76. “Non cercate più il mio cuore, perché le bestie l’hanno mangiato”, di lì una vita in fuga anche sentimentale, e il mascheramento sotto la corazza social-mondana che resterà fino alla fine (ma è una maschera dolorosa, come ha detto Agosti già nel mio documentario “Stile Alberto”, ora su Rai Play, scusate la réclame). A spiegarlo meglio di tutti è Pasolini, amico, consigliere, rivale di AA, che ne dà la definizione chirurgicamente più giusta: Arbasino “per qualche accidente ch’io non so, ha avuto amputati alcuni sentimenti, e ora se ne va per il mondo sempre allegro come un moncherino o un cane cieco”. Pasolini che pure l’aveva “lanciato”, con le sue poesie (perché Arbasino nasce poeta), il 22 giugno 1956 gli scrive una tremenda lettera, in cui sostiene che in lui c’è una “illusione culturale, il cui aspetto più immediato è la fiducia nel valore assoluto della citazione”. Qualcosa di simile gli scrive anche Roberto Longhi, “il più grande stilista italiano”, per Arba, storico dell’arte col dono della prosa e altro mentore di AA. “Caro Arbasino, Lei può vedere il gran conto che noi facciamo del suo ingegno, della sua capacità mimetica (Lei deve avere dei quartetti poetici in microsolco sempre a disposizione), ma si ha l’impressione ch’Ella curi un po’ troppo l’organizzazione di se stesso. Si lasci andare un po’ più, diventi un po’ più rozzo, più paesano, più italiano”. Nessuno verrà ascoltato. AA non rinuncia al brivido cosmopolita, alla furia della citazione. Al fregolismo su e giù per l’Europa e l’America, tra la via Emilia (centrale a Voghera) e il West.
Dopo la raccolta di racconti “Le piccole Vacanze”, il romanzo epistolare “L’Anonimo Lombardo”, e le raccolte di reportage da Londra e Parigi in gran parte uscite sul Mondo, è ora del gran romanzo. Ed ecco dunque che si mette lì a fare i suoi “Fratelli”. Ma man mano che si avvicina l’uscita, cresce l’ansia, montano i gossip, si impennano i risentimenti. Arbasino fa leggere una prima bozza agli amici, ma la bozza circola in città, e non piace per niente. Non piace quella grande commedia umana, quella Recherche nel mondo della nobiltà, degli scrittori, dei giornalisti, in cui tutti si ritrovano. Tutti sembrano disinteressati al capolavoro “in the making”, a quella festa mobile di una borghesia frullata dal boom, che Arbasino racconta trovando soprattutto una lingua unica costruita sul parlato (l’autoradio di una Jaguar ben temperata), con riferimenti esatti di tutti i tic e le marche dei prodotti di consumo, precisa fin nelle canzonette, mentre l’Italia è concentrata sulla critica e l’autocritica a Marx e i suoi derivati. A Bassani, inizialmente alleato, non dà fastidio solo la riconoscibilità dei personaggi, ma anche il fatto che sia un “romanzo saggio”, alla Proust, alla Musil. Altra pecca, la mescolanza tra tragico e comico (che è poi alla base della grande commedia all’italiana, il vero great italian novel); del resto l’anno prima esce “il Sorpasso”, con Gassman a bordo di una Lancia Aurelia B24,mentre in “Fratelli” il protagonista ha una Mg azzurra “come i miei bei occhi”. E se nel finale al cinema Trintignant finisce giù da una scarpata, nei “Fratelli” si chiude pure in tragedia (quanti suicidi, e funerali).
Ma il più incavolato è Moravia. Bisogna pensare che Moravia in quegli anni è già il capo del complesso industrial-militare-letterario italiano. Ed è un altro alleato, inizialmente. E’, nella genealogia coniata dallo scrittore vogherese, un padre (insieme a Soldati e Brancati), mentre gli zii si sa che sono Gadda e Palazzeschi e Comisso, scrive Agosti (e Longhi?), i maestri supremi (da cui i nipotini, Arbasino, Testori e Pasolini, secondo la teoria che la letteratura si muove non in linea retta ma con la mossa del cavallo).
Moravia diventa il grande accusatore che cerca di boicottare in tutti i modi l’uscita del romanzo: scrive una micidiale lettera a Bassani, che è il capo della collana “Biblioteca di letteratura” della Feltrinelli (anche lui amico di Arbasino). Scrive Moravia a Bassani: “Il fatto di parlare di certe cose rivela un’indiscrezione morbosa e disumana. Ma il modo è semplicemente orrendo, specie se si pensa che Arbasino si considera ed era da noi considerato un amico”. Il fatto morboso che Arbasino mette nel romanzo, cambiando i nomi e la situazione, è un dramma che ha colpito la coppia Moravia-Elsa Morante: il suicidio del giovanissimo amante di lei (che nel romanzo si chiama Francesca Sanquirico), il ventottenne Bill Morrow, pittore americano conosciuto a New York nel 1959, di cui si era perdutamente innamorata (e di cui un quadro finirà, nel 1968, sulla copertina del Mondo salvato dai ragazzini) e non omette che nello stesso frangente il marito di Elsa è a Parigi, “con la Luciana”, alias Dacia Maraini”. Moravia è furibondo e consiglia minacciosamente a Bassani che il romanzo non s’ha da pubblicare. “Mi sembra un libro nel quale il pettegolezzo rasenta la diffamazione e l’incoscienza la criminalità. Ti prego di riflettere bene a quello che fai pubblicando questo libro. Io so che tu sei una persona che non prende mai leggermente le cose della vita. Ebbene ti invito a farlo anche questa volta!”.
Bassani capisce il messaggio, e si rivolge immediatamente a Giangiacomo Feltrinelli - lo dicevo che era una storia di giovani - che a 28 anni ha tradotto le immani ricchezze della famiglia (nate con le traversine per le ferrovie dell’impero austroungarico) nella casa editrice. Giangiacomo tiene botta. Si troverà una soluzione diplomatica, cambiare collana, non più quella diretta dal ferrarese ma un’altra (che tempi, signora mia, avrebbe detto AA, quando “cambiare collana” di una casa editrice era un caso nazionale. Pensiamo sempre che nel ‘63 escono i “Fratelli d’Italia”, e al cinema “Il Gattopardo” e “8 e mezzo”. E’, quello di quegli anni, un mondo con “valori che non coincidono con quelli odierni”, scrive Agosti: “dall’importanza dei giornali alla centralità del cinema, fino all’imprevedibilità degli incontri in un mondo privo del tutto di profilature, in un’epoca dove mancavano le liberatorie da firmare e la modulistica da compilare e le piattaforme a cui accedere e i bandi a cui partecipare: e quindi le idee potevano facilmente diventare opere”.
Comunque, la rottura con Bassani è definitiva: minaccia e poi presenta le dimissioni dalla rivista “Paragone”, visto che Arbasino non ne è stato cacciato come suo desiderio. Lo chiama “piccolo falsario”, e a Feltrinelli: più che un editore stai diventando un cacciatore di scandali. Il young Feltrinelli risponde per le rime: “Questo libro è un prodotto di questa società, né meglio né peggio di essa: nel libro di Arbasino una certa società si è, forse per la prima volta, vista nello specchio. Capisco la sorpresa, mi sorprende l’indignazione che sa di malafede. Ciascuno è quello che vuole essere, e perché vergognarsi di quello che si è e di chi si vuole essere?”. C’è un’altra questione segnalata da Moravia. “La Domietta Hercolani ieri mi ha telefonato dicendomi che doveva parlarmi”. “Mi ha detto che Alberto Arbasino giorni addietro le aveva mandato il manoscritto del suo romanzo. Lei aveva letto il manoscritto e aveva scoperto che il personaggio principale, Desideria, era lei stessa e che Arbasino aveva messo in piazza nel suo romanzo lei e i fatti suoi e la sua vita e le persone della sua vita. La Domietta era indignata oltre ogni dire e parlava di fare bastonare Arbasino e di cacciarlo in galera. D’altra parte era addolorata, moltissimo, perché si era affezionata ad Arbasino, l’aveva accolto in casa sua, gli aveva presentato i suoi amici, l’aveva accarezzato in mille modi. Mi disse che perfino aveva pianto dopo aver letto il libro”.
Allora. “La Domietta” è Domietta Hercolani del Drago, principessona-musa di Arbasino che Alberto mette tutta intera nel romanzo, cambiandole nome appunto in Desideria, una nobildonna colta e chic e ricchissima, insomma tutto ciò che non sono generalmente le nobildonne romane. Molto infelice, naturalmente, perché nel romanzo sono tutti infelici, e finiscono tutti malissimo. “Un altro aspetto del romanzo è quello di essere sinistro e festoso insieme, frenetico e disordinato, tragico e farsesco. I miei personaggi discutono, parlano, corrono, si divertono, mangiano nel modo migliore, ma... finiranno tragicamente, in conclusione la sconteranno tutti” mette in chiaro Arbasino prima che il libro esca.
Ma la questione “della Domietta” serve anche a dare una lettura diversa di un tormentone (parola peraltro inventata da Arbasino) tipicamente arbasiniano, quello sugli scrittori rovinati dal pettegolezzo e uccisi-dalla-propria opera, una categoria di cui bisognerebbe tenere il santino sul comodino, dall’Henry James dei “Bostonians”, al Fitzgerald del “This Side of Paradise”, fino al maestro di tutti i geniali sputtanatori sputtanati, il Truman Capote che dopo “Preghiere esaudite” finisce abbandonato e solo. Arbasino si è sempre beffato di quel suo lontano omologo, lo scrittore gay piccoletto che frequenta le classi alte un po' per il piacere di, un po' sapendo già che le metterà poi in una grande opera (“cosa credevano, che fossi lì per divertirli?”, la dichiarazione di intenti dell’americano). Arbasino Capote lo elegge a suo punching ball in vari episodi (dai racconti che lo vedevano in spiagge californiane invecchiato e brutto e con “una palla fuori dallo slip", alla vecchia macchietta, allo sbafatore a corte dei padroni anche italiani. Tra cui vacanze insieme a ruota della real casa Agnelli, in Spagna, dove Arbasino raccontava con crudele sufficienza il ménage piccoloborghese di Capote e di un suo fidanzato. Fino alla sontuosamente isterica introduzione al meridiano su Capote, dove Arbasino ricorda il Capote in visita a Roma con la moglie dello sceriffo che l’aveva aiutato per il caso di “A sangue freddo”, e lo scrittore e la sceriffessa venivano sfottuti come “Trummy and Mommy” per il loro provincialismo yankee. Però alla luce di queste ricerche si capisce un po’ meglio l’isterismo di Alberto: che proietta sul povero Capote tutta l'angoscia dell’emarginazione rischiata e sfiorata in proprio.
Arbasino non era nato a New Orleans ma nell’Oltrepò pavese, non era figlio di una mamma alcolizzata bensì di una stimata famiglia di farmacisti e avvocati, ma anche lui era passato dalle sue “Preghiere esaudite”, anche se non a Central Park ma a Voghera (già con un piccolo scandalo giovanile per una famiglia locale offesa da una satira goliardica, e conseguente denuncia); o sull’Appia Antica (con magari il Bolognese al posto della Côte Basque). C’erano anche dei cigni in coabitazione, tra i due, come Marella Agnelli, notoriamente “exposed” da Capote, ma in piccola misura, rispetto alle note altre (Babe Paley, che non gli rivolgerà mai più la parola come abbiamo visto nelle note serie tv americane del settore). Ma se Marella non perdonerà mai Capote, Domietta del Drago (rivale in amore di Marella, tra l’altro, per l'Avvocato) rimarrà invece amica di Alberto fino alla fine (e qui, arbasinamente, quante colazioni abbiamo fatto, a Pasqua, con Alberto e Domietta, ma si vede tutto nel doc). Che poi. I cigni romani sono più buoni di quelli americani? Sarà l’aria? Boh. Man mano che il romanzo sta per uscire, comunque, crescono le maldicenze, a destra a sinistra al centro.
Il “Meridiano d’Italia”, giornale vicino al Msi: “L’inchiesta di Arbasino” riguarda, tra gli altri, Guttuso, Seroni, Visconti; per non parlare di Pasolini. Non uscirà un libro che sarebbe stato una vera e propria ghiottoneria scandalistica. Lo ha impedito la “censura” che funziona in casa comunista. Si tratta di un volume (…) in cui si svelano gli intrighi, i vizi, le relazioni più o meno lecite, le inversioni non soltanto morali (...). L’Arbasino ha consegnato il manoscritto all’editore Feltrinelli; ma poiché Feltrinelli è legato al Partito comunista (…) l’imprimatur non è stato concesso”. Vabbè. Addirittura il libro è considerato una “inchiesta”. Andrea Barbato scrive un pezzo sull’Espresso intitolato “Ci siamo dentro tutti”. Moravia sul Corriere uno stranissimo articolo, “Il macabro in salotto”, dove tratteggia, pur senza farne il nome (anzi chiamandolo “Zani”), un ritratto di Arbasino, a partire da una descrizione della sua casa (siamo in quella successiva, a via del Consolato, paragonata a “una maschera mortuaria. Lo scopo non è di esprimersi, bensì di nascondersi”.
Arbasino cerca di esorcizzare tutta questa pressione (e diciamo pure tutti questi jettatori) annunciando un lungo viaggio in California, un po’ come quando, mi viene in mente, Philip Roth parte per la lunga crociera coincidente con l’uscita in libreria del “Lamento di Portnoy”. Ma Arbasino, a differenza di Roth, non si porta i genitori. Roth ricordava che li aveva appunto imbarcati perché non risentissero dello scandalo, ma il padre praticone invece prima di salpare si era dotato di un cospicuo numero di volumi, che rivendeva a bordo con la dedica, “dal padre dello scrittore”.
Alla fine il libro esce. Si intitola “Fratelli d’Italia”, cassate le alternative di “Le italiche fatiche”; “Le mura e gli archi”; “Le piaghe mortali”. Finito di stampare a maggio, arriva in libreria il 5 giugno 1963; costa 3000 lire; è il numero 24 della serie “I Narratori. Collana di grandi autori moderni di tutto il mondo” inaugurati dal “Dottor Zivago”. Anche se il mondo qui è Voghera. Vende poco, 4701 copie il primo anno (oggi sarebbe un successo, ma all’epoca un libro di medio successo ne vendeva centomila). Cessano le polemiche, arrivano le stroncature feroci, anche, oggi diremmo, decisamente omofobe: “leziosaggine del terzo sesso”; “narcisismo efebistico”, “trito fertilizzante dell’inversione”, “un balletto di invertiti e di pervertiti”, “un balletto ambiguo e viscido, come di amebe in un acquario o di serpi sotto la luna (...); (certe corse in automobile sportiva soltanto per andare a insidiare un gruppo di marinai, per oltraggiare l’amore in un boschetto o in un albergo...)”; “molte di codeste pagine ci sembrano marce per senilità, per quell’impotenza tipica degli esibizionisti e degli omosessuali che non riescono mai ad aggredire la vita, la insidiano e la corrompono soltanto, restando a far da voyeurs dal buco di una serratura questa volta libresca”. Mortacci.
Tra i pochi giudizi positivi, Giuliano Gramigna, l’alleato di sempre Pietrino Bianchi, e il solito Pasolini: considero Fratelli d’Italia un libro straordinariamente bello, che naturalmente gli asini in doppiopetto della critica italiana non hanno preso in considerazione – terrorizzati”. Questa volta aveva proprio ragione.


Non è una "magica favola"
Il soggiorno sanremese di Čajkovskij dove nacquero la Quarta Sinfonia ed Evgenij Onegin