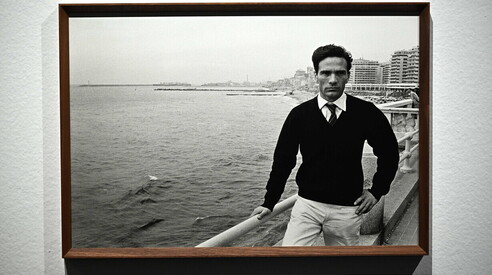FACCE DISPARI
Laura Ballestra: “Le biblioteche sono uno strumento di felicità”
Non più solo custode di libri, ma figura sociale e guida nella ricerca di qualità: per la presidente dell’Aib, la biblioteca resta uno dei pochi spazi non orientati al consumo, dove la lettura crea relazioni e benessere. Intervista
Pierre Bayle sognava di fare il bibliotecario per disporre di tutti i libri che voleva e del tempo per studiarli. Bibliotecari furono per un periodo più o meno lungo Leibniz, Hume, Borges. Eppure non è, o non è più, un lavoro da erudito puro. Se vi aspiri devi essere estroverso, manageriale, partecipe della comunità che viene a leggere. Lo sottolinea Laura Ballestra, presidente dal 2023 dell’Aib, l’Associazione italiana biblioteche, direttrice della biblioteca dell’Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza e docente di Biblioteconomia.
La socievolezza è un requisito indispensabile per un bibliotecario?
Senza dubbio. Nell’immaginario collettivo la nostra figura non è sempre rappresentata nel modo più corretto. L’erudizione è necessaria perché occorre una professionalità elevata, ma lo è anche l’attenzione per la comunità di riferimento. Ci vuole spiccata capacità relazionale perché si è costantemente a contatto con gli utenti e occorre una certa vocazione ad aiutare chi cerca informazioni per indirizzarlo verso scelte di qualità. La information literacy svolge un compito tanto più importante quanto più diventa vasta l’offerta. Il bibliotecario deve portare il lettore a comprendere le differenze che ci sono tra cento libri che trattano lo stesso argomento, perché il rischio è che contenuti di livello più basso si confondano con quelli prodotti da importanti voci autoriali.
Qual è oggi la parola chiave per una biblioteca?
La lettura. Anche se il nostro è diventato un lavoro polifunzionale, la centralità è sempre sulle politiche di lettura, che si traducono in una crescita culturale e sociale. Non è retorica: la frequentazione delle biblioteche è un indicatore di benessere, perché favorisce le relazioni e la partecipazione umana. Le biblioteche, soprattutto nei piccoli Comuni, ospitano eventi e organizzano attività, ciascuna con un’anima e con servizi tarati sui bisogni locali.
Dice che chi va in biblioteca è più felice?
Proprio così. Non è soltanto un luogo per la lettura individuale. Basti pensare ai social reading o ai book club che ospitiamo. Chi frequenta le biblioteche costruisce più relazioni. Senza contare il senso di libertà che si prova, sia nelle biblioteche civiche sia in quelle di maggiori dimensioni, per lo “scaffale aperto” da cui si possono attingere i testi senza intermediazione. Siamo in un posto di non consumo: chi entra non è trattato da consumatore e fruisce di un servizio gratuito. Luoghi così sono davvero pochi.
Non sottraete acquirenti al mercato librario?
Al contrario, c’è una correlazione positiva perché è dimostrato che il lettore di biblioteca compra più libri. L’Aib intrattiene un dialogo costante con la filiera editoriale. Non siamo in concorrenza, ma lavoriamo per un obiettivo comune.
Amazon vi ruba pubblico?
Grazie alle nostre reti e alla politica di acquisti coordinata, se una biblioteca manca di un testo può chiederlo a un’altra per procurarselo. Ci sono anche circuiti cittadini in cui le biblioteche pubbliche fanno scambi con quelle universitarie. Certamente il pulmino di Amazon per tempestività batte i nostri, ma l’urgenza non è prioritaria per la generalità dei lettori.
È sufficiente il numero delle biblioteche pubbliche italiane?
Sono circa 7.500 con una notevole disparità distributiva: il 60 per cento è concentrato al Nord, soltanto il 13 al Centro e il 27 al Sud, anche se le cifre vanno interpretate tenendo conto della maggiore o minore popolosità di alcuni territori. Certamente c’è una disparità nei tassi di fruizione: si va dal 30 per cento di Bolzano al 20 della Lombardia e al 6 per cento in Campania. Per le biblioteche scolastiche invece la geografia è a macchia di leopardo: ci sono istituti che fanno rete con le strutture civiche, altri con un patrimonio fermo agli anni Ottanta dove la gestione è demandata a più docenti a rotazione e manca una figura di riferimento stabile, scoraggiando la fruizione degli studenti. È un doppio peccato perché la lettura non è un processo naturale ma va allenata, altrimenti si rischia di non recuperarla più e di perdere la capacità di concentrazione. Inghiottiti dagli smartphone.
Perché scelse questo lavoro?
Scoprii la biblioteconomia quando ero all’università e mi appassionai, ma ero già stata assidua frequentatrice di biblioteca alle scuole medie. Quando cominciai a lavorare capii l’importanza degli aspetti gestionali e di management, per cui presi una seconda laurea in economia aziendale.
Come hanno influito gli sviluppi tecnologici?
Le biblioteche hanno mostrato da subito la capacità di aggiornarsi, ma la velocità dei cambiamenti è aumentata. Dobbiamo abbracciare le innovazioni però con spirito critico, ossia distinguendo i mutamenti reali dalle mode passeggere della tecnologia.
Qualche emozione da bibliotecaria?
Un senso sottovalutato ma potente è l’olfatto: amo il profumo dei libri. Mi emoziona camminare quotidianamente tra gli scaffali e constatare la quantità di volumi attinenti a qualunque microdisciplina. Acquisiamo tanti testi in digitale ma sono i metri lineari di scaffali che nella loro dimensione fisica ti rendono l’idea della seguente verità: ogni area della conoscenza è sempre più profonda di quanto avresti potuto immaginare.

il miglior libro del mondo