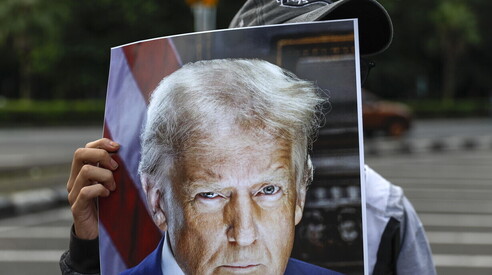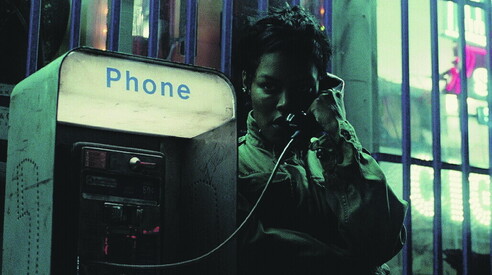Foto Ansa
Magazine
Borges filosofico. Così lo scrittore è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico
Con il tempo le figure culturali cambiano volto: oggi l'autore è sempre più celebrato come filosofo capace di diagnosticare il presente, anticipando con le sue visioni temi del nostro tempo, dall’AI al labirinto dell’informazione
Accade col tempo che la natura di una figura cambi in base alle necessità che ha il mondo in quel momento. Isaac Newton, ad esempio, che giocava con l’occulto, era ossessionato dall’interpretazione dell’apocalisse ed era considerato nella sua epoca un abile alchimista. Oggi invece esiste solamente come illuminato scienziato, come un prometeo del Lincolnshire che ci ha donato la teoria della gravità, come un’icona per gli studenti Stem. Quasi nessuno nella nostra epoca ricorda Franz Kafka e Victor Hugo come disegnatori, o le avventure imprenditoriali in Sardegna di Balzac. Magari tra qualche decennio si dimenticherà il Processo e si parlerà solo del Kafka con matita e carboncino, con qualche operazione di recupero postumo stile Caravaggio. Werner Herzog ha detto che verrà ricordato per i suoi libri e non per i suoi film. Complici gli hipster americani, abbiamo visto nell’ultimo decennio Italo Calvino perdere la sua caratteristica principale di romanziere e narratore – giusto qualche prof delle medie fan di legge Michele Serra consiglia ancora Il cavaliere inesistente – mentre la sua opera saggistica e critica è entrata nel discorso comune, con tanto di meme da “buongiornissimo caffè” con le frasi sulla “leggerezza”. Le città invisibili è diventato breviario camaleontico per archistar, registi e assessori all’urbanistica, le sue frasi citate nei convegni e nei pamphlet sui boschi verticali del futuro e nelle newsletter corporate-buoniste.
Con processi simili negli ultimi anni uno scrittore e critico argentino è diventato a suo modo qualcos’altro. Jorge Luis Borges ha perso il distintivo di semplice scrittore e critico ed è diventato filosofo. E se spesso queste metamorfosi postume fanno perdere lo smalto al genio, qui invece la celebrazione di Borges come pensatore più che prosatore sembra una buona notizia, anche per la Letteratura (quella vera, quella di Walser e Baudelaire). Intendiamo filosofo non con il cartellino che ci si può appiccicare nel sottopancia televisivo, dalla Gruber o in una quarta di copertina di un pamphlet sulla “mia estate leggendo Pascal”. Proviamo a intendere filosofo usando la definizione di Michel Foucault, e quindi come una persona in grado di “diagnosticare il presente di una cultura”. Borges l’ha fatto anche col passato, ma oggi ci stiamo accorgendo che lo sta facendo col nostro presente, anche se lui è morto nel 1986. E non è un caso che in questi mesi se si va ad ascoltare un pensatore come Slavoj Zizek parlare – ad esempio al Berggruen Institute alla Giudecca – ci si ritrova a sentir parlare delle idee di Borges, delle sue illuminazioni sul pensiero, e non delle sue storie, che comunque assomigliano più a parabole o a dialoghi platonici. “Il filosofo non ha ruolo nella società”, diceva Foucault. “Socrate ne è un eccellente esempio: la società ateniese non ha saputo riconoscergli che un ruolo sovversivo, il suo mettere in questione le cose non poteva essere ammesso dall’ordine costituito. In realtà, è dopo un certo numero di anni che si prende coscienza del posto di un filosofo, insomma gli si assegna un ruolo retrospettivamente”. Anche nell’ultimo caso interessante di uso editoriale dell’intelligenza artificiale, “c’è un po’ di Borges”, come titolerebbe un quotidiano di provincia. Stiamo parlando del libro scritto in gran parte con l’AI dal pensatore fittizio Jianwei Xun, Ipnocrazia, edito da Tlon e finito sulla copertina dell’Espresso.
Quest’operazione, considerata da alcuni truffaldina e da altri brillante, era stata messa su da Andrea Colamedici, che ha detto di aver messo dentro il libro “un pezzo riscritto di Hegel, che in realtà è una reinterpretazione che passa da Marx; ho messo dentro un pezzo di Borges; ho lasciato tracce divertenti. Come un finto esperimento”. Ecco, l’argentino usato come Hegel o come Marx. La stessa casa editrice di Colamedici, Tlon, deve il nome al racconto Tlön, Uqbar, Orbis Tertius dove avviene una progressiva sostituzione del reale con l’artificiale. Colamedici sull’Unità aveva invitato tutti ad “agire come se, nel tessuto letterario di Jorge Luis Borges e in particolare nella raccolta di racconti Finzioni, labirinti intricati, specchi riflettenti e biblioteche senza fine, non siano metafore poetiche ma vere e proprie visioni profetiche del nostro tempo, capaci di offrire riflessioni puntuali e tremende sullo stato della conoscenza umana nell’anno 1 d.C, ossia dopo ChatGPT”. Se, come ci sta insegnando l’elezione di Leone XIV serve una Rerum Novarum per questa nuova era del tech, per l’epoca del machine learning, serve qualcuno da usare come profeta a posteriori, come guida per questo algoritmico presente.
Il ripescaggio di Borges è forse anche una rivincita per un certo conservatorismo o una certa posizione politica liberale. Oggi il suo nome, insieme a quello di Philip Roth (vittima invece, si dice, dell’ondata #metoo e di un certo anti-patriarcato), è tra quelli citati sui Nobel mancati ma meritati. “E’ una vecchia tradizione scandinava: mi candidano per il premio e lo danno a qualcun altro, e questo è una specie di rito”, diceva Borges nel 1979. E, sono d’accordo vari critici, a lui non era stato dato proprio per le simpatie a destra. Per qualche commento di accoglienza verso il regime di Videla, poi ritrattato, o una presunta stretta di mano con Pinochet quando fu invitato in Cile dall’università. “Le persone sono molto cattive, perché quando qualcuno di rango riceve un dottorato, è previsto dal protocollo che assista anche il presidente del paese”, lo difendeva la sua vedova sicura che si trattasse di un problema politico. Problema nascosto dai detrattori dal suo essere poco accessibile nei suoi scritti. Non il realismo magico di Macondo, ma saggi su Dante e miti greci. Leggiamo nei verbali che escono fuori a distanza di cinquant’anni che un membro dell’accademia svedese, votante, disse: “è troppo esclusivo o artificiale nella sua geniale arte in miniatura”. In questi giorni è uscito per Medhelan un bel libro dimenticato, Borges in controluce (traduzione di F. Coppola), dove possiamo vedere il lato privato, e quindi anche politico, di JLB, raccontato dall’amata donna a cui ha dedicato L’Aleph.
L’argentino è filosofo nel senso della definizione di Foucault, una persona in grado di “diagnosticare il presente di una cultura”
Nella sua ormai famosa lista Gli scrittori? Tutti di destra, Giovanni Raboni, poeta e miglior traduttore di Proust, inserisce Borges tra T.S. Eliot, Gadda e Céline. Dice l’argentino in un’intervista, parlando della sua infanzia nel quartiere Palermo di Buenos Aires: “Dare del vigliacco a qualcuno era il peggiore degli insulti. Ero ancora un ragazzino quando mio padre mi mise in mano un pugnale e mi insegnò a usarlo e a farmi rispettare a dispetto dei problemi che avevo con la vista e di un aspetto non proprio da gladiatore”. Condannò i fascismi che provavano a insediarsi in sud America, ma allo stesso tempo aveva paura che, nel dopoguerra, le mode politiche progressiste potessero trasformarla in una parodia europea.
Liberale per alcuni, nazionalista per altri, o forse entrambe le cose. Sicuramente individualista. Ma le etichette non bastano
Liberale, dicono alcuni, nazionalista, dicono altri, o forse entrambe le cose. Sicuramente individualista, come devono esserlo i grandi lettori. Forse come provocazione o forse vedendola come unica soluzione al secolarismo socialista, si augurò che nascesse nella sua terra una dittatura illuminata. Ma è sempre impossibile riuscire a usare le stantie etichette per le menti brillanti di un secolo complesso come il Novecento. Fu un Nobel come Mario Vargas Llosa – scrittore che addirittura si candidò alla presidenza del suo Perù, arrivando in testa al primo turno – a descrivere Borges, secondo lui rappresentante perfetto di ciò che Sartre gli aveva, nei suoi anni giovanili marxisti, insegnato a odiare. Borges era “l’artista evaso dal suo mondo e dall’attualità in un universo intellettuale di erudizione e di fantasia, lo scrittore sprezzante della politica, della storia e anche della realtà, che esibiva senza pudore il suo scetticismo, l’intellettuale che non solo si permetteva di ironizzare sui dogmi e sulle utopie della sinistra, ma che portava la sua iconoclastia fino all’estremo di affiliarsi al Partito conservatore con l’insolente argomentazione che i signori scelgono di preferenza le cause perse”.
Per capire perché Borges oggi è filosofo non serve nemmeno andare a riprendersi gli scenari allucinatori della Biblioteca di Babele o della Casa di Asterione, dove al confronto le estremizzazioni di Black Mirror sembrano esercizi da laboratorio. E’ sufficiente invece prendere in mano il volume La mappa segreta, uscito quest’anno per Adelphi (a cura di Tommaso Scarano), che raccoglie i testi ritrovati, dagli anni trenta agli anni ottanta, dell’argentino. Non è un caso che da qualche decennio sia Adelphi a essersi presa l’onore e l’onere di condividere l’opera borgesiana, che così bene risuona nell’immaginario del Calasso navigatore di labirinti. E’ una vittoria della letteratura, che quando è ad altissimi livelli, può arrivare al rango di “amore per la sapienza”. Dopotutto non è forse Nietzsche uno dei migliori prosatori del suo secolo? Cos’ha da invidiare Così parlò Zarathustra alla migliore poesia del suo tempo? La filosofia come letteratura, o la letteratura come filosofia. Nella mappa segreta leggiamo di Shakespeare, di Whitman, di De Quincey, ma sono tutte porte per capire il funzionamento del mondo, della mente e di quello che va oltre la comprensione della mente. E spesso lo strumento della citazione – altro coltellino svizzero usato con maestria anche da Calasso – diventa un gradino verso la verità. “Schopenhauer ha scritto che non esiste circostanza della nostra vita che non sia volontaria”, scrive Borges in un saggio su Poe. Il pantheon resiste alle mode, è un tentativo mutabile di canone, che non dimentica mai il Don Chisciotte o i celti e cerca Platone nell’Ulisse di Joyce. Il pantheon è sacro, e allo stesso tempo si smonta, tanto da arrivare a dire che alcune traduzioni sono meglio dell’opera originale. Si riesce a essere insieme conservatori e innovatori. Non è un caso che Le parole e le cose, opera fortunata di Foucault, si apra con un passo di Borges.
“Ho consacrato la mia vita alla letteratura, e non sono sicuro di conoscerla; non mi azzarderei a darne una definizione”
Come un Socrate borghese, l’argentino metteva sempre davanti alle proprie verità il suo “so di non sapere” dichiarando: “Ho consacrato la mia vita alla letteratura, e non sono sicuro di conoscerla; non mi azzarderei a darne una definizione, perché per me rimane sempre segreta e mutevole, in ogni riga che ricevo o che scrivo”. E così facendo lanciava anche qualche affondo ai filosofi di professione, che invece sono spesso allergici alla mutevolezza, dicendo “nei testi di estetica, ho avuto la sgradevole impressione di leggere le opere di astronomi che non avessero mai osservato le stelle”. Borges era di fondo un lettore, come ci ricorda una delle sue frasi stampate sulle tote bag, un uomo che leggeva la divina commedia in tram, che amava l’Inghilterra, che aveva incontrato Bergoglio ben prima che arrivasse a Roma. Borges non aveva paura a lanciarsi – lo vediamo nella Mappa segreta – in frasi apodittiche come “ciò che caratterizza un’epoca non si trova mai in essa; si trova nei tratti che la caratterizzano dall’epoca successiva”. Oppure: “per l’immaginazione britannica nessuna tra le azioni umane è tanto interessante quanto l’assassinio”. E ancora: “La fama è sempre una semplificazione e a volte una perversione della realtà: non c’è uomo celebre che non sia un po’ calunniato dalla propria fama”.
La divertente teoria cospirazionista su un Borges fasullo, notizia che sta “nell’ordine delle invenzioni di Borges” secondo Sciascia
E a quest’ultima massima ci si può collegare alla divertente teoria cospirazionista secondo cui Borges non sia mai esistito, ma fosse una semplice invenzione di collettivo di burloni. A svelare la pseudo notizia fu all’inizio degli anni ottanta una rivista catto-xenofobo-nazionalista che raccontò di come alcuni scrittori argentini – tra cui il miglior amico di Borges, Adolfo Bioy Casares – avessero preso un attorucolo uruguaiano di origine italiana, tale Aquiles Scatamacchia, per impersonare l’autore dell’Aleph. Leonardo Sciascia, quando lesse di questa storia, commentò così: “la notizia dell’inesistenza di Borges è una invenzione che sta nell’ordine delle invenzioni di Borges, un portato e un complemento dell’universo borgesiano, il punto e la saldatura della circolarità borgesiana, del sistema. E a qualcuno potrebbe anche venire il sospetto che l’invenzione dell’inesistenza di Borges possa avere avuto come autore lo stesso Borges: una specie di scorciatoia da lui escogitata per raggiungere in anticipo l’inesistenza”. E infatti anche dell’esistenza dello stesso Socrate ancora si dibatte, invenzione di Platone o vero sapiente che vagava per l’Acropoli invitando gli altri a conoscere loro stessi?
Il ruolo di un Borges filosofo ci riporta a un tempo antico in cui il filosofo era colui che cercava la verità. Il tempo di Talete di Mileto e di Biante di Priene. L’epoca delle iniziazioni e di quando sacrificio voleva davvero dire qualcosa. “Bisogna praticare la filosofia fino al punto che gli strateghi ci sembrino asini”, diceva un altro saggio greco presocratico, chiudendo forse, il tema “politico” intorno all’argentino. Qualche tempo fa sulle pagine di questo giornale, che si è divertito a usare le nuove tecnologie per testare lettori e firme, l’intelligenza artificiale ha intervistato Borges, o quello che rimane di Borges nel labirinto della grande rete neurale artificiale. In questa conversazione immaginaria, che trasforma l’algoritmo in un Manganelli 2.0, alla domanda “qual è il suo timore più grande, di fronte a tutto questo”, il cyborg-Borges ha risposto: “Che il labirinto diventi una gabbia. Che la vostra AI diventi un’enciclopedia senza domande. Che smettiate di perdervi. ‘L’inferno, per me, non è la sofferenza: è l’ordine’”.