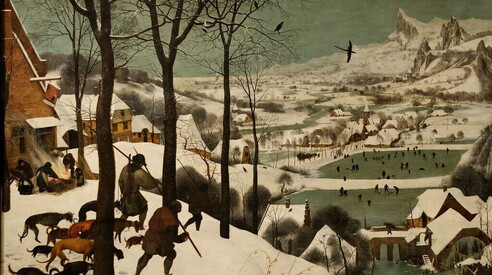intervista
I libri e le riviste di un formidabile idealista. Parla Dave Eggers
Scrive romanzi, a partire da un magnifico memoir, saggi e sceneggiature. Editore appassionato, ha avviato anche attività filantropiche. Internet, l’intelligenza artificiale e il ruolo della cultura
E’difficile riassumere in un’unica definizione l’attività e la personalità di Dave Eggers, come è difficile identificarne le radici in un luogo preciso del grande paese: è nato nel 1970 a Boston, nel Massachusetts, ha vissuto sino al 1991 a Lake Forrest, nell’Illinois, prima di trasferirsi a Berkeley, dove vive tuttora. Si è spostato quindi sempre verso occidente ed è quest’ultimo approdo californiano a caratterizzarne maggiormente il modo in cui si presenta: sereno, sorridente e assolutamente informale. La curiosità che dimostra nei confronti di chiunque rivela una sincera apertura del suo sguardo sul mondo, e credo che sarebbe felice di sentirsi definire in primo luogo come americano. Intendiamoci, è un critico severo, e a volte spietato delle storture e delle ingiustizie della società statunitense, ma ama profondamente il proprio paese ed è convinto che la promessa americana sia antitetica a ogni forma di insularità e isolazionismo.
Scrive romanzi, saggi, articoli giornalistici e sceneggiature, e ha fondato riviste letterarie di culto quali Might, Timothy McSweeney Quarterly Concern e 826 Valencia. Per il cinema ha scritto il copione di Nel paese delle creature selvagge di Maurice Sendak e ha seguito l’adattamento di alcuni suoi testi, lavorando fianco a fianco con autori diversi quali Spike Jonze, Sam Mendes, Tom Twicker e Gus Van Sant. Il cinema è molto più che una passione: nell’intervista realizzata per il Criterion Channel a Joel ed Ethan Coen, emerge, oltre a un’impeccabile competenza, la voglia di apprendere e di interrogarsi sulle diverse forme di espressione artistica.
Parallelamente all’impegno di editore – anche in questo ruolo è in egual misura severo e appassionato – ha avviato attività filantropiche mentre fondava Voice of Witness, un progetto educativo che ha il fine di portare alla luce ogni episodio nel quale vengono violati i diritti umani, e ScholarMatch, un programma che mette in contatto gli studenti che hanno bisogno di borse di studio con i potenziali donatori: è insomma uno di quegli idealisti che rifiuta il cinismo e il pessimismo a dispetto di ogni difficoltà. Quando l’incontri ti rendi subito conto che ama esporre le sue idee con fermezza credendo tuttavia sinceramente nel confronto, e questa apertura intellettuale trova una propria declinazione nell’eclettismo con cui si esprime artisticamente: è anche un apprezzato artista figurativo che espone regolarmente presso la Electric Works, una delle principali gallerie di San Francisco, ed è stato celebrato con una retrospettiva al Nevada Museum of Art. Per cercare di comprendere una personalità così poliedrica è bene accennare infine ad alcuni dati personali: la moglie Vendela Vida, madre dei suoi due figli, è una scrittrice molto stimata che ha fondato con lui la rivista The Believer, mentre il fratello William è un illustre analista politico che collabora regolarmente con think tank conservatori promuovendo lo strumento della privatizzazione, quanto di più lontano dalle sue idee politiche. L’ottimismo e l’energia riescono a nascondere i grandi dolori che hanno costellato il suo percorso esistenziale: la morte dei genitori John e Heidi a poche settimane di distanza, che ha tentato di esorcizzare nel suo magnifico memoir L’opera struggente di un formidabile genio, e il suicidio della sorella Beth. C’è un altro elemento prettamente americano nel modo in cui affronta ogni sfida: la capacità di reagire alle difficoltà attraverso scelte prammatiche che individuano l’eroismo nella quotidianità e persino nell’aurea mediocritas. E’ stato lui ad allevare il fratello Christopher che aveva solo otto anni quando morirono i genitori, e non c’è rivista o iniziativa culturale che non sia diventata un punto di ritrovo per giovani scrittori che individuano in lui un riferimento non solo letterario: la condivisione è un ennesimo elemento fondamentale della sua personalità.
Ci conosciamo ormai da una quindicina d’anni, e ho imparato da tempo che nel corso dell’intervista è spesso lui a fare le domande, per poi sintetizzare le sue risposte colorandole con ironia. Gli spiego che l’intervista che state per leggere è parte di una serie di incontri con scrittori americani, e si limita a chiedermi: “Da dove iniziamo?”
Dal momento in cui ha deciso di diventare uno scrittore. Ricorda quando e come è avvenuto?
Il 23 agosto 1992 alle 16.32. Sto scherzando. Mi è difficile identificare quando, dove e come: Ovviamente c’è un momento nel quale tu decidi di scrivere per tutta la tua vita e poi c’è un momento in cui sei in grado di pagare il tuo affitto con il tuo lavoro di scrittore. Nel mio caso tra queste due date è passato un decennio.
Sono interessato a sapere sempre quali siano i sentimenti che prova un autore nell’atto della scrittura. Daniel Mendelsohn mi ha parlato di urgenza e Donna Tartt di assorbimento.
Per quanto mi riguarda a volte provo gioia e a volte fatica. Quando scrivo narrativa provo quasi sempre gioia. Con il giornalismo quasi sempre fatica. Ma il giornalismo proviene sempre da un luogo di urgenza, dal momento che è parte di un flusso di eventi, quindi devo creare spazio per la fatica.
C’è un autore o un’autrice che è stato fondamentale nella sua formazione di scrittore?
Quando ero giovane direi, certamente, Joan Didion. Sì, lei più di chiunque altro. I nostri stili non potrebbero essere più differenti, ma è risultato impossibile per me rimanere insensibile al modo con il quale è riuscita a dominare sia la narrativa che la saggistica. Per non parlare della libertà intellettuale, che la rendeva unica nel modo in cui esponeva le proprie idee politiche.
Con gli scrittori che ho intervistato ho affrontato anche il problema del rapporto tra forma e contenuto.
E’ una questione sempre fondamentale in ogni forma di espressione artistica: quali sono state le vostre conclusioni?
Nessuna conclusione definitiva, sarebbe assurdo e anche arrogante. Tuttavia, a costo di sbagliare, io ho la netta sensazione che i libri, i film, e in generale le opere d’arte oggi siano apprezzati più per la nobiltà del loro contenuto che per le effettive qualità. Se è d’accordo, che rischi individua in questa tendenza?
Hmm. Non ci avevo mai pensato in questi termini. Lascio a lei questa osservazione: immagini che io sia seduto di fronte a lei e dica “interessante, interessante” mentre mangio del pane.
Abbiamo riflettuto su come linguaggio dell’immagine abbia cambiato – se lo ha cambiato –- il linguaggio delle parole.
Sto di nuovo mangiando del pane mentre dico “interessante. Interessante.”
Mi lasci almeno provare a chiederle se c’è qualcosa che secondo lei la letteratura possa fare meglio del cinema.
Nel momento in cui leggiamo, siamo i direttori della fotografia del libro, e benché io ami i film e ami disegnare e dipingere, non esiste direttore della fotografia, così come non esiste pittore, che possa realizzare qualcosa di migliore di quello che siamo in grado di creare con le nostre menti.
C’è qualcosa che il cinema riesce a fare meglio della letteratura?
Negli ultimi tempi ho cercato di riflettere sul perché io ritorni sempre su alcuni film e li guardi continuamente. Mi sono convinto che molta di questa attrazione sia dovuto al montaggio. Un buon film si trasforma in un grande film nella fase di montaggio, nella sua spietata e nitida precisione. E’ qualcosa che i film riescono a fare bene e in maniera unica.
I suoi colleghi intervistati finora sostengono tutti che un adattamento cinematografico debba essere qualcosa di autonomo rispetto al libro, fino al punto di tradirlo: lei ha adattato libri di altri autori e ha visto adattare i suoi testi. Qual è la sua opinione a riguardo?
“Tradire” è una parola forte. Ma un film dovrebbe essere un’opera d’arte corollaria ed esuberante, non una riproduzione diligente. I grandi adattamenti si prendono grandi libertà e quindi sono opere autonome.
Ritiene che Twitter/X abbia cambiato il linguaggio degli scrittori?
Io non vedo alcun effetto di Twitter/X nel lavoro degli scrittori di qualità. Almeno per quanto riguarda la mia conoscenza degli scrittori americani.
Gli scrittori che ho intervistato si sono dimostrati estremamente freddi in relazione all’intelligenza artificiale: lei come valuta le opportunità e i rischi che essa comporta?
L’intelligenza artificiale ha migliaia di applicazioni in campo scientifico che possono salvare delle vite umane, e questo rappresenta un valore imprescindibile. Tuttavia ne detesto con tutte le mie forze, anzi con la forza di mille soli, l’utilizzazione nell’arte. Nella scrittura non esiste un’utilizzazione dell’intelligenza artificiale esente da rischi, punto. Equivale a imbrogliare sia quando si è a scuola che all’università. Ed è un’opzione ridicola e pigra a livello professionale. Se usi l’intelligenza artificiale per scrivere, non sei uno scrittore, ma un programmatore.
Recentemente nel mondo della Video Art si riscontra una tendenza a utilizzare come soggetto dei classici del cinema: penso ad esempio a The Clock di Christian Marclay o la versione di 24 ore di Psycho realizzata da Douglas Gordon.
Amo sinceramente ognuno di questi progetti.
Ritiene che appoggiarsi sul passato rappresenti una debolezza sul piano dell’ispirazione?
A mio modo di vedere rappresenta un segno di continuità oltre che una rielaborazione colta di classici del cinema. Se mi chiede il mio parere, è assolutamente favorevole.
Sembra che le fake news abbiano ogni giorno di più lo stesso rilievo della realtà: lei come combatterebbe questo problema?
Comincerei innanzitutto dal regolamentare Internet.
Non si corre il rischio della censura?
Ho parlato di regolamentazione all’interno di un campo che sembra non tolleri limiti. Altra cosa è la censura, che è sempre odiosa e sbagliata.
Sapevo che saremmo finiti a parlare di politica: il mondo liberal, non solo negli Stati Uniti, sembra essere sempre più elitario. Come è successo?
Ma quando non è stato così? In particolare negli Stati Uniti i liberal tendono ad avere un’istruzione e un’educazione maggiori. E più acquisiscono queste caratteristiche, e più diventano scettici in relazione al fascismo travestito da populismo (che ora indossa i cappelli rossi). Non c’è da stupirsi se oggi i repubblicani hanno intenzione di distruggere il ministero dell’Educazione. Se tutto l’elettorato fosse ben istruito, non avrebbe mai eletto un fascista condannato per molestie sessuali che promette apertamente di mettere fino alla democrazia americana.
Eppure in ogni parte del mondo i populisti sembrano riuscire a interpretare le esigenze e i sogni dei votanti molto più dei partiti tradizionali, specie quelli di sinistra.
In quasi tutti i paesi c’è uno zoccolo duro che oscilla tra il fascismo e il populismo di circa il 40 per cento. E’ una percentuale della popolazione che preferisce un fascismo efficiente piuttosto che una democrazia caotica. Ora stiamo assistendo al fenomeno di opportunisti come Trump che sfruttano abilmente la forza di questa parte della popolazione, dandogli nello stesso tempo potere. Come ci si libera di questo zoccolo duro di fascisti ostinati? Ancora una volta la risposta è l’istruzione.
Che cosa manca alla sinistra per essere più convincente e conquistare l’elettorato?
Come hanno fatto in passato sia Bill Clinton che Barak Obama, i liberal devono dirigere il proprio messaggio verso il centro, e il messaggio deve essere focalizzato sull’economia, la sanità e il costo della vita. I democratici devono ricordare che l’elettorato americano, nel bene e nel male, vuole cambiamenti radicali ogni 4-8 anni. Il prossimo candidato alla presidenza non può apparire in alcun modo un candidato del sistema, ma deve essere, o almeno apparire, come un outsider.
La cultura e l’arte in generale come devono porsi rispetto al potere?
Opporsi quando necessario. E fare sempre domande.
Ha letto Elegia americana?
No. E’ sempre stata considerata robetta dal momento in cui è uscita, soprattutto negli ambienti e tra la gente rurale che descrive. E ora credo sia chiaro a molti chi sia J. D. Vance, che qualche anno fa definiva Trump l’Hitler americano.
Ritiene che quello che sta succedendo in questi ultimi mesi metta a repentaglio la libertà in America?
Sì, certamente. Ogni giorno un pilastro della democrazia americana è buttato nel tritacarne.
Secondo lei, la cultura americana sta diventando più insulare?
Non si può fare un’affermazione del genere in assoluto sulla cultura americana. Ma è certo che all’interno del popolo Maga sono celebrati l’isolazionismo e l’ignoranza.
C’è qualcosa che ammira o almeno apprezza della attuale amministrazione?
No.
Come hai reagito alle elezioni del primo Papa americano?
E’ di Chicago, e chi proviene da lì generalmente rappresenta il meglio del paese. Come posso non amarlo?
Immaginiamo che lei venga eletto ministro della Cultura: quale sarebbe la sua prima iniziativa?
Riportare in vita il Wpa (Works Progress Administration) di Roosevelt, con il quale gli artisti erano pagati per documentare com’era il paese in quel momento. Non avremo mai una documentazione migliore dello stato cui versava la nazione di quella che artisti diversi come Diego Rivera, Saul Bellow e Dorothea Lange crearono negli anni Trenta e Quaranta.