
Foto Getty
l'intervista
L'amore, uno spasmo di cui è impossibile privarsi. Chiacchierata con Cathleen Schine
Il femminismo, il ritmo dei romanzi, il fantasy e il linguaggio, l'intelligenza artificiale e l’impegno nell’arte: “Il ruolo dello scrittore è testimoniare, anche solo continuando a esistere”, ci dice la scrittrice americana
Quando l’ho contattata per questa intervista, Cathleen Schine mi ha chiesto di parlare soltanto di letteratura perché “la situazione politica internazionale è troppo deprimente”. Ma poi, subito dopo ha aggiunto: “E’ impossibile eludere temi con i quali chiunque deve confrontarsi. Anzi grave”. E’ una donna colta, intelligente e autoironica, nella quale la tradizione ebraica della famiglia in cui è nata convive con quella del New England, l’area nella quale è cresciuta. Qualche anno fa fece scalpore la sua decisione di abbandonare il critico David Denby, padre dei suoi due figli, per Janet Meyers, la produttrice che poi ha sposato, e solo qualcuno ha ricordato che la missiva al centro della Lettera d’amore rivelava una relazione omosessuale. I suoi romanzi sono caratterizzati dalla leggerezza che contraddistingue il suo carattere, ma questo non le impedisce affatto di raggiungere la profondità, al punto che la rivista People l’ha definita una “Jane Austen dei nostri tempi”.
Da qualche anno si è trasferita a Venice, in California: “Los Angeles, con il suo clima e i suoi tempi lenti, si adatta meglio al mio carattere pigro”, mi ha spiegato. “E amo il mio letto: è più grande di una scrivania ed è strutturato in maniera migliore per poggiare libri e carte. E’ più morbido di una scrivania, ed è disegnato meglio per poterci riposare: è il centro di tutte le cose belle. Di giorno, o di notte sanno tutti dove trovarmi”. Nei suoi libri è evidente che il cuore di ogni sua riflessione è l’amore, raccontato come uno spasmo del quale è impossibile privarsi, ma che rende la vita degna di essere vissuta anche quando genera sofferenza: “L’amore mi tormenta come se fosse dolore”, ha scritto, e “sono innamorata. Una scelta tipicamente stupida”. E poi “mi lascerai, ti dimenticherai di me. Gli uomini sono tutti uguali. Proprio non ci arrivate. L’abbandono è una forma di stupro”. E’ da queste affermazioni che ho voluto iniziare la nostra chiacchierata chiedendole se ritiene di essere una scrittrice femminista.
“Spero che molte delle idee dei miei personaggi ne siano imbevute”, mi ha detto, “tuttavia non penso mai: ‘ora scriverò un libro che esprime i miei valori femministi’. La saggistica si adatta meglio a questo tipo di scrittura didattica, ma ci sono molte straordinarie romanziere femministe, a cominciare da Virginia Woolf”.
Ce ne sono altre alle quali si ispira?
Maxine Hong Kingston, ma chi è al suo livello? A mio avviso lei è incomparabile. E’ una magnifica romanziera femminista, ma come succede con i grandi scrittori, dovremmo citarla anche in molte altre categorie: nessuno può limitare la sua forza morale artistica a quell’unico elemento, per quanto importante nel suo lavoro. Sa chi scrive romanzi su donne che lottano contro le restrizioni della società? Anthony Trollope. Mi fa piacere inserire anche lui nel Pantheon femminista.
Qualche giorno fa ho dialogato con Annie Proulx su come il linguaggio delle immagini ha cambiato quello della parola scritta.
Ma siamo sicuri che sia veramente cambiato? Intendo: so che in qualche modo il cinema lo ha cambiato, ma quando leggo qualcosa di veramente buono non c’è separazione tra l’immagine e la parola: sono un’unica cosa. D’istinto mi verrebbe di rispondere che il ritmo nei romanzi è cambiato, ma poi mi vengono in mente quei film degli anni Trenta con dialoghi così veloci che faccio difficoltà a seguirli. Mi chiedo se l’auto-fiction sia stata influenzato dal cinema, e se siano stati i film a influenzare il proliferare del fantasy in campo letterario. Ho l’impressione che l’influenza sia in realtà relativa ai temi più che al linguaggio. E’ vero che oggi nessuno scrive periodi come quelli di Henry James, ma certamente il ritmo della vita è responsabile di questi cambiamenti in misura eguale a quello del cinema.
Annie Proulx è arrivata a parlare della fisicità dei libri per riflettere su quello che la letteratura può fare meglio del cinema.
A me viene da pensare alle riflessioni interiori, ma anche allo scrivere sullo scrivere, sul pensare e sull’osservare.
Esiste invece qualcosa che il cinema può realizzare meglio della letteratura?
Poco tempo fa ho visto Hester Street, con cui Joan Micklin Silver debuttò nel 1975. Un mese dopo ho letto Yekl, un romanzo pubblicato nel 1896 da Abraham Cahan, grande scrittore socialista, attivista e per lungo tempo direttore del giornale Yiddish Forvarts. Dopo poche pagine mi sono resa conto che Hester Street era un adattamento di Yekl, e che la Silver aveva avuto un approccio quasi sociologico: il suo intento era educare il pubblico americano ai processi degli immigrati ebrei Lower East Side e al conflitto che vivevano tra la tradizione e l’assimilazione, ed è riuscita a trasformare tutto ciò in un’opera d’arte. Si trattava del risultato di immagini che miglioravano le parole? In alcuni casi sì. Nel film ci sono momenti, alcuni rapidi accenni ai comportamenti, magari uno sguardo tra due personaggi, che avrebbero potuto essere nel romanzo ma in realtà non c’erano. Perché credo che la reale differenza non è il mezzo ma lo scrittore e la regista; i loro temperamenti, i loro talenti i loro obiettivi. Quindi parto dal creatore piuttosto che dal mezzo, e, tenendo in mente ciò, la mia risposta alla sua domanda e un convinto sì!
Qual è stata la sua reazione all’adattamento della “Lettera d’amore”?
Sono stata e sono ancora estremamente grata che sia stato realizzato. Mi hanno pagato bene, ogni persona coinvolta è stata estremamente rispettosa e io non avevo alcun ruolo nelle decisioni, né alcuna voglia di essere coinvolta. Ho scritto il libro, e il libro esiste come l’ho scritto e questo è tutto. Tuttavia, a parte la gratitudine e la consanguineità, non riesco a guardare il film, mi fa letteralmente ammalare. Non è un giudizio, è un fatto biologico che nasce nella miscela tossica tra la mia presunzione e la mia modestia. Ascoltare le proprie parole in un differente contesto significa ascoltare tutto ciò che c’è di sbagliato nelle proprie parole e anche tutto ciò che coloro che hanno realizzato il film non hanno capito nel momento in cui le usavano. E arriva la nausea.
E’ vero che nel film la professione di uno dei personaggi è cambiata radicalmente?
Nel libro George è uno psichiatra, nel film un pompiere! Si tratta certamente di un’attività che comunica più vitalità. Forse è anche più uomo? I pompieri proiettano immediatamente l’immagine di un uomo virile che aiuta altra gente.
Lei pensa che Twitter / X abbia cambiato il modo in cui si esprimono gli scrittori?
Avevo una vera e propria dipendenza per Twitter fin quando Elon Musk non se ne è appropriato e l’ha rovinato. Qualche anno fa ho letto un libro basato sui tweet, ma non so se abbia esercitato nei miei confronti un’influenza durevole. Io ritengo che ciò che ha cambiato maggiormente il linguaggio è stato l’avvento del fantasy: perfino quel libro basato sui tweet aveva per protagonista una sirena. Io credo che i libri di Harry Potter – che io amo, calmatevi odiatori della Rowling – hanno conquistato l’immaginazione di tanti ragazzi che sono diventati scrittori.
Ha mai usato l’Intelligenza Artificiale?
Sto scrivendo un libro che richiede una grande quantità di ricerca sulla prima metà del XIX secolo, e mi rifaccio costantemente a Google, che da un po’ di tempo appare sullo schermo insieme alla possibilità di utilizzare AI. Mi sono reso conto che molto spesso è superficiale e piena di errori, e l’unica volta che l’ho usata proficuamente mi è risultata utile per le referenze elencate sotto ogni informazione che mi forniva. Si trattava di molto materiale che in gran parte avevo già scoperto, ma devo ammettere che mi ha fatto individuare altre fonti. Non ho mai chiesto però alla AI di scrivere qualcosa: è il mio mestiere, perché dovrei farlo?
Quali sono secondo lei le opportunità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale?
Ho un’amica docente, la quale insiste che i suoi studenti imparino ad usare ChatGPT in modo che possano controllarla e non ne siano controllati: a mio avviso un approccio interessante che guarda al futuro. L’intelligenza artificiale non va da nessuna parte, quindi è meglio farsela amica e imparare a manipolarla con successo, sempre che sia possibile. C’è gente che la usa come editor e voglio confessarti che ho flirtato con l’idea di sottoporre il mio nuovo libro e chiedere “di che diavolo parla questo testo?” Perché si tratta di qualcosa che io non so mai fin quando il libro è finito, e la gente me lo chiede sempre. Poi però mi sono resa conto che non volevo che questo gigantesco ladro di dati fosse il mio primo lettore: è già abbastanza difficile far uscire un libro e avere un’opinione dagli esseri umani. Aggiungo che esiste anche una questione molto seria che riguarda gli scrittori e chiunque faccia attività creativa, ai quali non viene chiesto alcun permesso né viene riconosciuta alcuna ricompensa per l’uso del loro lavoro: in questo AI non ha vergogna.
E’ giunto il momento di avvicinarsi ai temi politici: ritiene che c’è modo di contrastare le fake news?
Spero con tutto il cuore di sì. Mi sono rimasti pochi riferimenti dei quali mi fido sulla stampa o sui social media, e leggo il resto per bilanciare la bolla: un viaggio nella bolla della destra per portare un po’ di luce o anche di buio nella mia bolla di donna di sinistra.
Quale è il confine tra letteratura e in generale l’arte impegnata e la propaganda?
Il rischio della propaganda esiste sempre per chi realizza qualcosa con un fine che non è l’arte stessa, e molto ha a che fare con il talento dell’artista: la compiutezza dell’opera deve trascendere il messaggio. Esiste poi anche il rischio che tutto ciò avvenga inconsapevolmente: gli scrittori non vivono nel vuoto, e c’è sempre un dialogo tra il mondo e l’individuo che cerca di decifrarlo. A volte parli degli orrori, della crudeltà e l’odio diffuso nel mondo, a volte celebri la bellezza, la gioia, l’amore, l’umorismo che continua ad esistere anche all’interno dell’orrore. Mi rendo conto che questo può sembrare fuori moda, ma penso che l’arte sia personale e idiosincratica come può esserlo anche la morale.
Lei si è appena definita una donna di sinistra. L’America e gran parte del mondo sembra andare in direzione opposta: come crede che possa rinascere la sinistra dopo la disastrosa sconfitta di novembre?
La sconfitta non è stata disastrosa in termini di numeri, ma certamente lo è stata per le sue conseguenze. Vorrei poter avere una risposta. Tutto quello che so è il poco che posso fare in prima persona: non voglio essere un attivista, non voglio andare a protestare il sabato, sono troppo vecchia. Voglio sedermi sul mio tavolo di lavoro, scrivere un libro ambientato nella prima metà di un XIX secolo e andare a passeggio col mio cane sulla spiaggia. Ma so che resistere è l’unica cosa che possiamo fare e c’è chi parla di nuovo maccartismo. A questo riguardo il mio slogan di protesta è composto dalle parole che Joseph Welch disse al senatore McCarthy: “non si vergogna, non le è rimasta un po’ di decenza?” Ma il tradimento che l’America sta vivendo è molto peggiore. Non è possibile racchiudere nel contenitore della decenza la creazione di un enorme esercito personale per realizzare le idee velenose e deviate di Stephen Miller. La crudeltà che si aggira liberamente nelle strade e in ogni ufficio dell’immigrazione supera McCarthy, come anche il rifiuto della scienza, dell’educazione, dell’assistenza sanitaria. Lui spargeva paura nell’elite: il governo e Hollywood, questo pericolo è molto più ecumenico.
Personalmente ritengo che il successo di Trump sia dovuto anche a una reazione agli eccessi della cultura woke.
Ovviamente c’è anche una relazione, ma quegli eccessi nacquero come reazione alla lunga storia di orribili ingiustizie del paese, e alla fine ci siamo trovati con una nuova forma di ingiustizia. Ci siamo cullati a lungo con il mito dell’America che dà il benvenuto agli emigranti, garantisce libertà religiosa e tiene separate la Chiesa dallo Stato. E quando ci siamo resi conto che era soltanto un mito, ci siamo detti che era un bel mito e abbiamo cercato comunque di vivere credendoci. Ora quei valori, mai raggiunti ma sempre cercati, sono stati brutalmente rifiutati, buttati nella spazzatura e calpestati. Che tragedia.
Quali sono secondo lei i motivi del successo dell’attuale presidente?
Lo spettacolo. Penso che non sia altro che spettacolo. La gente ama il caos e ritiene che sia come il wrestling: tutta scena e nessuna conseguenza, ma non è così. Parliamo di persone che amano la libertà di odiare, ma per fortuna esiste una metà del paese, purtroppo esausto, che non la pensa così. Ritengo che il male con il quale ci stiamo confrontando sia per alcuni troppo doloroso, soprattutto se paragonato al senso di liberazione che provano alcuni nei confronti delle sconvolgenti trasgressioni di Trump. Ancora una volta lo spettacolo, sempre spettacolo.
Tuttavia il mondo dello spettacolo è schierato in grande maggioranza contro il presidente.
Quello che ha messo in scena da Trump ha altri codici, terribilmente efficaci. Pensa agli slogan, anche a quelli della sinistra: possono essere più intelligenti che di autentica sostanza e portano con sé il pericolo di minimizzare il pericolo. Viceversa Trump, rispetto al suo elettorato, è avvantaggiato dal modo in cui utilizza nomi volgari nei confronti di chi gli si oppone, o da come classifica i suoi orribili ordini esecutivi.
Se ritiene che il paese sta vivendo un incubo, non crede che sia insufficiente limitarsi a scrivere?
Il ruolo di chi si oppone consiste testimoniare, e sono convinta che si possa farlo anche scrivendo: è valido come marciare o mandare soldi per finanziare le istituzioni o i partiti che si collocano all’opposizione. Si può farlo anche semplicemente esistendo. Resistere, persistere, esistere.
Crede che l’America abbia gli anticorpi necessari per resistere a questa situazione?
Per me è inconcepibile che non li abbia. Ma a sua volta la situazione è inconcepibile…

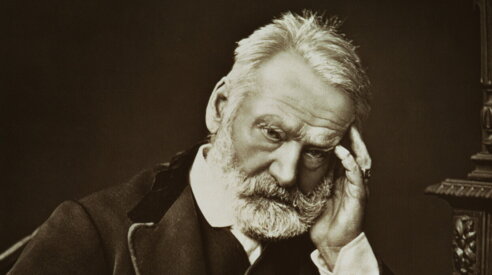
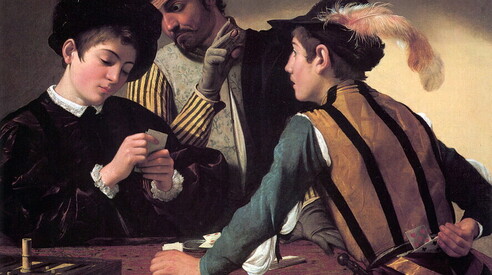
ristampato un altro aureo libretto di Carlo M. Cipolla


