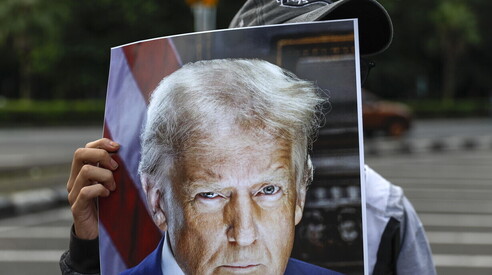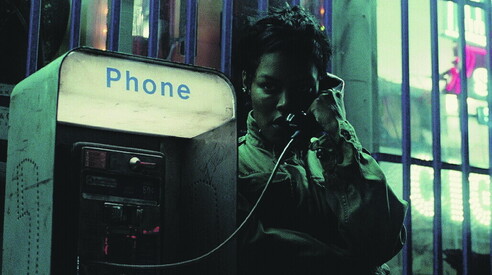"Un'immagine per ogni pagina del romanzo di Thomas Pynchon 'L'arcobaleno della gravità'" di Zak Smith, composta da 755 elementi di tecnica mista su carta (foto Getty)
In libreria
Torna Thomas Pynchon con un detective solitario e una “quest” infinita
Il decimo libro dello scrittore postmodernista è un noir ingarbugliato pieno di personaggi bislacchi e sfortunati, immersi in una combinazione strepitosa di riferimenti ultrapop e spasmi metafisici, con lo sguardo più all'attualità che al passato
Thomas Pynchon sta tornando. Il più impalpabile degli autori statunitensi, il recluso par excellence fresco ottantottenne, è pronto con un nuovo romanzo, ovviamente in pieno stile pynchonesque. Shadow Ticket, annunciato alcune settimane fa dall’editore Penguin Random House, uscirà il 7 ottobre in America. Si tratta del decimo libro dello scrittore postmodernista ed è ancora – come i due precedenti, Vizio di forma (2009) e La cresta dell’onda (2013) – un noir abbastanza ingarbugliato. Milwaukee, 1932. Il detective, ex crumiro, Hicks McTaggart è assoldato per scovare un’ereditiera del formaggio, ma le indagini lo portano lontano: in Europa tra nazisti, spie britanniche, agenti sovietici, musicisti swing, neofiti del paranormale e motociclisti spacconi. Si troverà sballottolato in Ungheria la cui lingua pare indecifrabile ma i pasticcini alquanto rinfrancanti. Vedrà sorgere l’èra delle Big band e lui, ballerino provetto, troverà nella musica l’unico scampo a una società troppo complessa per le sue qualifiche (e per le sue tasche). “Se questo sarà sufficiente – si commenta con ironia nella descrizione disponibile sul sito della casa editrice – a permettergli in qualche modo di tornare a Milwaukee e al mondo consueto, che potrebbe non esistere più, a suon di lindy-hop, è un’altra questione”.
Lo sfondo è, infatti, quello della Grande depressione con l’abrogazione del proibizionismo dietro l’angolo e Al Capone nel penitenziario federale. L’Europa che comincia man mano a squarciarsi. Il metodo intellettuale di Pynchon è, ça va sans dire, induttivo: dal particolare all’universale, da piccoli fatti individuali a enormi movimenti storici in atto. Non c’è dubbio: i personaggi del nuovo romanzo saranno bislacchi, tecnicamente schlemihl (lo sfortunato della tradizione ebraica); avranno impresso lo stigma di nomina loquentes esilaranti e icastici, barbagli del Nome-del-Padre di lacaniana memoria. Basta “tradurre” le generalità del protagonista: hick significa “campagnolo” o “rozzo”; McTaggart è invece una strizzata d’occhio alla serie televisiva scozzese che metteva all’opera il cinico ispettore James Taggart. Strepitoso combinatore di riferimenti ultrapop e spasmi metafisici, Pynchon guarda più all’attualità che al passato. E’ possibile che il suo intento sia di ammonire l’uomo presente occhieggiando una vicenda che in controluce nasconde i mali odierni. Sempre attento agli ultimi, ai diseredati (che sono la vera eredità degli Usa, a suo giudizio), con la foto del profilo di Facebook logicamente oscurata, il buon Thomas difende i deboli dalle nevrastenie dell’opulenza e dagli appiattimenti del sistema. Lo shadow ticket è un biglietto ombra, una prenotazione per un viaggio che non viene pagato immediatamente, consentendo al passeggero di “bloccare” un posto per un periodo limitato. Pynchon, sin dai tempi di V. (1963), ha effigiato persone che cercano di sciogliere misteri irrisolvibili. Hicks McTaggart sembra l’ultimo di una lunga serie di cercatori solitari. Insomma, la verità è una quest, l’accertamento non ha fine. Ecco una casella vuota, un buco trascendentale.
Nel frattempo, qui da noi Einaudi ha ristampato un altro libro chiave dell’autore newyorkese: Un lento apprendistato (traduzione di Massimo Bocchiola, 180 pp., 13 euro) che raccoglie cinque racconti giovanili preceduti da una celeberrima introduzione (il testo uscì negli States per la prima volta nel 1984). Tra alcoliche frequentazioni beat, occhiali da sole con la montatura di corno e feste nei loft, la memoria di Pynchon corre agli anni di stesura dei racconti, nel lustro che va dal ’59 al ’64. E nel mordace contributo prefatorio non fa sconti a sé stesso: “Mi interessava di più mettere sulla carta un’intera gamma di errori. Come lo stile letterariamente verboso. Vi faccio grazia di uno scrutinio di tutte le ridondanze che presentano questi racconti, salvo per dichiarare il mio turbamento davanti alla quantità di viticci che spuntano di continuo. Non so nemmeno ancora con certezza cosa sia un viticcio. Credo di aver copiato la parola da Thomas Stearns Eliot”. Sobborghi, spionaggio, discariche, entropia, termodinamica, pioggerella: dalle primissime composizioni Pynchon si dimostra sensibile ai paradossi della contemporaneità, alla “condizione postmoderna”, esibendo un nugolo di antieroi svitati e irresistibili, braccio armato della controcultura. La lingua è spezzettata in mille slang e tecnicismi, la struttura è già labirintica. D’altra parte, Don DeLillo ci aveva avvertito: “Pynchon ha trasformato la letteratura americana in qualcosa di più grande e più forte”.