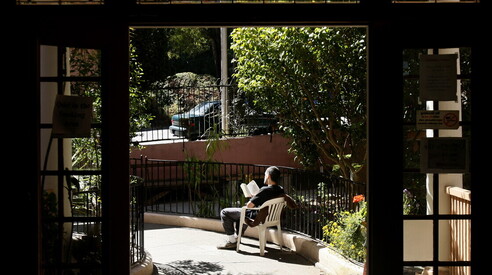
una fogliata di libri
Il potere che avrebbe ancora la letteratura
Senza una visione storica e del mondo si può solo raccontare la propria autobiografia. Ma troppe narrazioni sembrano in realtà abbandonare la profondità per un racconto del dolore più simile a un piagnisteo, ritrovandosi a scrivere romanzi sul reflusso gastrico come visione di sé stessi
Durante gli scontri di Valle Giulia Pier Paolo Pasolini stava coi poliziotti anziché coi manifestanti perché aveva una visione della Storia. Se scrivi e non hai una visione della Storia ti resta la Visione del mondo. Se non hai una Visione del mondo ti resta l’autobiografia. Se sei uno scrivente di questi anni ti crogioli nell’autobiografia sub specie piagnistei, e ti ritrovi a scrivere romanzoidi sul reflusso gastrico come visione di te stesso. Insomma, benvenuto a piano terra. Lo sosteneva qualche giorno fa Guia Soncini su Linkiesta a proposito di Yasmina Reza: un grande scrittore è uno che quando scrive io tu non pensi mai stia parlando di sé, e sono ormai in pochi, del resto mica tutti hanno la forza di generare uno Zuckerman, una Elizabeth Costello o di plasmare un io aldobusiano, bestia felice, lucente e proteiforme che ha sempre fatto letteratura a sé (e non di sé, ma pazienza, lana caprina, ormai stiamo parlando a quattro gatti). Crollata pertanto l’idea che la letteratura sia, implicitamente, lavoro sul punto di vista, ci resta una cameretta con vista su un punto: l’ombelico. Ma come ci si può posizionare in un ombelico per cavarne qualcosa? Istruzioni logistico-prossemiche per l’uso. Posizione 1) Sdraiati come su un’amaca, in posizione dolcemente arcuata: vi vedrete benissimo i piedi, quindi se non avete un alluce valgo cominciate a inventarvene uno. Posizione 2) Rannicchiati come un feto: avrete in bocca le ginocchia, e le ginocchia vi consegneranno, in una folata straziante, i traumi dell’infanzia in bicicletta, quando cadendo ve le sbucciavate. Posizione 3) Faccia in giù, come il morto in acqua: trattenete il fiato fino all’asfissia e l’angoscia vi porterà traumi periferici rimasti nell’ombra ma pronti a riemergere. L’aletta del romanzoide parlerà di “passato che ritorna coi suoi fantasmi”, siamo a cavallo. Sì, perché troverete di certo un editore. Quanto ai lettori, difficile dire, ma il trauma vi garantirà almeno un giro nel traumodromo, e guai a Dio ad averne uno dagli effetti risibili. Il trauma può anche essere un’inezia, ma le conseguenze devono essere di portata devastante. Preparatevi, dunque, per l’agone: sfigurate il quartiere residenziale in cui siete cresciuti e fatene una favela tutta eternit e monnezza (occhio al possibile risvolto civile), estraete dal berretto con visiera della vostra giovinezza il coniglio spappolato di un trainspotting, e del presente fate dolorismo e dolorismo, buttatevi ventre a terra, sbraitate, pestate i piedi. O lamento o muerte!
Meglio muerte. Anzi, meglio Joe Dunthorne, che con “Il dentifricio radioattivo” (Einaudi) dimostra il potere che avrebbe ancora la letteratura, a patto di farla: un memoir verofalso straripante, pieno di dramma, di allegria, di pathos e di gioia di scrivere – quel che ne deriva è un gioiosissimo piacere di leggere. La storia in breve: quando lo scrittore si sposa, la madre gli regala un anello che, dice, “è scampato ai nazisti” nel 1935. Scatta l’indagine. Cosa ne verrà? Una storia di famiglia che rivela quanto ogni narrazione sia una costruzione: duemila pagine di memorie del bisnonno, inventore di un dentifricio radioattivo grazie al quale otterrà un posto in un importante laboratorio berlinese, getteranno una luce piuttosto sinistra. Niente eroismo e niente melodramma. Molte dentiere e senso dell’umorismo. Una storia tra Germania, Stati Uniti, Scozia e Turchia. Miti da sfatare, a profusione.
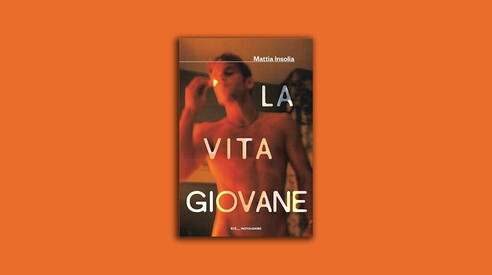

una fogliata di libri
L'altra faccia della Torcia. Lettera da una okkupazione
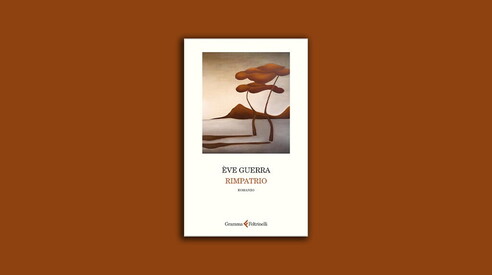
Una Fogliata di libri


