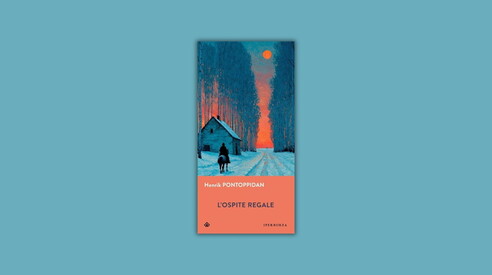Google creative commons
una fogliata di libri
Un grande scrittore scrive per scrivere. E stop
Un grande scrittore non scrive per “esprimere sé stesso”, ma per la scrittura stessa. Come Stendhal o Lucia Berlin, che riuscivano a parlare di sé stessi e delle loro vite, raccontando il mondo intorno a loro
Quando un grande scrittore mette polpastrello alla tastiera la sua scrittura è un omaggio all’atto di scrivere. Difficile che lo intenda come “esprimere sé stesso”, paturnia tardissimo novecentesca e attuale nervatura onnipresente e onnipotente – tutti lì a esprimere sé stessi, da Masterchef al Premio Strega è un gran sestesseggiare pallido e assorto presso un rovente account Instagram, o presso biografie roventi di noia. Al contrario, un grande scrittore prova un filo di repulsione per questa necessità fisiologica, parente più delle attività dell’intestino crasso che delle Lettere, e più volgare dell’autobiografismo massimamente indecente e autoepicizzante che avvilisce la letteratura a filo dei panni cui appendere i propri calzini coloratissimi, indossando i quali si esprime, appunto, sé stessi, e si ricorda al mondo che “tutto racconta una storia” – difficile, ormai, scovare una cantina che voglia farvi bere del vino e basta, difficilissimo trovare uno scrittore che voglia farvi bere delle pagine e basta (poi vabbé, rileggi “Fratelli d’Italia” di Arbasino ripubblicato da Feltrinelli in questi giorni e ti riconcili con la cilindrata letteraria pura).
Insomma, un grande scrittore scrive per scrivere. La musica per la musica. Stendhal: “Quel che scrivo mi sembra molto noioso; se continua così questo non sarà un libro ma un esame di coscienza”. Lo sospettava alla fine del II capitolo di “Ricordi d’egotismo”, capolavoro in cui parlò molto di tutto il resto e solo un poco di sé stesso. In tema, Lucia Berlin. Che in un breve saggio intitolato “Il mio blocco dello scrittore” spiega come ha fatto a scrivere un racconto su sua sorella malata di cancro senza raccontare di sua sorella malata di cancro. “Ogni domenica mia nipote e io trovavamo qualcuno che badasse a lei e andavamo alla corrida alle quattro. Nelle arene la morte era ritualizzata, catartica, tutto il contrario della camera da letto di Molly”. Un mattino, dopo aver visto tre splendide corridas, ne vuole scrivere. Ma come organizzare un racconto che tenesse insieme la sorella e le corride? “Ignoravo gran parte dei termini che lo avrebbero reso un valido reportage”. Quindi soluzione: voce narrante. Ma quale? Una vedova tornata in Messico, dove lei e suo marito erano stati in viaggio di nozze. “Non potevo farla andare da sola all’arena, in Messico non si usa”. Soluzione: farla accompagnare da alcuni turisti, tra cui una coppia di neosposi giapponesi. Con loro, una guida, “che raccontava le corride al posto mio”. Tra i turisti “doveva esserci una vedova, ed essere in lutto. Era necessario che la morte fosse presente anche fuori dall’arena, com’era per mia nipote e me, che telefonavamo a Molly mentre gli areneros trascinavano via i tori insanguinati”. Anche la scelta dei giapponesi non fu causale: un giorno, durante una corrida, un giapponese era morto sugli spalti e nessuno ci aveva fatto caso. Il suo corpo era stato coperto e ignorato fino alla fine della corrida. Ed è normale – racconta Berlin – perché in una corrida la morte è un aspetto immancabile della vita. “La giovane coppia doveva essere innamoratissima, perché a morire sarebbe stato il marito, in modo improvviso e crudele. La mia narratrice sarebbe stata vicina alla moglie, così che si appoggiassero l’una all’altro, come mia nipote e me. Il racconto non parlava della corrida, ma di me, di mia nipote e di Molly. Parlava della morte coraggiosa e bellissima di mia sorella”.

Una fogliata di libri