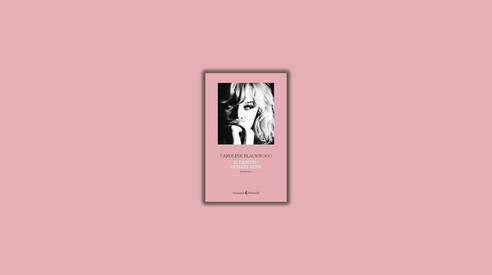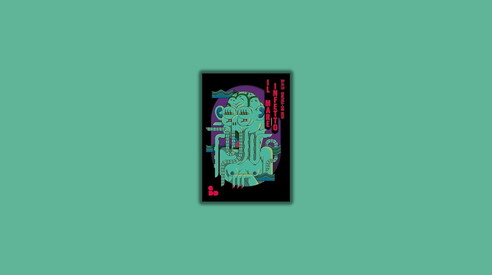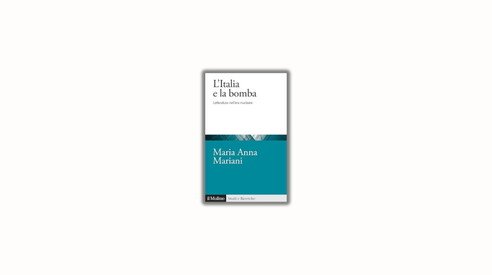
una fogliata di libri
L'Italia e la bomba
La recensione del libro di Maria Anna Mariani edito da il Mulino, 224 pp., 24 euro
Se già Italo Svevo, nella paradossale chiusa de La coscienza di Zeno, si chiedeva retoricamente cosa sarebbe successo all'umanità nel momento in cui la corsa agli armamenti avrebbe finito per produrre una bomba in grado di distruggere ogni cosa, negli anni della Guerra fredda, quando questo rischio era concreto, per scrittori e critici che hanno a cuore la vita sul pianeta tale questione diventa un luogo di riflessione inaggirabile. In un momento storico in cui l’Italia non possiede un arsenale nucleare ma ospita armi statunitensi ed è storicamente impegnata nella ricerca in tal senso (basta ricordarsi di Enrico Fermi nel film “Oppenheimer” di Christopher Nolan), scrittori come Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Leonardo Sciascia e Italo Calvino si trovano a discutere sulla posizione dell’Italia e sui rischi della bomba ed è attorno a questi temi e questi autori che ruota il libro di Mariani che per dipanare il proprio ragionamento fa propria la domanda di Primo Levi: “Che cosa significa vivere nell’èra nucleare non come una superpotenza né come una vittima, ma come complici involontari e passivi?”. Lo studio di Mariani però non si limita all’esposizione dei differenti punti di vista, ma offre al lettore l’immagine di una sorta di metafisica della bomba che, nelle diverse visioni degli autori, trasmette l’urgenza di un’interrogazione in cui la letteratura si intreccia alla politica e alla società, un connubio che oggi pare lontano dall’interesse di scrittori e maître à penser che prediligono il loro mondo ristretto. Così per esempio leggendo le precise pagine dedicate a Italo Calvino emerge bene come il suo postmoderno, spesso affrettatamente derubricato nell’alveo del divertissement o, comunque, del gioco arguto, custodisca in realtà non solo l’immagine di un “impegno senza sosta”, ma anche la prova di come, senza voler per forza essere pedanti, la letteratura possa offrire materiale a un immaginario che poi abita, prepotentemente, il nostro mondo. Elsa Morante sarà poi molto diretta nel suo discorso antiatomico poiché si tratta del “fatto più importante che oggi accade” (nella conferenza “Pro o contro la bomba atomica” del 1965), Alberto Moravia sceglierà una via stilisticamente cristallina per denunciare come il rischio atomico non sia un presagio lontano ma un incubo quotidiano mentre Leonardo Sciascia, con il suo Majorana, proverà ad addentrarsi negli oscuri meandri della coscienza. L’ultimo capitolo, dedicato a La rabbia di Pasolini e all’immagine del fungo atomico che diventa icona, risuona di un’urgenza estremamente contemporanea: quanto ci tocca il male lontano?
Maria Anna Mariani
L’Italia e la bomba
il Mulino, 224 pp., 24 euro