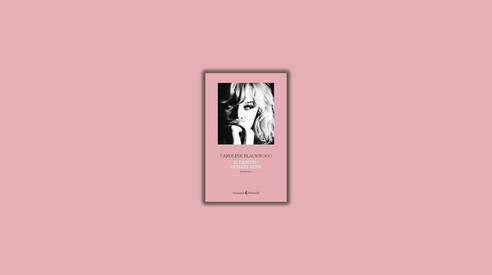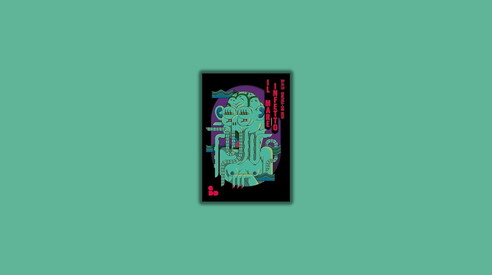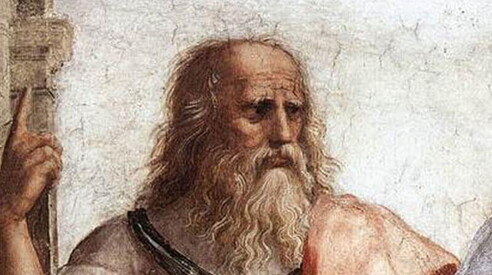
overbooking
Sì, gli antichi sapevano già tutto
Un’impresa ambiziosa: dare voce al pensiero antico senza appesantirlo di dottrina. Nel suo nuovo libro, Matteo Nucci unisce il racconto della vita di Platone alla potenza narrativa della filosofia
Bisogna rallegrarsi dell’ambizione di Matteo Nucci nello scrivere Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli, 566 pp., 22 euro); non tanto per la mole del libro né per l’elevato soggetto, quanto per aver voluto mediare fra due forme narrative non agevoli, il romanzo storico e il romanzo filosofico. Entrambe impongono esigenze stilistiche specifiche – il primo la fedeltà agli eventi, il secondo l’insegnamento di una morale – che quasi mai si accompagnano bene; entrambe, soprattutto, pongono il problema di come debbano parlare i personaggi per suonare credibili senza risultare noiosi o sentenziosi. Il romanzone di Nucci, nella sua accuratezza, è forse inevitabilmente troppo discontinuo per poter formulare un giudizio univoco, ma di certo va sottolineato lo stratagemma che lo caratterizza sin dall’incipit: lo “Scendevo al Pireo” del narratore è un calco del “Discesi ieri al Pireo” di Socrate, con cui inizia il più rilevante dialogo platonico, la Repubblica (Politeia). Addirittura, su quel solo verbo “katèben”, Mario Vegetti si era esercitato in una disamina di pagine e pagine nelle note della sua monumentale edizione critica (Bibliopolis, 7 volumi, 290 euro). E’ con la stessa acribia che Nucci costella la narrazione biografica di citazioni implicite, alcune immediatamente riconoscibili al lettore medio (Platone ha un cavallo bianco e uno nero), altre che si possono decrittare solo ricorrendo al corposo apparato bibliografico nell’ultima decina di pagine. Ciò gli consente di salvare la capra del romanzo filosofico, attenendosi alla lettera della dottrina platonica, e i cavoli del romanzo storico, con una voce narrante che procede intessendo un centone di riferimenti a Platone e a fonti coeve, quasi mai menzionandole ma permeando di esse il discorso. Ciò giustifica altresì la naturalezza di certe sorprese nascoste qua e là, ammicchi a Leopardi o a Freud che non potevano certo essere a disposizione del quarto secolo a.C. però contribuiscono a creare un ordito semantico colto che – in assenza di registrazioni di chiacchierate nell’agorà – suona perfettamente verosimile alle nostre orecchie: agli antichi dobbiamo tutta la nostra cultura, quindi gli antichi sapevano già tutto.