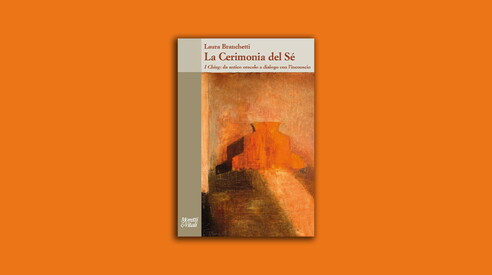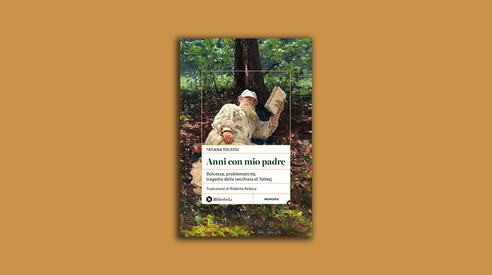una fogliata di libri
Autobiografia della scuola
La recensione del libro di Mario Isnenghi edito da il Mulino, 365 pp., 26 euro
Rovesciando, come spesso gli è capitato nella sua lunga e benemerita carriera di storico, consuetudini e luoghi comuni, Mario Isnenghi fa della vituperata mobilità di professori e maestri uno dei punti salienti di questa storia della scuola italiana. L’assegnazione di una cattedra lontano da casa diventa quindi, più che una condanna a sperimentare sulla propria pelle gli annosi problemi di mobilità fra nord e sud, un’occasione per connettere e connettersi fra culture, costumi, lingue, diverse come sappiamo di regione in regione, anzi, perfino di comune in comune. Questo trovarsi in luoghi remoti, porta i giovani insegnanti a fare i conti con sé stessi, avvicinandoli, nota l’autore, quasi naturalmente alla scrittura. Ecco allora prodursi quasi da sé lettere, memoriali, resoconti più o meno dettagliati sul confronto con terre e genti sconosciute, “manoscritti nella bottiglia che risalgono e ridiscendono nella penisola; e alla fine, una storia molecolare d’Italia attraverso le vite e le relazioni dei docenti, le amicizie che si creano, i riflessi nelle memorie.”
Proprio in questa messe di carte ha voluto navigare Isnenghi, connettendo le microstorie di questi insegnanti che si travestono da giovani esploratori con la grande Storia, fungendo da agenti niente affatto segreti in un contesto talvolta ostile. E’ il caso, ad esempio, del venticinquenne Ernst Gnad, tedesco spedito nel Veneto a cavallo tra la Seconda e la Terza guerra d’indipendenza, trovandosi a verificare sulla propria pelle il passaggio da suddito di un grande impero multiculturale come quello degli Asburgo a cittadino del nascente Regno d’Italia.
In questo itinerario si incrociano vicende di grande risonanza nazionale, come quella della maestrina Italia Donati, perseguitata da malelingue e sospetti di liaison dangereuse con il sindaco di Porciano, dove è stata mandata a insegnare. Ferita irrimediabilmente dal discredito, si suicida, gettandosi nell’acqua del mulino. Siamo nel maggio 1886, il caso diventa presto nazionale, la domanda cruciale è “quale e quanta istruzione per il popolo, e in particolare, quale e quanta istruzione per il genere femminile”.
Nel saggio di Isnenghi la scuola è l’agone nel quale atterrano lacerazioni e traumi profondi, le diatribe fra laici e clericali su tutti, ma anche momenti di grande slancio comunitario, come la storia di Luigi La Vista, il discepolo di De Sanctis diventato martire della causa risorgimentale. E non possono mancare i confronti con i grandi romanzi sulla scuola, l’inevitabile Cuore, ma anche Scuola Normale Femminile di Matilde Serao.
Mario Isnenghi
Autobiografia della scuola
il Mulino, 365 pp., € 26 euro