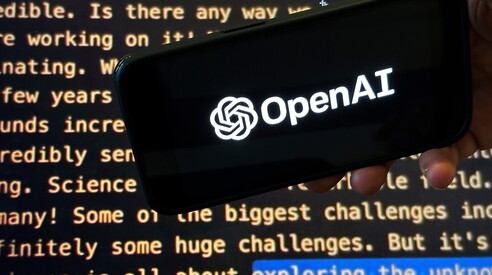Foto Epa, via Ansa
La rivolta dei gamer
Nell'utopica società di Sims quasi nessuno vuole finire nelle mani dei sauditi
La comunità dei giocatori sta reagendo con crescente ostilità alla potenziale acquisizione del colosso americano dei videogiochi Electronic Arts da parte di Pif, il principale fondo d’investimento saudita
Taipei. Mentre a Washington Donald Trump accoglieva il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con tutti gli onori del caso, una comunità transnazionale, quella dei videogiocatori, si ergeva contro il suo regno. Non nelle piazze o nei talk show, ma dentro un videogioco: The Sims. La comunità dei giocatori sta reagendo con crescente ostilità alla potenziale acquisizione del colosso americano dei videogiochi Electronic Arts da parte di Pif, il principale fondo d’investimento saudita, con cui il regno di MbS sta effettuando un’operazione di sportwashing (l’abbiamo visto recentemente in bella vista nei tabelloni degli sponsor delle ATP Finals di Torino) che evidentemente contempla anche i giochi online. L’idea che l’azienda che controlla Sims, la saga di simulatori di calcio FIFA, e titoli famosi come Battlefield possa finire sotto l’ombrello finanziario – e inevitabilmente politico – di Riad ha innescato qualcosa che somiglia a una ribellione silenziosa. Una protesta nata dal basso, in un ambiente che di solito si associa alla fuga dalla realtà, non alla militanza.
Il fondo saudita ha peraltro una genesi singolare: molto del suo quasi trilionario patrimonio (il budget stimato è di 950 miliardi di dollari) deriva dalla famosa purga del 4 novembre 2017, all’hotel Ritz-Carlton di Riad, quando centinaia delle famiglie più ricche del regno ricevettero un invito personalizzato per incontrare il re saudita. L’invito si rivelò essere una trappola, e l’intero hotel divenne una prigione per una settimana, al termine della quale l’élite saudita si trovò decapitata, in un’operazione in cui si stima le vennero confiscati direttamente o indirettamente beni per circa 500 miliardi di dollari. Le violazioni dei diritti umane sono state all’ordine del giorno del regime di MbS, che le ha usate come modus operandi sistematico per darsi una nuova vita nell’era post-petrolio, riposizionandosi come attore con ambizioni globali.
E così è da Twitch e da YouTube che nasce un movimento di ribellione che su internet mancava ormai dai tempi della primavera araba. L’inquietudine dei giocatori non riguarda tanto la gestione aziendale, quanto ciò che nel mondo dei videogiochi conta davvero: la cultura che lo attraversa, la libertà creativa, la possibilità di continuare a plasmare mondi senza filtri ideologici. Chi gioca a The Sims costruisce case, famiglie, identità alternative, e non è un caso che infatti il videogioco sia quello più diverso dal punto di vista della rappresentanza, ben oltre lo stereotipo da incel del giocatore medio, ma capace di includere nella sua comunità una fetta non trascurabile di donne, persone di colore e rappresentanti della galassia Lgbtqi+. Una comunità che teme che l’acquisto da parte del regime saudita dell’azienda possa nascondere un restringimento dell’apertura etica anche all’interno dei videogiochi stessi.
I giocatori di The Sims, un gioco che non ha un vero e proprio obiettivo se non quello di simulare la vita reale, e che condivide con essa proprio il fatto di mancare di un senso logico e razionale, costituiscono una micro-società che, proprio perché fittizia, pretende di restare completamente libera. L’approccio alla rivolta va dal serio – con petizioni e consigli di giochi alternativi – al faceto, con il linguaggio tipico di internet, ovvero gli immancabili meme. Alcuni di essi prendono di mira in maniera piuttosto esplicita l’accordo, suggerendo che il prossimo gioco dei Sims includerà pacchetti di espansione come “La mia prima violazione dei diritti umani”. Ma la protesta assume anche forme curiose: thread chilometrici, video polemici, campagne coordinate sui social, pressioni dirette a EA affinché “non venda l’anima del gioco”. Una mobilitazione distribuita e spontanea, che ricorda le dinamiche dei fandom più radicali: non c’è un leader, non c’è un programma, solo un’idea condivisa di ciò che non deve accadere.
Il fenomeno è sorprendente solo in apparenza, e a chi lo guarda da distante, senza averne provato le dinamiche in prima persona: da anni i videogiochi sono uno spazio dove identità, linguaggi, desideri e rapporti di potere vengono messi alla prova. Ora sono anche lo spazio in cui forse l’ultima comunità globale – dispersa, anonima e senza confini – prova a dire che almeno certi mondi, per quanto virtuali, non sono in vendita.