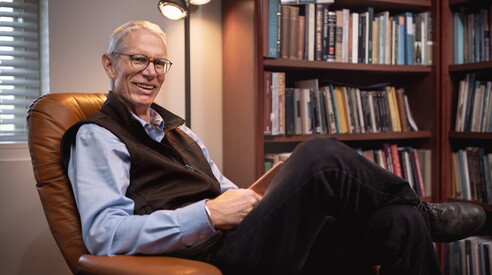
Google creative commons
“Make Athens Great Again”
Democrazia significa ascoltare chi non la pensa come noi, ci dice Josiah Ober
“Il woke crea competizione nella vittimizzazione”, con la richiesta di diritti che si moltiplica e senza pensare ai doveri. La lezione ateniese che spiega dove nascono il nazionalismo e l’autoritarismo
Anticamera del Nobel”, dicono del premio italo-svizzero Balzan, anche se, a differenza della medaglia scandinava, ha la forza di celebrare discipline meno nette. Parliamo di un premio che ha nel suo albo d’oro umanistico figure come Giovanni Macchia, Jan Assmann e Marc Fumaroli, un albo che ha la preziosità chic di un catalogo Adelphi. Quest’anno uno dei quattro premiati è lo statunitense Josiah Ober, che ha dedicato la sua vita allo studio della democrazia ateniese per arrivare a un risultato che non piace a molti, cioè che l’unica vera democrazia possibile funzionale è quella liberale. Il professore di Stanford ha ricevuto il premio nell’emiciclo svizzero dalle mani della presidente della fondazione Balzan, Maria Cristina Messa, e da Marta Cartabia, che presiede il comitato generale premi, allegra delegazione del compianto governo Draghi in esilio a Berna. L’ex ministra della Giustizia ha sottolineato l’importanza della ricerca di Ober “oltre il mondo accademico, influente nel dibattito pubblico”, perché studiare l’Atene di allora vuol dire capire come oggi funziona il demos, tema ora caldo più che mai, dato il numero di sguaiati allarmi sulla fine della democrazia. “Certo”, dice il professore al Foglio, “c’è un drammatico aumento di democrazie illiberali, ma bisogna ricordare che la democrazia nella storia è un’eccezione. Non viviamo in una situazione inusuale. Per una nazione è più facile diventare un’autocrazia. Oggi due terzi della popolazione vivono in regimi autocratici”. E poi ci sono quei regimi, che nel suo libro “Demopolis” etichetta come pseudo-democrazie, o democrazie illiberali, dove c’è l’illusione del voto e dove ci si proclama democratici, ma non ci sono quelle caratteristiche liberali di base (basta andare a farsi un giro in Sudamerica).
Ober, che è anche nell’Hoover Institution diretto da Condoleeza Rice, ammette che oggi la democrazia liberale è in crisi, soprattutto rispetto agli anni 90, quando “prematuramente” si pensava fosse ormai vittoriosa. “Ma non ci si era resi conto che in diverse parti del mondo non avevano esperienza dei doveri civici della cittadinanza, erano solo esaltati dall’idea dei diritti”. Ma “la democrazia oggi non sta morendo”. C’è una possibilità di un conflitto civile, ma è una possibilità meno realistica della “visione ottimistica” di Ober, “dove si può imparare a diventare cittadini responsabili, perché essere pessimisti vuol dire creare una profezia che si auto avvera. Dire ‘è finita’ porta alla fine. E infatti molti, come Candido, preferiscono chiudersi a coltivare il proprio giardino”. Il professore ha iniziato a cercare le risposte politiche nella Grecia antica mentre il suo paese era impegnato in Vietnam, e da allora ha cercato di costruire dei vademecum su cosa si può imparare dagli ateniesi. Atene ci “mostra il bisogno di una vera cittadinanza partecipativa. Quando gli ateniesi si sono presi il potere alla fine del sesto secolo hanno dovuto fare il lavoro dei cittadini, passare ad esempio un anno nel consiglio dei cinquecento. Vuol dire prendere un anno dalla tua vita per fare il lavoro quotidiano del governo. Anche una persona così poco politica come Socrate l’ha fatto, e facendolo impari come funziona la macchina”.
Per un po’ la democrazia liberale moderna da qualche parte nel ’900 ha funzionato, anche se sempre in modo “imperfetto”, e Ober cita gli Stati Uniti, ovviamente, e alcuni paesi europei, dove c’erano delle serie elezioni competitive, dove i cittadini pensano davvero di poter scegliere rappresentanti che difendono i loro interessi, e nel background c’è un sistema di diritti generalizzati su cui non si vota, che sono lì, protetti dalla Costituzione, fissi”. Quando nasce il problema? Quando la richiesta di diritti si moltiplica, senza pensare ai doveri, e quando nessuno vuole più dialogare con l’altra parte. Il caso perfetto è il movimento woke. “Parte di quel movimento dice che la ‘vera identità’ non è quella di un cittadino – un cittadino riconosce che gli altri sono diversi da sé e sa che deve negoziare con loro – ma è un’identità legata al gender o all’etnia. Questo va contro l’idea di cittadinanza. Per loro, la cosa importante sono ‘i diritti richiesti da quel gruppo identitario’, anche se vanno contro i diritti degli altri fuori da quel gruppo”. Perché in fondo la democrazia si basa sul fatto che “ogni gruppo deve riconoscere che ci sono altri gruppi con altri interessi, e che si arriverà a una negoziazione e a un accordo che darà a ogni gruppo una parte di quello che vogliono, ma nessuno ottiene proprio tutto quello che voleva”.
Il problema del mondo woke è che vuole “totale e completa giustizia per il suo gruppo” e se non la ottiene si rifiuta di stare al gioco della democrazia. La questione della percepita ingiustizia crea mostri, pensiamo al movimento da campus Queer for Palestine. “Siccome si gioca tutto sull’ingiustizia esportata”, ci dice Ober, “chiunque viene visto come vittima di un’ingiustizia è pertanto visto come giusto, e qualunque cosa fa è corretta, perché è vittima. Il woke crea una competizione sulla vittimizzazione. Chi è vittima ha più diritti, e questo crea una gara in negativo”. E così si parla di intersezionalità e si sommano genere, razza, eccetera per “far vedere quanto uno è vittimizzato”. Nasce un cortocircuito. Perché chi sta “fuori da quel mondo” finisce per dire: “‘Ma siamo noi le vere vittime’. E così hai il nazionalismo bianco. Partecipano anche loro a questa gara della vittima. E’ uno scontro terribile perché ognuno afferma che i propri diritti vengono violati e nessuno accetta una negoziazione”. I pericoli per la democrazia liberale arrivano dagli estremi. “Bisogna riconoscere che non ci sono solo i teppisti della destra alternativa, ma anche una sinistra che si frammenta per andare alla ricerca del gruppo identitario”. La soluzione va cercata sempre ad Atene, ed è l’educazione civica. “Dobbiamo tornare a educare i cittadini a riconoscere che la moderazione è una virtù. Trattenersi è parte dell’essere cittadino. Essere cittadini vuol dire essere coraggiosi abbastanza per dire la propria, ma anche moderati abbastanza da ascoltare gli altri quando dicono la loro”.
Oggi, anche in paesi come Francia o Stati Uniti, tra gli esperimenti democratici più riusciti dell’epoca contemporanea, ci sono fette di popolazione che al caos o al “deep state” preferirebbero l’uomo forte. Ma tutto, spiega Ober, parte dalle élite che hanno iniziato a percepirsi come “di un’altra classe”. E cita quella frase di Hillary Clinton detta durante le presidenziali del 2016 – “branco di miserabili” – parlando dell’elettorato Maga, frase “rivolta alle persone non scolarizzate”. Queste figure si sono staccate troppo dal popolo, “sembra che invitino solo a votare e basta, ma quando il governo e i cittadini si separano crolla tutto”, spiega il professore. “Per me la democrazia è un autogoverno dei cittadini, diretto o tramite rappresentanti, ma appena chi governa viene visto come qualcosa di diverso da we the people, cioè ‘noi il popolo’, siamo nei guai. E’ questo che porta ai demagoghi populisti che dicono: ‘anch’io odio l’élite, io sono come voi, io solo capisco i vostri interessi, fidatemi di me’”.
“Mi sono chiesto: cosa penserebbero gli ateniesi di Trump? Basterebbe il fatto che abbia evitato di partire militare per il Vietnam per screditarlo, oltre al fatto che viva in una casa tutta d’oro”. Anche sugli “oligarchi” della Silicon Valley sarebbero scettici nell’agorà, ma non tanto per il loro stile di vita, quanto perché molti di questi “partono dall’idea che l’expertise tecnologica possa progettare il futuro, che c’è una soluzione ingegneristica a tutto. La convinzione ateniese è che non ci sono esperti quando si parla di politica e di azioni necessarie per vivere insieme”. Ober tira anche fuori la questione dei media, che secondo lui “non stanno aiutando la democrazia. Soprattutto i social”. Perché creano delle “bolle di opinioni e informazione. Oggi si ottengono solo le informazioni esacerbate che intensificano le loro posizioni. I social generano rabbia ed emozioni intense, spingendo verso gli estremi. Non ci uniscono con un corpo comune di informazione. Questo è un problema perché ci incoraggia a percepirci come parte di rigidi e piccoli gruppi identitari, con interessi ostili agli altri. Nessuno di noi avrà tutto quello che vuole perché è impossibile averlo in una società pluralista”.
Josiah Ober, per statuto, dovrà usare metà dei soldi ricevuti dalla Balzan per un “programma per giovani accademici”, e ha deciso di concentrarsi su un piano di studi sulla “rivitalizzazione della democrazia”, cioè capire come hanno fatto le democrazie a riprendersi o rinascere quando sono state minacciate da “interludi” oligarchici e autocratici. E ci ricorda, ripensando alle immagini degli iracheni sorridenti col pollice viola dopo il voto post-Saddam, “che la democrazia è molto più di avere delle elezioni. Vuol dire accettare sé stessi come cittadini con vere responsabilità, per negoziare con le persone con cui non sei d’accordo”. Make Athens Great Again.





