
Foto Ansa
Magazine
Lontani dal mare. Dove e a che quota vivono davvero gli italiani
Il ritmo di “abbassamento" degli abitanti, il lento addio ai monti e una sorpresa. Una demografia verticale che cambia il volto del paese
Non ditelo. Non azzardatevi neppure a pensarlo. Scommetto cento contro uno che non conoscete l’altezza sul livello del mare (s.l.m.) del comune in cui abitate – se non con un’approssimazione tale che è come non conoscerla; né a cosa si riferisce questa altezza – essendo evidente che un comune non ha la stessa altezza s.l.m. in tutta quanta la sua superficie. E comunque, a maggior ragione se è così: non osate pensare che l’altezza s.l.m. dei comuni italiani oltre a non interessare ad alcuno conti quanto il due di briscola tra i tanti parametri che caratterizzano la popolazione italiana. Popolazione italiana e non semplicemente, o non soltanto, i 7.900 comuni italiani. E tuttavia, detto col cuore in mano: non avreste tutti i torti, a pensarla così. Quando mai si è vista un’elaborazione dell’altezza s.l.m. dei comuni italiani? E, meno ancora, degli italiani? Lacuna sopportabilissima, sembrerebbe, se nessuno s’è mai applicato a vedere di colmarla. Non c’è richiesta di informazioni sull’argomento, così le informazioni latitano. E diamole, allora, e se cadono nel vuoto che vuoto sia. Prima informazione. L’Italia è un paese montuoso, con due catene di monti che lo attraversano: una da est a ovest, le Alpi, e un’altra da nord a sud, gli Appennini. Lo si impara alle elementari e, in fatto di altezza s.l.m. non è che si vada molto al di là, proseguendo gli studi – a parte le ostiche suddivisioni di Alpi e Appennini che usciti da scuola in un amen si volatilizzano. Al più il monte più alto d’Italia e d’Europa: il Monte Bianco, 4.806 metri, nelle Alpi Graie. Già a indicare il monte più alto degli Appennini entriamo in grande difficoltà – è il Corno Grande, nel Gran Sasso, Abruzzo, 2.912 metri s.l.m.
Primo chiarimento: l’altezza dei comuni viene rilevata in base all’altezza s.l.m. della sede del municipio, di solito più in basso della media dell’abitato
Ma, intanto, primo chiarimento: l’altezza dei comuni viene rilevata in base all’altezza s.l.m. della sede del municipio. Ora, normalmente questa sede è ubicata in una posizione più favorevole per facilitare l’accesso dei cittadini, ovvero più in basso e in piano rispetto alla media dell’abitato. Ergo: tutti i numeri che esporremo relativi alle altezze s.l.m. dei comuni sono da considerarsi approssimati per difetto. Ciò detto, l’altezza media s.l.m. dei 7.900 comuni italiani (dei 7.900 municipi dei comuni italiani) è di 354,6 metri s.l.m. Ora, quanti leggono queste righe vivono senz’altro in grande maggioranza in comuni molto al di sotto di questa soglia, una soglia lontanissima, per esempio, dall’altezza s.l.m. delle più grandi città italiane. Le prime dieci città italiane quanto a popolazione, e altresì le sole a superare i 300 mila abitanti (nell’ordine: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania), hanno un’altezza media s.l.m. di appena 54,7 metri. Le 44 città italiane con più di 100 mila abitanti si situano mediamente solo un poco più in alto: 74,7 metri s.l.m. Solo Perugia, di queste 44 città, ha un’altezza s.l.m. superiore all’altezza media dei comuni italiani. Non basta: appena il 12 per cento delle 512 città italiane con più di 20 mila abitanti supera l’altezza media dei comuni italiani di 354,6 metri. Ma in queste città di oltre 20 mila abitanti, che rappresentano appena il 6,5 per cento dei comuni italiani, abita il 54 per cento dei 59 milioni di italiani. Ciò ci fa capire due cose. La prima: più sono popolose e più mediamente le città sono ubicate in basso. Ergo, seconda cosa: gli italiani abitano mediamente ben al di sotto dell’altezza media dei comuni italiani. Roma vale per un comune, ma ha 2 milioni e 752 mila abitanti ubicati a un’altezza media di 20 metri s.l.m. Anche Morterone vale per uno, ma ha 33 abitanti ubicati a un’altezza media di 1.070 metri s.l.m. Così, se passiamo dai comuni agli italiani, considerando quanti abitanti ha ciascun comune e affibbiando a ciascuno di questi abitanti l’altezza del comune troviamo che gli italiani abitano molto più in basso dell’altezza a cui sono mediamente situati i comuni in cui abitano. Ad oggi gli italiani abitano mediamente a poco meno di 175 metri di altezza s.l.m., esattamente alla metà dell’altezza media dei comuni italiani: conseguenza del fatto che più si sale in altezza più piccoli si fanno i comuni, meno italiani li abitano. E viceversa.
I comuni italiani a zero metri s.l.m. sono Comacchio, Taglio di Po e Lagosanto. A 2.035 metri c’è invece il più alto, Sestriere
2. Una prima curiosità è stata così soddisfatta. Ma naturalmente se ci fermassimo a questo punto resteremmo in un ambito un po’ troppo superficiale, quasi da guinness dei primati. Nel quale, prima di proseguire, dobbiamo tuttavia collocare almeno due piccole perle: sono tre i Comuni italiani a zero metri s.l.m.: Comacchio, il più grande dei tre, Taglio di Po e Lagosanto, i primi due in Veneto, il terzo in Emilia Romagna. A 2.035 metri s.l.m. si situa invece il comune di Sestriere, Piemonte, il più alto comune italiano, l’unico oltre i duemila metri di altezza. Da zero a oltre duemila: i comuni italiani non si fanno mancare niente, in fatto di altezza s.l.m.
C’è una sorta di resilienza della popolazione alla conformazione montuosa del territorio, poco adatto eppure assai popolato
E tuttavia, c’è come una resilienza della popolazione italiana alla conformazione montuosa del suo territorio, poco adatto al popolamento e tuttavia assai popolato, e alla sua stessa storia, che ha portato a edificare in montagna ben 2.487 comuni, pari al 31,5 per cento, quasi un terzo dei comuni italiani, che parrebbero destinati all’estinzione e invece ben vivi nella maggior parte – almeno quelli non già condannati da dimensioni talmente piccole (indicativamente sotto i mille abitanti) da non poter trovare in sé stessi la sufficiente vitalità demografica per tenersi a galla. La resilienza potrebbe sintetizzarsi in una formula che ha contraddistinto il movimento generale della popolazione italiana nell’ultimo mezzo secolo con riferimento, appunto, all’altezza s.l.m.: scendere, dalla montagna e dalla collina in direzione della pianura – questa è indubbiamente stata la direzione di marcia – ma con giudizio. Dove la resilienza, ça va sans dire, è tutta in quel “con giudizio”. Giudizio che sembra essere aumentato col passare degli anni. Grazie ai dati dell’Istat che al 31.12.2021 e al 31.12. 2023 affiancano a ogni comune italiano la sua altezza e gli abitanti alle due date possiamo arrivare a questa conclusione: i comuni della montagna hanno perso tra il 2021 e il 2023 30 mila abitanti, 78 mila ne hanno persi quelli di collina, 50 mila ne hanno guadagnati quelli di pianura, mentre la popolazione italiana ha perso appena 58 mila abitanti. In rapporto ai loro abitanti queste cifre diventano: una perdita di 4 abitanti ogni mille per i comuni della montagna e di 3 abitanti ogni mille per quelli della collina; un guadagno di 2 abitanti ogni mille per i comuni della pianura e ancora una perdita, lieve assai, di un abitante ogni mille abitanti per il complesso dei comuni italiani, ovvero per l’intera popolazione italiana. Variazioni assai contenute, comunque si intendano considerare. Ed è proprio questa la conclusione che ci porta a parlare di resilienza. In questo contenimento dei danni gioca un ruolo decisivo il movimento migratorio con l’estero e l’aspetto che colpisce è l’insospettata capacità anche della montagna di giovarsene positivamente.
3. Quelle minime variazioni possono essere tradotte in metri, addirittura in centimetri grazie all’operazione di attribuire a ciascun italiano l’altezza s.l.m. del comune nel quale abita. E’ chiaro che in ogni comune c’è chi sta più in alto e chi più in basso del Municipio rispetto al quale è calcolata l’altezza s.l.m., ma vale il gioco della media. Tra il 2021 e il 2023 in termini di altezza s.l.m. gli abitanti della montagna sono scesi mediamente di 0,7 metri (da 520,8 a 520,1 metri s.l.m.), come quelli della collina, scesi anch’essi di 0,7 metri (da 262,4 a 261,7); sono invece rimasti al loro livello medio di 78,5 metri s.l.m. gli abitanti della pianura, mentre gli italiani hanno perso mezzo metro, scendendo da 175,4 a 174,9 metri s.l.m. Cosa dobbiamo pensare di queste minime variazioni? Intanto che nel loro minimalismo lasciano pur sempre intendere che la popolazione scende, lentissimamente ma scende, sul livello del mare, in direzione delle pianure – come già detto. In secondo luogo che tra montagna e collina il movimento verso la pianura, prima assai diversificato, raffreddandosi è andato altresì uniformandosi: perdono le zone altimetriche della montagna e della collina a favore della pianura e dei comuni della pianura: ma perdono poco, e meno del passato. Dobbiamo tuttavia annotare che i due anni tra il 2021 e il 2023 rappresentano pur sempre un periodo davvero stretto per valutazioni come queste, valutazioni che hanno però il pregio dell’attualità. In termini di attualità potremmo tradurre tutto ciò che siamo venuti fin qui dicendo nella constatazione che lo spopolamento della montagna (e in secundis della collina) non è così esteso, profondo e soprattutto veloce come saremmo portati a pensare.
A soffrire, a soffrire davvero, sono i comuni ad un tempo di montagna (e collina) e con una popolazione troppo ridotta. I comuni con meno di mille abitanti sono in Italia la cifra spropositata di 2.020 (più di un quarto dei comuni italiani) dei quali i tre quarti situati nelle zone altimetriche della collina e della montagna: questi comuni, con una popolazione complessiva di un milione e 80 mila abitanti, per una media di 526 abitanti a comune, hanno perso nei due anni il 15 per mille (l’1,5 per cento) della loro popolazione: in proporzione 15 volte la perdita di abitanti della popolazione italiana e 4 e 5 volte la perdita di abitanti rispettivamente della montagna e della collina. Tra di essi ci sono 245 comuni che non arrivano a 200 abitanti. Questi ultimi hanno perso nei due anni considerati il 21 per mille, oltre il 2 per cento della loro popolazione, a una media di oltre l’1 per cento l’anno che non promette loro un altro secolo di vita. Coi loro poco più di 32 mila abitanti appollaiati mediamente attorno ai 750 metri di altezza s.l.m. rappresentano vestigia di un passato che non può continuare. E ciò vale per tutti o quasi i comuni di meno di mille abitanti e per buona parte di quegli altri 2.440 comuni con una popolazione che va da mille a meno di 3mila abitanti. Una politica d’area, di territorio, capace di accorpare amministrativamente, funzionalmente e da un punto di vista socio-economico questi comuni si impone tanto per la sopravvivenza degli stessi che per provare a controllare il ritmo di abbassamento, se possiamo chiamarlo così, della popolazione italiana – a maggior ragione in considerazione della buona tenuta del resto dei comuni, anche della stessa montagna.
4. E veniamo infine alle regioni. Non c’è il minimo dubbio che se chiedessimo agli italiani quali sono le prime due regioni secondo l’altezza s.l.m. dei loro abitanti la risposta sarebbe univoca. Prima: Valle d’Aosta, seconda: Trentino Alto Adige. Attorno al terzo gradino del podio osserveremmo invece la più avvolgente delle incertezze. Il terzo gradino del podio, infatti, si svela immediatamente se solo osserviamo che la seconda regione per altezza s.l.m. dei suoi abitanti non è il Trentino Alto Adige bensì – chi se lo aspetterebbe? – la Basilicata. Perché se diciamo che al secondo posto c’è la Basilicata diventa automatico spostare il Trentino dal secondo, dove pensavamo che stesse, al terzo posto – dove invece lo collocano calcoli precisi. In base a questi calcoli, dunque, gli abitanti della Valle d’Aosta vivono mediamente a 711,2 metri s.l.m.; quelli della Basilicata a 556,3 metri s.l.m.; quelli del Trentino Alto Adige a 547,6 metri s.l.m. Una differenza di neppure 9 metri separa gli abitanti delle due regioni che occupano la seconda e la terza posizione. Un soffio, ma così sono le classifiche. La classifica delle regioni, del resto, non si ferma a questa sorpresa. Al quarto posto c’è il Molise (498,3), al quinto l’Umbria (350,5), al sesto l’Abruzzo (322,5), al settimo praticamente appaiati il Piemonte (288,2) e la Calabria (286,2). Cosicché appare piuttosto evidente il primato delle regioni del Mezzogiorno su quelle del Nord. Primato confermato dal fatto che delle 9 regioni i cui abitanti vivono al di sopra dei 200 metri s.l.m. solo tre sono del Nord (oltre alla Valle d’Aosta e al Trentino anche il Piemonte); una del Centro (appunto l’Umbria); ben cinque del Mezzogiorno (oltre alla Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria e Sicilia).
A dispetto di quanto si potrebbe pensare, sono soprattutto gli abitanti del sud a vivere su monti e colline. E le spiagge assolate? E i mari cristallini?
A vivere su monti e colline sono insomma ben più degli abitanti del Nord quelli del Mezzogiorno. E le spiagge assolate? I mari cristallini? Mettiamola così: tutta la piattezza, nel senso di pianura, nel senso di terra che s’alza di poco, di pochissimo, sul livello del mare è al Nord. Ci sono solo quattro regioni i cui abitanti vivono mediamente al di sotto, ben al di sotto, dei 100 metri s.l.m., tutte del Nord, nell’ordine: Liguria (56,1 metri s.l.m.), Veneto (79,5), Emilia Romagna (82,9) e Friuli Venezia Giulia (86,9). I due terzi dei comuni italiani a meno di 100 metri s.l.m. sono situati al Nord: la Pianura Padana, il Po con i suoi 642 km di percorso e il suo delta sull’Adriatico, le spiagge della Liguria, del Veneto, della Romagna, vincono, se possiamo dir così, sull’arcigna maestosità delle Alpi. Diversamente, i così sottovalutati Appennini si spingono fin sulle coste di gran parte del Mezzogiorno, lo invadono, lo stringono dappresso, lasciando spazi più risicati per le pianure, i comuni delle pianure e gli abitanti delle pianure. Il peso condizionante della montuosità è al Sud che si manifesta più largamente che al Nord. Non ci avremmo scommesso.
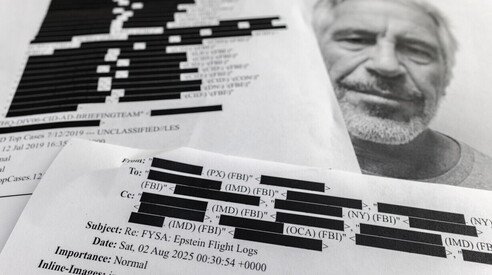

giustizia e non solo
L'effetto "Drive-in" della sinistra sul referendum



