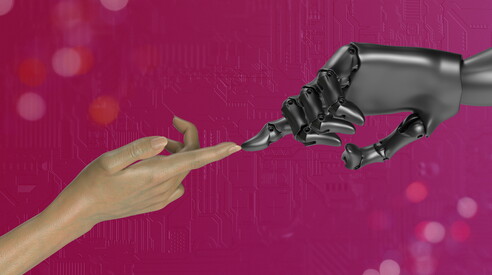Foto LaPresse
il tic
Io dazio da sola. Come spiegare a un americano il concetto di "ristori"
Nella cavalleresca cultura italiana dell’indennizzo non c’è verso di instillare il volgare concetto di rischio di impresa. Con gli Stati Uniti siamo fatti per non capirci: un paese basato sulle mance ai lavoratori contro un paese basato sulle mance alle aziende
Insomma ieri sono partiti ufficialmente i dazi, e il 7 agosto tra la pizzica e la taranta e la polenta verrà ricordato come la sagra delle “tariffe”; per la Ue sono al 15 per cento (ma non si sa cosa succederà ai vini, all’acciaio, se saremo graziati o ancor più cornuti e daziati. E se non terremo fede ai 600 miliardi di investimenti negli Usa potremmo salire al 35!). Certo gli svizzeri stanno peggio, al 39 per cento (vedi a essere neutrali!). Altri sono daziatissimi e cornutissimi (per motivi astrusi India e Brasile 50 per cento). Qualcuno però non è catastrofista: se tutto questo daziare dovrebbe far entrare nelle casse americane circa 300 miliardi di dollari l’anno, il cancelliere tedesco Merz ha ammesso sommessamente che forse, sì, noi europei ci abbiamo un po’ marciato, con l’America, e che sì, i dazi sono un po’ un problema però è chiaro che “dobbiamo fare qualcosa di più”, insomma la nostra parte.
Intanto, in Italia è subito scattato il più italico dei tic, la più deliziosa parola del vocabolario italiano, che non è “benigno” né “bonifico” bensì “ristori”. Cioè quando qualcosa va male, che siamo balneari o tassisti o altre categorie di imprenditori, subito lo stato deve “ristorare”. La gloriosa epoca dei “Dipiciemme” covidici ci ricorda il Decreto Ristori bis, ter, quater e quinquies. "Ristori", questa amabile parola, evoca dolci salvataggi (un po’ come l’affascinante conte Ristori interpretato da Alessandro Preziosi in “Elisa di Rivombrosa”) e titilla l’italico orecchio. Le imprese sono pronte a chiederli, il governo frena. “Continuiamo a stare al fianco dei nostri produttori", ha detto Giorgia Meloni ma “Alla fine, soltanto alla fine, si potrà fare un bilancio, soprattutto tarato sul nostro tipo di economia”, risponde il ministro Giorgetti. E intanto pure il “Decreto ristori” o “Decreto indennizzi” per i balneari è stato sonoramente bocciato dalla Commissione europea (i balneari volevano essere risarciti degli investimenti fatti, nel caso non riuscissero a impostare una successione millenaria di lettini e ombrelloni feudali). In questa cavalleresca cultura italiana dell’indennizzo non c’è verso di instillare il volgare concetto di rischio di impresa. “I dazi fanno parte del rischio d’impresa. Non potete pretendere che i contribuenti paghino per tutte le insidie dello scenario internazionale” ha detto qualche giorno fa a Repubblica Lorenzo Codogno, ex capo economista del Mef.
Ma niente, i ristori sono una cosa molto italiana, direbbe Stanis Larochelle di Boris: e peraltro intesi sempre e solo dal lato dell’impresa, perché nel paese col minor senso della “customer satisfaction” al mondo, farvi ristorare un disservizio voi, clienti, è impossibile e volgare. Non sta bene, non si fa. Qualche settimana fa (signora mia) ho noleggiato un’auto a Milano. L’auto era sporca, danneggiata, mi ha fermato pure la polizia e risultava essere stata rubata in passato (da cui molte seccature). La compagnia non l’ha ritenuto un disservizio abbastanza disservizio per rimborsarmi, pardon, ristorarmi. In America forse mi avrebbero dato un’auto gratis, forse a vita. E i rimborsi dei treni? In un’epoca aurea mi pare di ricordare che arrivassero in automatico. Adesso, per ovvi motivi (se ogni cliente vittima di un ritardo dovesse essere ristorato, fallirebbe immediatamente Trenitalia), è diventato complicatissimo. Da 60 minuti in poi ti rimborsano o ristorano il 25 per cento del biglietto. Il 25 per cento! Per un'ora! E per restituirti tutto, di quanto deve essere in ritardo il convoglio? Di un quinquennio? Un secolo? Ma poi c’è anche una procedura “smart refund” (quando c’è l’inglese è sempre in agguato il rischio sòla, e infatti non funziona, il server dice “pagina non trovata”, il cliente, a quel punto, non ristorato, demorde). Ma anche, forse per radici cristiane, senso di colpa o chissaché, restituire un qualunque acquisto in Italia pare brutto, e tutti ci teniamo in casa scarpe grandi o capetti di due taglie in meno che non abbiamo mai osato farci rimborsare perché sappiamo che il commesso dal sopracciglio alzato risponderebbe offesissimo: “le posso dare un buono”, mentre la cultura del refund (poco smart e molto efficace) è parte stessa dell’America. Soldi in mano, un bel sorriso, e via. Così comprerai di nuovo, e di più. In Italia invece le imprese non vogliono ristorare nessuno, ma amano tantissimo essere ristorate. Come spiegarlo a un americano? Agli americani che sì, probabilmente beneficeranno dei dazi, che forse serviranno ad abbassargli le tasse, ma vivono anche nella società della customer satisfaction, e del rischio di impresa, estremi. Come spiegare che le imprese italiane vogliono i soldi dello stato italiano se uno stato estero gli aumenta i prezzi?
Il povero americano che ha le ferie, cioè una settimana, due se va bene, all’anno, mica due mesi come noi, arriva in Italia e deve cercare lui di essere simpatico al cameriere, altrimenti non mangerà; e sorridere lui al commesso malmostoso che sbufferà (certo, in America ti sorridono non perché sono più buoni, ma perché vogliono la mancia). Poi quando torna in America avrà la nostalgia della arugula e del parmesan ma non del customer service dell’Italia, il paese dove il cliente ha sempre torto. E però codesto americano magari una volta in patria non avrà più il lavoro (provate a spiegare loro l’idea di posto fisso, non esiste manco la dicitura). O non ci sarà più proprio l’impresa, fallita o assorbita o scalata. E, a parte qualche calamità agricola, chiederà aiuti allo Stato? Ma, anche qui, non esiste neanche il sostantivo, e dunque the thing (si dice infatti “government’s money”, e già cambia tutto, se dici “state” non comprendono). Insomma, siamo fatti per non capirci, un paese basato sulle mance ai lavoratori contro un paese basato sulle mance alle imprese (però là i lavoratori con la mancia sorridono molto, qua le imprese ristoratissime sono sempre incazzatissime, non è mica giusto, vabbè).

L'editoriale dell'elefantino