
LaPresse
la lettera
Il ceto medio declina, sì, ma quale? Welfare e insalata mista
Disuguaglianze interne, welfare debole e responsabilità eluse. Questo presunto declino del ceto medio, del suo status e dei suoi livelli di reddito, non si presta a facili semplificazioni
Al direttore - Verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso, la questione del ceto medio diventò centrale nel dibattito pubblico dopo la pubblicazione del celebre “Saggio sulle classi sociali” di Paolo Sylos Labini (1974). L’allievo di Joseph Schumpeter, mettendo in discussione un mantra della vulgata marxista, mostrava il peso crescente dei ceti medi (al plurale), soprattutto della piccola borghesia del settore agricolo, dell’artigianato e del commercio (i famigerati “topi nel formaggio”). E, pur riconoscendone l’importanza, lo attribuiva soprattutto alle politiche clientelari messe in campo dalla Dc. Sulla questione del suo declino sociale è tornato Ilvo Diamanti, curatore di un sondaggio Demos (la Repubblica). Mi permetto di osservare che questo presunto declino del ceto medio – del suo status come dei suoi livelli di reddito – non si presta a facili semplificazioni. L’attenzione, infatti, andrebbe rivolta più sull’allargamento della forbice tra il suo strato superiore e quello inferiore, ovvero sulle disuguaglianze create da questa divaricazione. Tendenza analizzata per primo da Charles Wright Mills nella sua monumentale ricerca sui “colletti bianchi” del 1951. In verità, come ci ha spiegato Arnaldo Bagnasco, una classe media non è mai esistita. Infatti, “la classe media è un’insalata mista di occupazioni, una nebulosa che comprende lavoratori indipendenti (come artigiani, piccoli e medi imprenditori) e dipendenti (come gli impiegati pubblici e privati)”. Quando ci si vuol riferire a un insieme che supera e comprende tali diversità, entra allora in gioco il termine ceto, che indica una vicinanza di tratti culturali, stili di vita, modelli di consumo, effetto anche di scelte politiche.
La famigerata questione sociale, quindi, non riguarda solo il tasso di disuguaglianza, chi ha un basso salario, un impiego precario ed è escluso o staziona ai margini della “città del lavoro”. Essa chiama in causa l’assetto complessivo del nostro welfare. Agli inizi degli anni Cinquanta, Thomas Marshall poteva sostenere che nel welfare state in via di costruzione era implicita una tensione verso l’eguaglianza. Alla prova dei fatti, questo pronostico si è rivelato un abbaglio. Basti pensare all’incapacità, anche nelle sue versioni più interventiste, di estirpare le forme più dure e mortificanti di povertà come le stesse radici maschiliste dell’apparato dei diritti di cittadinanza. L’esperienza storica del welfare, in altri termini, porta ad affermare una tesi esattamente opposta a quella del sociologo inglese, che solo i moralisti accademici della sinistra possono ignorare, e cioè che libertà ed eguaglianza possono entrare in conflitto tra loro. Anche perché le protezioni sociali dipendono, in una misura che non ha confronto con i diritti civili e politici, dalle risorse create dal mercato. Sfidati dai cambiamenti demografici, della famiglia e del lavoro, i sistemi di welfare sono sulla graticola dei governi da quando non è stato più possibile pagarli aumentando le tasse. Sono stati finanziati indebitandosi. E il debito, prima o poi, occorre restituirlo. Purtroppo, la classe politica italiana è apparsa insensibile a questo monito. “Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci, non compromettersi, rimandare la scelta; tenere i piedi in due staffe, il doppio giuoco, il tempo rimedia a tutto, tira a campare”, diceva Piero Calamandrei. “E’ meglio tirare a campare che tirare le cuoia”, rispondeva idealmente all’insigne giurista il “totus politicus” Giulio Andreotti. Tutti e due, seppure con intenti opposti, avevano colto acutamente uno dei tratti distintivi del nostro carattere nazionale. Per altro verso, è stato un conservatore disincantato come Giuseppe Prezzolini, fondatore della Congregazione degli Apoti (cioè di “coloro che non se la bevono”), a sostenere che da noi non ci sono né antenati né posteri: ci sono solo contemporanei. Un “contemporaneismo” autoassolutorio, una sorta di liberatoria delle responsabilità avute nei confronti delle generazioni passate e delle responsabilità che si dovrebbero avere verso le generazioni future.
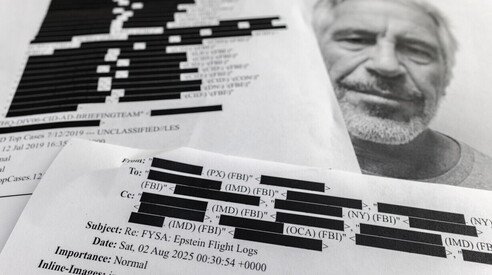

giustizia e non solo
L'effetto "Drive-in" della sinistra sul referendum



