
Ansa
Cattivi scienziati
Per comprendere la guerra occorre considerare la storia evolutiva del comportamento sociale
Secondo uno studio sugli scimpanzé, pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Sciences, il conflitto nasce perché conviene dal punto di vista evolutivo e non come deviazione culturale. Ma "la guerra umana contemporanea si innesta su traiettorie che travalicano il modello biologico primatologico"
La domanda “come è nata la guerra?” — intesa come conflitto organizzato tra gruppi — trova oggi risposta in un nuovo contributo significativo che proviene dalla ricerca sul comportamento dei nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé. Uno studio pubblicato di recente nei Proceedings of the National Academy of Sciences mette in luce che nei gruppi di scimpanzé selvatici una forma di aggressione intergruppo letale può tradursi in un aumento della dimensione del territorio e, conseguentemente, in un vantaggio riproduttivo per i vincitori. Questo dato fa da ponte tra l’etologia comparata e l’evoluzione dei conflitti umani, offrendo così elementi di riflessione sulla genesi della guerra nei nostri antenati.
In concreto, il gruppo di scimpanzé studiato appartiene alla comunità di scimpanzé di Ngogo, nel parco nazionale di Kibale National Park in Uganda, osservata da decenni: gli autori (tra cui i primatologi Brian Wood e John Mitani) hanno documentato che in seguito a una serie di attacchi coordinati contro un gruppo vicino — che hanno causato la morte di almeno 21 individui — il territorio del gruppo vittorioso è aumentato del 22%. Dopo l’espansione territoriale, le femmine del gruppo hanno partorito molti più cuccioli (da 15 in tre anni a 37 nei tre anni successivi) e la mortalità infantile entro i tre anni è scesa dal 41% all’8%. Gli autori hanno escluso che il miglioramento possa essere attribuito semplicemente a un aumento della disponibilità di frutti: i dati indicano che la fruttificazione nella parte "originaria" del territorio è rimasta stabile o è persino calata.
Essi ne concludono che l’aggressione intergruppo, la conquista di nuovi spazi e il miglioramento delle condizioni riproduttive per i vincitori vanno letti come un meccanismo evolutivo attivo. Se accettiamo questo quadro come valido — ed è un quadro ben sostenuto dai dati dello studio — emerge un’ipotesi forte: la guerra, intesa come conflitto organizzato per la conquista o la difesa di risorse territoriali, può essere considerata un comportamento favorito almeno in parte dalla selezione naturale nel contesto animale, e quindi plausibilmente presente anche nelle origini del genere Homo. Nei gruppi di primati da cui deriviamo, la capacità di coalizzarsi contro gruppi esterni, di vincere, di acquisire risorse e spazio vitale, si traduceva in un miglior successo riproduttivo — analogamente a quanto mostrato negli scimpanzé. In altri termini: la guerra nasce perché conviene dal punto di vista evolutivo — almeno in certe condizioni ecologiche — e non come una deviazione culturale, ma come possibile esito della dinamica sociale e territoriale dei primati.
Occorre tuttavia precisare che questo modello non è esaustivo né rigidamente deterministico. In primo luogo, gli scimpanzé pure mostrano variabilità: non tutti i gruppi manifestano aggressioni letali e non a tutte le espansioni territoriali seguono conflitti. In secondo luogo, la trasposizione diretta al genere Homo richiede cautela: gli Homo hanno capacità simboliche, complesse strutture socio-culturali, cooperazione su scala molto più ampia, tecnologia e linguaggio — elementi che modulano e spesso amplificano o mitigano l’aggressività intergruppo. Gli autori dello stesso studio lo riconoscono: "Gli umani hanno, fortunatamente, sviluppato una straordinaria capacità di risolvere e evitare tali conflitti", afferma Wood. In terzo luogo, non si deve ignorare che la guerra umana contemporanea si innesta su traiettorie storiche, ideologiche, economiche e tecnologiche che travalicano largamente il modello biologico primatologico.
Ma l’importanza della ricerca resta rilevante: essa fornisce una "prova diretta" della connessione tra aggressione intergruppo, guadagno territoriale e successo riproduttivo nei primati selvatici — un dato che consolida precedenti osservazioni (es. sugli infanticidi e sulle coalizioni maschili tra scimpanzé) in un quadro evoluzionistico integrato. Questo rafforza l’idea che per comprendere l’origine della guerra occorre considerare la storia evolutiva del comportamento sociale e del conflitto, e che le radici della cooperazione e del conflitto risalgono a ben prima dell’emergere della nostra specie, come due facce della stessa medaglia.
Per chi si occupa di origini umane questa ricerca invita a riformulare la domanda: non solo “perché gli esseri umani fanno la guerra”, ma “in quale contesto evolutivo la predisposizione al conflitto intergruppo è stata selezionata”. Il contesto che lo studio mette a fuoco è quello della competizione territoriale, della acquisizione di risorse e della pressione riproduttiva — in condizioni in cui le femmine e i piccoli beneficiano del controllo di un’area ampliata.
Ne consegue che la guerra può essere vista non tanto come un’aberrazione civile, quanto come un’estensione storica di un carattere adattivo dei primati: la capacità di formare coalizioni, di discriminare "noi" da "loro", di lottare per territorio e risorse. Se questo è vero, la sfida etica e politica umana diventa trasformare una potenzialità biologica (la conflittualità) in una capacità culturale di cooperazione estesa, di gestione pacifica delle risorse e di costruzione di istituzioni che trasformino la condizione di gioco a "somma zero" implicita in molti conflitti territoriali primitivi.

cattivi scienziati
Perchè serve riportare sui dati la discussione sul digiuno intermittente

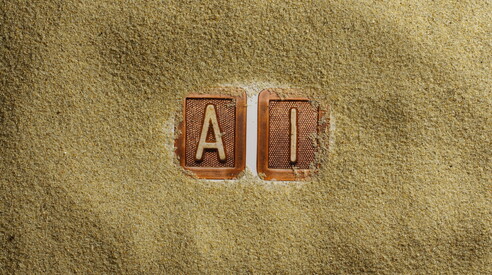
cattivi scienziati


