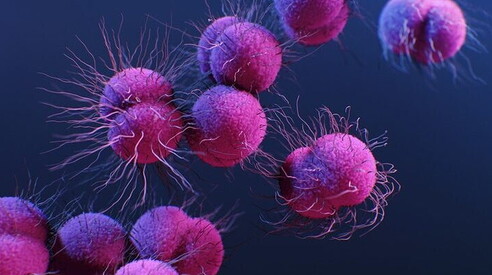Ansa
Cattivi scienziati
Negli articoli scientifici il punto fondamentale è comunicare bene i numeri
Lo studio del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori è un lavoro ampio e merita perciò una comunicazione accurata. Un risultato buono, espresso insieme al suo margine di incertezza, è più forte della retorica di chi vuole i vaccini infallibili, ed è più solido delle convinzioni assolute di chi li rifiuta a priori
L’articolo del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori recentemente pubblicato è un lavoro di ampio respiro, ricco di dati e utile per aggiornare il quadro complessivo su efficacia e sicurezza dei vaccini contro Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV). Proprio per questo, però, merita una comunicazione accurata.
Anche se gli stessi autori dichiarano limiti chiari - solo il dodici per cento degli studi inclusi è costituito da trial controllati, più della metà presenta un rischio di bias almeno moderato e non è stato applicato il metodo GRADE per valutare la qualità complessiva delle prove - i risultati di efficacia sono solidi. I vaccini a mRNA aggiornati riducono il rischio di ricovero per Covid-19 di circa la metà negli adulti e del 56 per cento negli anziani; nei soggetti immunocompromessi la protezione scende al 37 per cento. I vaccini antinfluenzali riducono i ricoveri del 60–70 per cento nei bambini e del 40–50 per cento negli adulti, e i nuovi vaccini o anticorpi contro RSV riducono fino all’80 per cento i ricoveri dei neonati, anche se per ora i dati coprono una sola stagione virale.
Il punto più delicato è l’interpretazione dei risultati di sicurezza, per esempio in gravidanza. Nei commenti che hanno seguito la pubblicazione, l’espressione “nessuna associazione” è stata spesso intesa come “associazione esclusa”. Ma nel linguaggio statistico questo non è corretto. Dire “nessuna associazione” non significa che il rischio sia stato escluso, ma che non è possibile, con le misure fatte, prendere decisioni attendibili circa la consistenza dell’effetto che si sta valutando, con il grado di significatività statistica prescelto. In altre parole, i dati disponibili non permettono di affermare se esista o meno un effetto, né di definirne con precisione la dimensione. È una formula tecnica che indica che, con le prove disponibili e con il grado di affidabilità ricercato, l’effetto non può essere determinato con sicurezza. Per capire bene questo punto, occorre chiarire che cosa rappresentano il p-value e il cosiddetto “intervallo di confidenza”. Quest’ultimo termine, per quanto tradizionale, può trarre in inganno, perché sembra alludere a un margine di fiducia personale. In realtà, nel caso che qui ci interessa, quello della valutazione della sicurezza di un trattamento, ciò che questo intervallo mostra è l’insieme dei valori del rischio relativo compatibili con i dati raccolti. Per questo oggi è più corretto parlare di intervallo di compatibilità: esso non misura la fiducia del ricercatore, ma la coerenza fra ipotesi di rischiosità e osservazioni.
Quando il rischio è, come in clinica, espresso da un rapporto — come rischio relativo (RR), odds ratio (OR) o hazard ratio (HR) — l’interpretazione del significato dell’intervallo di compatibilità segue una regola precisa. Se sta tutto sotto il valore 1, i dati sono compatibili esclusivamente con ipotesi di riduzione del rischio; se sta tutto sopra 1, con un aumento; se attraversa 1, significa che i dati sono compatibili sia con l’assenza di differenza fra chi è stato trattato e chi no, sia con la possibilità di una variazione del rischio (in positivo o in negativo) reale, ma comunque non dimostrata con il livello di affidabilità prescelto. Il p-value, a sua volta, misura quanto sarebbe probabile ottenere per puro caso effetti uguali o più estremi di quelli osservati se, in realtà, non vi fosse alcuna differenza tra i gruppi trattati e non trattati. Se è minore della soglia convenzionale di 0,05, i dati sono poco compatibili con l’ipotesi di assenza di effetto; se è maggiore, significa che, con quella soglia di affidabilità, non possiamo escludere che la differenza sia dovuta al caso. Ma questo non equivale a dire che l’effetto non esista: indica semplicemente che le evidenze non consentono, per ora, di stimarne con precisione l’ampiezza o la direzione.
Applichiamo queste considerazioni al lavoro del NEJM, per esempio nel caso della vaccinazione materna contro RSV con il vaccino RSVpreF. Per il parto pretermine, l’articolo riporta tre stime principali: un rischio relativo di 1,01 con intervallo di compatibilità da 0,89 a 1,15; un altro di 1,20 con intervallo 0,98–1,46; e un odds ratio di 1,03 con intervallo 0,55–1,93. Tutti attraversano il valore 1, e quindi i p-value sono superiori a 0,05. Con la soglia di affidabilità adottata, i dati non permettono di affermare che esista un aumento di rischio, ma neppure di escluderlo del tutto. Nel caso 1,20 (0,98–1,46), per esempio, i risultati sono compatibili tanto con nessuna differenza quanto con un aumento del rischio fino al 46%. “Nessuna associazione”, o anche “p non significativo”, dunque, non implicano che il rischio sia nullo, ma che i dati disponibili non consentono, con il livello di precisione statistica adottato, di prendere decisioni affidabili sulla consistenza dell’effetto che si sta indagando.
Lo stesso tipo di ragionamento vale per i vaccini a mRNA in gravidanza. Per l’aborto spontaneo, per esempio, gli odds ratio aggiustati sono vicini a 1, con intervalli ampi: uno studio riporta 0,97 (0,57–1,66), un altro 0,59 (0,29–1,19). Anche qui, gli intervalli attraversano 1, il che significa che i dati sono compatibili sia con nessuna differenza, sia con una piccola riduzione o un piccolo aumento del rischio. Per il parto pretermine, alcune stime restano sotto 1 con intervalli che non comprendono 1 (per esempio 0,7–0,8), suggerendo una possibile riduzione del rischio; altre, invece, includono 1 e quindi non permettono di concludere se l’effetto ci sia o meno. La stessa logica si applica alla co-somministrazione dei vaccini. La maggior parte degli studi mostra risposte immunitarie adeguate quando vaccini contro Covid-19, influenza e RSV vengono somministrati insieme; in alcuni casi, però, le analisi non riescono a dimostrare in modo netto che la risposta sia esattamente uguale a quella ottenuta somministrandoli separatamente. Anche qui, un p-value sopra 0,05 non significa che la risposta immunitaria combinata sia inferiore, ma solo che, con la soglia di affidabilità prescelta, i dati non bastano per dichiarare equivalenza completa. È un invito alla precisione delle parole, non un allarme sanitario.
Rimettendo tutto in prospettiva, il messaggio che emerge è chiaro: i vaccini respiratori riducono in modo consistente il rischio di malattia grave; in gravidanza non si osservano segnali solidi di rischio aumentato per gli esiti principali, e per alcuni vaccini si notano tendenze favorevoli, come una minore incidenza di parto pretermine. Tuttavia, per alcuni esiti e per alcune popolazioni gli intervalli di compatibilità restano ampi: piccoli aumenti o riduzioni del rischio non possono essere esclusi. La scienza, qui, non parla in bianco e nero: mostra ciò che appare probabile e ciò che resta da chiarire. Il punto non è usare questo studio per dire che “è tutto sicuro e la discussione è chiusa”, né per insinuare dubbi infondati. Il punto è comunicare bene i numeri. Un risultato buono, espresso insieme al suo margine di incertezza, è più convincente di qualunque certezza inventata. È più forte della retorica di chi vuole i vaccini infallibili, ed è infinitamente più solido delle convinzioni assolute di chi li rifiuta a priori.
Certo, qualcuno obietterà che questo linguaggio appartiene agli scienziati e che sui social o sui giornali servono messaggi “chiari”. Ma la chiarezza non nasce dalla semplificazione, se si perde la precisione, inducendo credenze non realistiche. Dire che un effetto non è dimostrato non è un modo per non prendere posizione, ma per prenderne una fondata sui dati. Non si tratta di prudenza né di ambiguità: è trasparenza. Comunicare che i risultati positivi parlano da soli, anche nel loro margine di incertezza, è più efficace di qualunque slogan, perché la ricerca non ha bisogno di urlare certezze per essere credibile, ma di dire la verità, intera e comprensibile. I vaccini meritano di essere difesi per quello che sono: strumenti che riducono davvero il rischio di ammalarsi gravemente, all’interno di margini di incertezza che la scienza misura e dichiara apertamente. Raccontarli così, con rigore e onestà, è il modo migliore per far parlare i dati da soli e per preservare ciò che davvero dà forza alla scienza: la trasparenza nel dire non solo ciò che sappiamo, ma anche quanto e fino a che punto lo sappiamo.
Tutto il contrario degli antivaccinismi che, senza metodo, gridano contro i vaccini ed agitano argomenti preconcetti, infondati, malformati o persino fraudolenti; vediamo, almeno noi, di non confonderci con loro.

cattivi scienziati