
Ansa
Cattivi scienziati
Addio a Jane Goodall, pioniera di un nuovo modo di fare ricerca
La fabbricazione di strumenti, la violenza organizzata, l’empatia, la tradizione: tutti questi tratti, che usavamo per definire la nostra “natura”, si dispongono ora su scale condivise. Come già Darwin prima di lei, ci ha tolto dal piedistallo per restituirci più responsabilmente al mondo vivente
Se n’è andata a 91 anni Jane Goodall, e con lei una delle figure più luminose della scienza del Novecento. Non è esagerato dire che il suo sguardo ha cambiato per sempre il modo in cui gli esseri umani vedono sé stessi e gli altri animali. Quando nel 1960 arrivò sulle rive del lago Tanganica, in Tanzania, nessuno poteva immaginare che quella giovane donna senza una formazione accademica convenzionale avrebbe rivoluzionato l’etologia, mettendo in discussione confini che sembravano scolpiti nella roccia. Le sue osservazioni sui nostri parenti più stretti, gli scimpanzé, ci hanno obbligato a ricalibrare la mappa mentale dell’“umano”, spostando il baricentro da una presunta eccezionalità ontologica a una continuità evolutiva.
Il primo colpo clamoroso arrivò nell’ottobre del 1960: Jane vide uno scimpanzé piegare un rametto, spogliarlo delle foglie e usarlo per pescare termiti dal termitaio. In quella scena, apparentemente semplice, crollava un dogma: la fabbricazione di utensili non era più esclusiva dell’uomo. L’articolo scientifico che seguì, pubblicato nel 1964, rese esplicito il punto: la capacità di concepire uno scopo, trasformare un mezzo e impiegarlo in modo flessibile ha radici che non iniziano con Homo. Le implicazioni furono filosofiche prima ancora che biologiche: se anche altri animali progettano e manipolano strumenti, allora l’intenzionalità pratica non è un discrimine netto, ma un gradiente. Da quel momento, lo “specifico umano” che ci collocava su un piedistallo, identificato proprio nella capacità di fabbricare strumenti con un fine preciso e di insegnare ad altri membri del gruppo a farlo, divenne un tratto comune lungo molte linee evolutive distinte.
Nello stesso anno Goodall documentò un’altra verità inattesa: gli scimpanzé non sono solo vegetariani, come si pensava, ma anche predatori organizzati. Li osservò cacciare colobi e altri piccoli mammiferi e condividere la carne all’interno del gruppo. Anche qui la portata fu epocale. La dieta onnivora, con episodi coordinati di caccia, ridefiniva l’ecologia comportamentale degli scimpanzé e, per riflesso, spingeva a riconsiderare scenari sull’emergere di cooperazione, scambio e alleanze anche nella nostra linea. In decenni di ricerche successive, l’idea che la carne possa avere un ruolo non solo nutrizionale ma anche sociale (moneta per cementare legami, favori, accessi) è stata ripresa e discussa, mostrando quanto quel primo tassello osservativo avesse aperto un fronte di studio duraturo. La “dolce innocenza” del primate, trasposizione dello stato di natura di Rousseau, era, alla prova dei fatti, inesistente.
Non meno sconvolgente fu la rivelazione che la violenza pianificata e di gruppo non è un’invenzione esclusivamente umana. La lunga osservazione a Gombe mostrò scissioni di comunità, pattugliamenti di confine, spedizioni, imboscate e uccisioni: una dinamica di guerra intergruppo che, anni dopo, altri siti e metodi confermarono, collegandola perfino all’espansione territoriale dei vincitori. La lezione, qui, toccava un nervo scoperto della nostra autocomprensione: l’aggressività letale pianificata non nasce con la cultura umana, ma è invece una possibilità evolutiva che condividiamo, e che in alcune condizioni ecologiche si attualizza. Capire questo quadro non significa naturalizzare la guerra; significa sottrarla al mito della “eccezione morale” e ricollocarla in un paesaggio comparato, dove ecologia, demografia e opportunità definiscono rischi e freni.
Ma il suo lavoro non raccontò solo brutalità. Goodall descrisse con minuzia la tenerezza che lega madri e piccoli negli scimpanzè, la forza dei legami familiari e la capacità di compassione. Vide adozioni di orfani da parte di adulti non imparentati, comportamenti di conforto dopo aggressioni, abbracci che riducevano i segni di stress nel destinatario. Anche qui il confine si spostava: se gesti prosociali, cura e consolazione si ritrovano in un’altra specie, allora i mattoni dell’empatia hanno una storia naturale che non coincide con l’umano, ma lo precede e lo accompagna.
L’eredità di Jane Goodall va però oltre l’elenco delle scoperte. Fu una pioniera di un nuovo modo di fare ricerca: non più animali numerati e distanti, ma individui riconosciuti con nomi e storie personali, seguiti per decenni. Quella scelta, contestata all’inizio come “antropomorfismo”, si rivelò metodologicamente feconda: per capire società complesse servono identità, biografie, relazioni; serve una lente temporale abbastanza ampia da vedere le traiettorie di status, parentela, alleanze, trasmissione sociale. Non a caso, proprio lungo la scia di quegli studi, emerse con forza l’idea di “culture” negli scimpanzé: repertori comportamentali diversi tra popolazioni, trasmessi socialmente, che non si spiegano solo con ecologia o genetica. Se anche la cultura è un gradiente, allora il nostro posto fra gli animali non è il di fuori, ma un punto avanzato di un continuum di apprendimenti e tradizioni.
La rivoluzione cognitiva e morale che ne seguì non rimase nei libri. Goodall trasformò la sua autorità scientifica in un impegno civile instancabile, fondando istituti e programmi educativi, e contribuendo—insieme a tanti altri ricercatori e attivisti—al mutamento delle cornici etico-giuridiche sul trattamento dei grandi primati. Nel 2015 il National Institutes of Health annunciò la fine del programma di ricerca biomedica sugli scimpanzé negli Stati Uniti, passo inserito in un più ampio ripensamento internazionale che in Europa ha portato a vietare l’uso dei grandi antropomorfi nella sperimentazione. Queste decisioni non derivano da una retorica emotiva o pseudofilosofica, ma dal riconoscimento — costruito anche grazie agli studi sugli scimpanzè di Gombe — di capacità cognitive e sociali che pongono obblighi morali specifici. La scienza, qui, non decide i valori, ma fornisce fatti che costringono a rivedere le nostre scelte collettive.
Ecco, quindi, l’eredità a mio giudizio più significativa del lavoro e della vita di Jane Goodall: l’“eccezionalismo umano” non esce demolito, esce rifinito. Rimangono differenze sostanziali — soprattutto nell’ampiezza e nella cumulatività della nostra cultura simbolica — ma esse non hanno più il sapore di un salto ontologico. La fabbricazione di strumenti, la cooperazione in caccia, la violenza organizzata, l’empatia, la tradizione: tutti questi tratti, che usavamo per definire la nostra “natura”, si dispongono ora su scale condivise, con convergenze e divergenze misurabili. In questo spostamento di prospettiva sta il significato epocale delle scoperte di Jane Goodall: come già Darwin prima di lei, ci ha tolto dal piedistallo per restituirci, più responsabilmente, al mondo vivente.

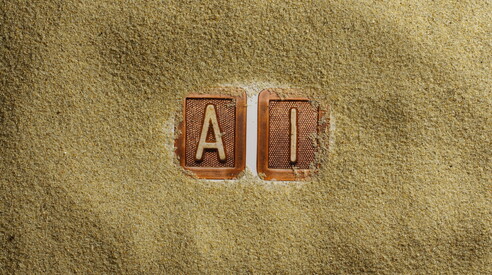
cattivi scienziati
L'AI è destinata a restare. Ma il nodo dei costi può incidere sui rendimenti

In principio, il pollice



