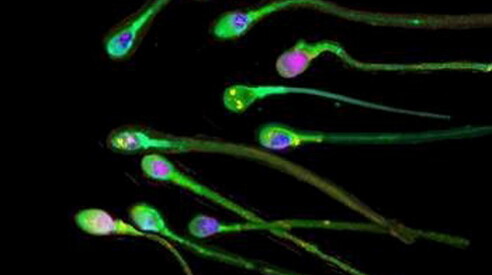LaPresse
Cattivi scienziati
L'associazione paracetamolo-autismo e il problema della politicizzazione della prova
Le affermazioni di Trump, Kennedy Jr. e il dottor Oz funzionano perché incastrano paure primarie in una trama narrativa semplice. La soluzione non è nella scienza stessa, ma nella buona politica e nella difesa dei baluardi che permettono a una liberal-democrazia di restare in piedi
La mossa di collegare il paracetamolo all’autismo – mossa portata dal trio politico-mediatico Trump-Kennedy-Oz – funziona perché incastra paure primarie in una trama narrativa semplice: “Ci hanno mentito su un farmaco usatissimo, e ora noi diremo la verità e difenderemo i bambini”. È una narrazione di lotta morale che non necessita di prove solide: basta un’associazione osservazionale metodologicamente claudicante presentata come “prova” per ribaltare l’onere della dimostrazione e mettere sulla difensiva chi invita a guardare all’enorme mole di dati che dice il contrario. In queste ore, infatti, testate e società scientifiche hanno ricordato che non esistono dati nuovi capaci di trasformare correlazioni in causalità, mentre l’American College of Obstetricians and Gynecologists e la Society for Maternal-Fetal Medicine ribadiscono che l’acetaminofene, usato correttamente, resta l’opzione raccomandata in gravidanza; perfino l’EMA ha confermato la sicurezza d’uso secondo linee guida correnti. La notizia “forte” è politica, non scientifica, e sfrutta la dissonanza tra comunicati governativi e consenso clinico per erodere la fiducia nelle istituzioni della scienza.
Dal punto di vista dei lavori citati dai ciarlatani come fonte di “prova ormai certa”, il cuore del problema sono i fattori confondenti. Molti studi che segnalano associazioni tra uso in gravidanza e disturbi del neurosviluppo sono osservazionali e sensibili al “confounding by indication”: si assume acetaminofene perché c’è febbre, dolore, infezione, condizioni che di per sé possono alterare il rischio di autismo o ADHD. Quando si adottano disegni più robusti, come le analisi tra fratelli all’interno della stessa famiglia, l’associazione scompare, segno che fattori genetici e ambientali condivisi spiegano gran parte del segnale. Una coorte svedese di quasi 2,5 milioni di individui pubblicata su JAMA nel 2024 ha mostrato esattamente questo, mentre lavori prospettici sul ruolo della febbre in gravidanza indicano un aumento del rischio indipendentemente dal farmaco, rafforzando l’ipotesi che la malattia materna, più che il trattamento, sia il driver del segnale. Per questo le società cliniche continuano a raccomandare di trattare febbre e dolore in gravidanza: i rischi di una sindrome febbrile non trattata sono concreti, quelli causali dell’acetaminofene sull’autismo no.
Perché allora dichiarare “abbiamo le prove” rende e continuerà a rendere? Perché attiva un set di bias cognitivi potentissimo. Il bias dell’intenzionalità cerca sempre un agente colpevole per un danno percepito: un farmaco quotidiano è un bersaglio psicologicamente più soddisfacente di un mosaico di fattori genetici e ambientali difficili da controllare. Il bias di disponibilità mentale rende credibili gli aneddoti vividi (“ho preso Tylenol, poi ho notato…”) più dei numeri astratti; il bias di proporzionalità pretende cause “forti” per effetti “grandi”; il bias di conferma offre alla platea già diffidente verso vaccini e sanità pubblica una nuova tessera del presunto complotto. Sopra questi, agiscono la “zero-risk bias” e l’avversione all’ambiguità: in gravidanza si predilige la scelta che appare “più pura”, anche quando il rischio reale sta nel non trattare febbre e dolore. E quando un’autorità politica conferma quelle paure, scatta l’“authority bias” identitario: non conta la forza delle prove, conta la fedeltà al gruppo. La dinamica si amplifica con l’“illusory truth effect”: ripetere un messaggio semplice (“Tylenol = autismo”) ne aumenta la plausibilità percepita, specie se rilanciato da canali governativi e media amici.
C’è poi la strategia politica. Primo, mobilitazione: “proteggiamo i bambini” è il più potente richiamo all’azione, capace di trasformare la scienza in interessato cinismo tecnocratico. Secondo, delegittimazione: se l’FDA, l’ACOG o i ricercatori sono un freno ed un nemico in quanto capaci di critiche ben piazzate nei confronti del potere politico, si dipinge la scienza come una burocrazia connivente che “nega l’evidenza” per proteggere interessi industriali. Qualunque richiesta di rigore metodologico diventa quindi solo un temporeggiamento o un tentativo di negare i “fatti” di cui tutti sono convinti. Terzo, spostamento dell’agenda: invece di investire sulla rete dei servizi per i disturbi dello spettro autistico, si promette un colpevole e un rimedio rapido, perfino rilanciando farmaci “salvifici” con basi ancora deboli per usi neuropsichiatrici complessi. È esattamente ciò che vediamo: a fronte di un’attenzione politica spasmodica su un presunto nesso causale smentito dai disegni sperimentali più robusti, mentre la comunità clinica ribadisce, con documenti e pagine pubbliche, che il paracetamolo, se indicato e a dosi corrette, rimane la scelta più sicura, si annuncia il miracolo del leucovorin, presentato come svolta. Il leucovorin è in realtà un rimedio mirato in specifici fenotipi di carenza di folati, con evidenze ancora limitate e che certo non “cura l’autismo”; però, guarda caso, uno dei componenti del trio – il dr. Oz – vende con le sue aziende più rimedi a base di questa sostanza.
È così che funziona, dunque: si prende un tema dove la letteratura osservazionale è eterogenea e controversa, si ignora il fatto che gli studi con controllo familiare e i dati sulla febbre materna smontano la causalità diretta, si passa sopra ai comunicati convergenti di ACOG, SMFM ed EMA, e si annuncia una verità definitiva che giustifica interventi immediati. Così si raccoglie consenso, si divide l’opinione pubblica e si incrina l’autorità delle istituzioni scientifiche; il costo lo pagano le pazienti, esposte a messaggi che le spingono a non trattare condizioni che, in gravidanza, vanno trattate. La scienza qui non ha un problema di “mancanza di prove”, ha un problema di politicizzazione della prova; contro questo, la soluzione non è nella scienza stessa, ma nella buona politica e nella difesa dei baluardi che permettono ad una liberal-democrazia di restare in piedi. Sempre che a questo vi siano cittadini interessati in numero sufficiente, cosa che non è affatto certa.