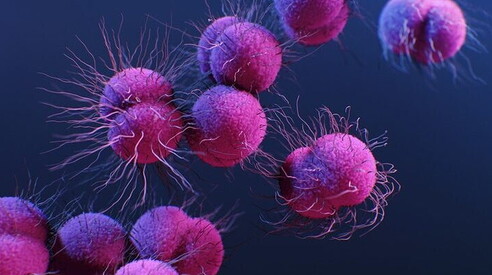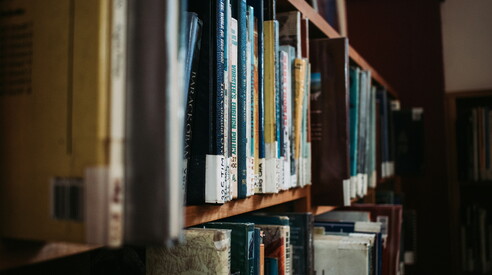
Foto di Muaawiyah Dadabhay su Unsplash
Una crisi silenziosa
Il business della ricerca e il fenomeno dei “paper mills”
La scienza si piega alla dittatura delle pubblicazioni, e c’è chi ci fa i soldi. Indagine su un modello fallimentare
C’è una crisi silenziosa nel mondo della scienza. Non si tratta di un virus, né di un conflitto fra teorie accademiche: il nemico, oggi, sono le pubblicazioni stesse. Si chiama “paper mill” – cartiera in italiano – e identifica un fenomeno inquietante e in continua crescita: la produzione seriale e su commissione di articoli scientifici falsi, privi di fondamento, non verificati e costruiti ad arte al solo scopo di alimentare carriere, ottenere finanziamenti, o semplicemente “gonfiare” curriculum accademici. Un’inchiesta del New York Times è tornata recentemente a investigare su un mondo opaco e sommerso, ma il problema è antico, diffuso, e purtroppo destinato ad aggravarsi.
Le prime segnalazioni sistematiche del fenomeno dei paper mills riguardano la Cina, considerata da molti analisti il vero epicentro della proliferazione di questi meccanismi fraudolenti. In particolare, è stato documentato come alcuni ospedali universitari e istituti di ricerca cinesi abbiano utilizzato per anni servizi di scrittura scientifica a pagamento per garantire ai propri medici e ricercatori pubblicazioni su riviste indicizzate, spesso requisito fondamentale per avanzamenti di carriera o promozioni. Il modello si è poi perfezionato in un vero mercato parallelo, capace di produrre articoli su misura, completi di dati fittizi, immagini manipolate e citazioni costruite ad arte.
A rendere ancora più complesso il fenomeno è l’elevata incidenza delle autocitazioni interne al sistema accademico cinese: secondo alcune analisi, oltre il 60 per cento delle citazioni a lavori pubblicati in Cina proviene da ricercatori cinesi stessi. Un dato che contribuisce ad alterare la reale influenza scientifica cinese, e suggerisce l’esistenza di pratiche strutturate come il citation stacking, ovvero citazioni reciproche pianificate per gonfiare l’impatto accademico. In questo contesto, la Cina ha fatto scuola, esportando un modello che oggi si replica – con variazioni – anche in altri paesi.
Dopo Cina e Stati Uniti, l’Italia si colloca al terzo posto a livello mondiale per il fenomeno del citation stacking. A questo tema è stato dedicato uno studio scientifico pubblicato su Plos One, che ha analizzato questa pratica tra i ricercatori italiani. E’ importante precisare che i numeri italiani sono significativamente inferiori rispetto a quelli cinesi. Tuttavia, considerando lo stato reale della ricerca in Italia – un paese con pochi laureati, pochi ricercatori e scarsi finanziamenti destinati al settore – colpisce l’elevato numero di pubblicazioni che ha portato l’Italia sul podio mondiale. Numeri che, tuttavia, possono suscitare qualche perplessità. A confermare questi dubbi al Foglio è Antonio Cassone, microbiologo ed ex direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità: “Sicuramente i ricercatori italiani sono molto produttivi, ma il fatto che il nostro paese abbia scalato a tal punto la classifica mondiale negli ultimi anni può lasciare qualche dubbio sulla validità scientifica di alcuni lavori”. Cassone, autore di un recente saggio sull’argomento, aggiunge: “Non stiamo più parlando di errori occasionali o di scarsa qualità nella ricerca. Siamo di fronte a un sistema parallelo, un mercato organizzato, che sfrutta la necessità di pubblicare per fare carriera”.
Secondo Cassone, il motore di questo fenomeno è la pressione insostenibile che grava sui ricercatori. In ambito accademico pubblicare è una necessità, indipendentemente dal contenuto – l’unica cosa che conta davvero è che il nome dell’autore compaia nero su bianco su una rivista, possibilmente internazionale. Cassone cita un dato emblematico che rende l’idea dell’enormità del fenomeno: nell’ultimo anno sono stati pubblicati nel mondo circa 2,5 milioni di articoli scientifici. Un numero che solleva una domanda cruciale: quanta di questa produzione rappresenta vera scienza, verificabile, rigorosa e utile al progresso? E’ una questione che non possiamo più ignorare, perché la proporzione di lavori di scarsa qualità o del tutto fittizi sta crescendo esponenzialmente.
Anche Giuseppe Novelli, genetista e già rettore dell’Università di Tor Vergata a Roma, denuncia il fenomeno: “Non stiamo parlando semplicemente di articoli scritti male. Il nodo della questione è che molti di questi studi sono generati, o pesantemente manipolati, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”. Novelli dice al Foglio che l’Ia, sebbene offra strumenti potenti per la ricerca, può rappresentare un rischio se viene impiegata senza un controllo critico adeguato. L’Ia può contribuire alla diffusione di informazioni errate, costruire frasi senza senso, generare citazioni sbagliate o inadeguate. Un esempio frequente: leggere frasi che citano articoli come “recentemente pubblicati”, per scoprire poi che gli studi in questione risalgono a sei o addirittura sette anni prima. Per Novelli “è un tipico errore dell’intelligenza artificiale: non ha senso critico, non comprende il contesto temporale, e in molti casi ha accesso solo agli abstract di alcune ricerche, spesso consultabili soltanto tramite abbonamento a pagamento”.
Ma il problema non si esaurisce con l’uso improprio dell’Ia. Novelli sottolinea anche il crollo della qualità della peer review, il processo di revisione tra pari che dovrebbe garantire l’affidabilità degli articoli scientifici. Troppe riviste, troppi articoli da valutare, e un numero insufficiente di revisori competenti disponibili a prendersi il tempo necessario. Il risultato è che studi inconsistenti, e persino fraudolenti, riescono a superare il vaglio editoriale e a essere pubblicati su riviste con questo modello di business. Non è raro che per pubblicare un articolo si debbano pagare somme comprese tra i 3 e i 4 mila euro, mentre alcuni “servizi editoriali”, che promettono la pubblicazione chiavi in mano, offrono pacchetti completi che possono arrivare anche a 30 mila euro. Un mercato milionario, che più che promuovere il rigore scientifico mira al profitto.
Alla base di questa impennata di pubblicazioni sospette c’è un sistema di incentivi profondamente distorto. A sostenerlo è anche Giuseppe Traversa, epidemiologo ed ex ricercatore dell’Istituto superiore di Sanità. Traversa spiega al Foglio che oggi, nella ricerca, il merito viene valutato soprattutto in base al numero di articoli pubblicati e alle citazioni ricevute. Questo sistema premia chiaramente la quantità e non la qualità. Se per vincere un concorso o ottenere un finanziamento bastano 100 pubblicazioni – anche di modesta validità – la tentazione di “gonfiare” il proprio profilo diventa fortissima. Le conseguenze sono pesanti e molteplici. In primo luogo, i fondi pubblici – già scarsi – rischiano di essere dirottati verso progetti di scarso valore, sottraendoli a chi davvero conduce ricerche di qualità. Ma il danno più profondo consiste nella perdita di fiducia. Quando anche chi osserva la scienza dall’esterno inizia a sospettare che dietro certe pubblicazioni ci sia il vuoto – o peggio, la frode deliberata – l’intero sistema vacilla. L’abbiamo visto chiaramente durante la pandemia, quando fake news e studi non verificati hanno contribuito a seminare confusione e sfiducia.
Secondo Cassone, per ristabilire un principio di credibilità, serve una rivoluzione culturale: dobbiamo tornare a premiare la qualità della ricerca, non la quantità delle pubblicazioni. Non si può più giudicare un ricercatore solo in base alla rivista su cui pubblica, ma è necessario leggere davvero quello che scrive, capirne i contenuti e valutarne l’effettivo contributo. Anche Novelli insiste su controlli più rigorosi: serve un pre-check editoriale efficace, ma anche una maggiore multidisciplinarietà nelle revisioni. Traversa, infine, evidenzia l’urgenza di riformare il sistema degli incentivi: dobbiamo valutare il valore reale della ricerca, non i numeri astratti delle pubblicazioni.
I tre esperti concordano sul fatto che per ora il sistema italiano è meno esposto rispetto ad altri paesi, dove la carriera accademica è strettamente legata alla performance editoriale. Ma questo non significa che siamo immuni. Errori grossolani, superficialità, citazioni strumentali e manipolazioni sottili sono già presenti nel panorama scientifico italiano. E la facilità con cui oggi è possibile acquistare uno studio pronto per essere pubblicato dovrebbe essere un allarme per istituzioni e comunità accademiche.
La scienza è per sua stessa natura un processo autocorrettivo, e nel tempo le frodi tendono a venire a galla. Ecco perché il controllo deve essere preventivo, non solo successivo: serve più vigilanza, maggiore rigore, e trasparenza in ogni fase del percorso di pubblicazione. In fondo, conclude Cassone, “questa storia è cominciata con un piccolo granello”. Ma se non prestiamo la dovuta attenzione, quel granello rischia di diventare una valanga in grado di travolgere tutto, anche la fiducia che abbiamo riposto per secoli nel potere della ragione.

cattivi scienziati
Tanti livelli intrecciati. La selezione naturale non è un processo lineare

cattivi scienziati
Xylella, un complotto lungo dieci anni finisce nel nulla